La Dea prima di Dio
22/05/2011, 10:57
Penso che molti conoscano già le teorie riguardo l’esistenza di un culto preistorico di una Grande Dea Madre che avrebbe dominato incontrastato l’area del Mediterraneo, dell’Europa e del Medio Oriente fino all’Indo, prima dell’inizio delle civiltà storiche, fin dalla lontana epoca dei primi Cro-Magnon giunti in Europa Occidentale circa 35.000 anni fa.
Tale culto sarebbe stato alla base di società preistoriche, fino al neolitico, fondate su modelli di tipo matriarcale, e sarebbe proseguito anche all’interno delle società patriarcali successive, sotto forma dei vari culti delle Dee Madri come per esempio Iside, Ishtar, Astarte, Afrodite, Demetra, Diana, Kalì e via dicendo.
Si tratta di teorie, che ancora devono essere dimostrate e che trovano non pochi detrattori.
Quando si parla di culture preistoriche, cioè anteriori all’esistenza di documenti scritti, esistono solo due fonti che ci possono dire qualcosa: i reperti archeologici, le tradizioni orali e i costumi popolari più antichi.
Ed è indubitabile che, anche se non dimostrano chiaramente tale tesi, tutte queste fonti in Europa e oltre mostrano chiari indizi sulla natura di questo antichissimo culto.
E oltre a questo, io personalmente porto un’altra argomentazione, che potremmo chiamare antropologica e filosofica.
Qual è la prima persona che ogni essere umano conosce nella sua vita? La madre, ovviamente. Con chi ha il primo rapporto, ancora prima di nascere? Con la madre, ovviamente. Qual è il primo rapporto umano in assoluto? Il rapporto fra madre e figlio, ovviamente.
Quindi, quando l’uomo guarda al divino, cioè all’Origine e al senso di tutte le cose, qual è la prima immagine a cui il divino stesso viene associato, istintivamente e quasi invincibilmente? Quella della madre, ovviamente.
Da un punto di vista astratto, si dice normalmente che Dio è senza sesso, senza forma e senza immagine. Praticamente uguale al vuoto assoluto. Almeno, questo è il risultato che ci porta una concezione puramente illuministica, intellettuale di Dio. Qualcosa di lontano ed astratto che alla fine serve solo come sfondo a un mondo che ha bisogno di essere concepito come ordinato razionalmente.
Ma di fatto, l’uomo della strada, non avendo bisogno di un Dio astratto, ha sempre seguito divinità dotate di precise immagini, anche se variabili e spesso contraddittorie. E di fatto, dobbiamo ammettere che l’umanità si è sempre sentita più vicina alle immagini della Dea Madre, piuttosto che a quelle del Dio Padre, che ha finito nella maggior parte dei casi per apparire lontano e distaccato dal mondo.
È quindi facile immaginare, anche se non è di per sé una prova, che le prime manifestazioni religiose dell’umanità siano state votate al culto di una Dea Madre, e che tale figura sia ancora attuale e diffusa, come di fatto è.
Per cominciare il nostro excursus fra le religioni antiche e moderne, cominciamo dalla prima fonte della classicità antica: l’antica Grecia.
Esisteva in Grecia un mito più arcaico degli altri più noti miti degli Dei dell’Olimpo, riferito da Esiodo nella sua raccolta di miti ellenici: “Le Opere e i Giorni”.
Tale mito proveniva dagli antichi Pelasgi, le antiche popolazioni pre-elleniche e pre-indoeuropee che vivevano in Grecia prima dell’arrivo delle orde indoeuropee nel 2000 a. C., popolazioni presumibilmente imparentate con altre popolazioni pre-indoeuropee come i Berberi del Nord Africa, o i Baschi dei Pirenei o gli Etruschi italici, e perciò provenienti da un’antica preistoria che conosciamo solo tramite i reperti archeologici, forse legata alle antiche popolazioni Cro-Magnon europee.
Secondo tale mito, in origine esisteva solo l’Abisso di acque fredde e buie, come in tanti altri miti cosmogonici, e in esso viveva una divinità originaria: Eurinome, cioè “Colei che vaga per ampi spazi”.
Poiché tutto era freddo e buio, Eurinome si mette a danzare per scacciare il freddo, e il vento del Nord la vede e la concupisce. Eurinome afferra il vento e lo trasforma in un serpente, Ofione, che si avvolge attorno a lei e la mette incinta.
Eurinome partorisce un uovo cosmogonico, poi riprende a danzare mentre Ofione, con le spire avvolte attorno al guscio, lo cova in attesa della sua schiusa.
Quando il guscio si rompe, le due metà del guscio si separano e la metà del superiore diventa il cielo, mentre la metà inferiore diventa la terra.
Eurinome ed Ofione diventano i Signori dell’Universo, ma Ofione pretende di essere l’unico padrone e di avere tutto il merito della Creazione, e perciò Eurinome lo getta giù dal cielo e lo relega nel mondo sotterraneo, dove rimarrà per sempre. Eurinome quindi organizza il dominio dell’universo per conto suo, e affida i sette cieli a sette Titani e sette Titanesse, mentre il primo uomo viene creato nella terra di Arcadia.
I Titani difatti erano presumibilmente le divinità dei Pelasgi che, una volta sconfitti e invasi dai primi Greci, videro le loro divinità venire relegate in secondo piano ed esiliate negli Inferi, sostituite da Zeus e le altre divinità classiche, che però conservavano tratti dell’antica religione.
Si noti che nel mito pelasgico la divinità principale è una Dea e non un Dio, Madre dell’Universo, che precipita giù dal cielo il Grande Serpente Ofione, esattamente come il Dio ebraico-cristiano scaraventa giù dal cielo sulla Terra e negli Inferi l’angelo ribelle Lucifero, che viene chiamato anche il Serpente Antico. Proprio come se a un certo punto la Dea Madre fosse stata sostituita da un Dio Padre, che originariamente era lo stesso Ofione, dato che nel mito lui era il Padre dell’Universo, e inoltre il serpente per gli antichi era un simbolo fallico e fluviale, simbolo di fecondità maschile.
Ma il Dio Padre delle religioni bibliche non è un Dio della fecondità, bensì un Dio astratto, la cui paternità è solo una relazione astratta. Il Dio Padre biblico è padre nello stesso senso in cui può esserlo un padre adottivo, o un artista nei confronti della sua opera. Nel Dio Padre del Cristianesimo la maternità è scomparsa, in quanto troppo “carnale”, e la paternità, tolto ogni riferimento sessuale, è ridotta a pura astrazione.
Ma in Grecia il culto della Dea Madre non scomparve. Certo, ora era Zeus il Re degli Dei, ma doveva vedersela con i culti misterici, che avevano molti seguaci.
Il prestigio del culto dei Misteri Eleusini nell’antica Grecia e nel mondo antico era molto diffuso, e scomparve solo quando il Cristianesimo la ebbe vinta, molti anni dopo l’Editto di Costantino nel 313 d.C.
I Misteri Eleusini si fondavano appunto sul culto di una Dea Madre, Demetra, e di Sua Figlia, Persefone, o anche Core (nome che significa “fanciulla”).
Poiché si trattava di culti misterici, ovviamente non ne conosciamo i particolari, dato che venivano rivelati solo ai suoi seguaci, e non potevano essere trasmessi per iscritto, però possiamo ricostruirne le linee guida attraverso le testimonianze storiche che parlano dei suoi aspetti pubblici.
Tale culto aveva il suo centro in un ipogeo presso la città ellenica di Eleusi, e tale culto durò circa mille anni.
Come forse saprete, su Demetra e sua figlia Persefone era diffuso un mito in Grecia, che mostrava come le due Dee fossero state essenzialmente delle divinità “ctonie”, cioè sotterranee, legate alla Terra e agli Inferi, in contrapposizione alle divinità celesti come Zeus.
Il nome di Demetra pare derivi dalla composizione delle parole “da” e “mater”, cioè “madre terra”. Ella infatti era la Dea delle Messi e quindi della Terra.
Pare che il suo culto sia proseguito fino quasi ai nostri giorni presso i contadini e i pastori delle isole dell’Egeo, a dimostrazione di quanto siano più legati agli antichi culti pagani i contadini, soprattutto nelle comunità più isolate.
Demetra aveva avuto una figlia dal fratello Zeus, di nome Persefone. Quando ancora era una fanciulla, Persefone fu rapita da Ade, fratello di Zeus e Demetra e Dio dell’Oltretomba, posto negli Inferi. Per questo l’aldilà veniva chiamato dai Greci con il nome del suo stesso Dio: Ade.
Per il dolore e la rabbia, Demetra si ritira dal mondo e la vita delle piante e degli animali cessa: gli alberi perdono le foglie e le messi non danno più frutto, la vita della Terra, senza il suo spirito vitale, rischia di estinguersi.
Per evitare la catastrofe universale, Zeus alla fine decide una situazione di compromesso fra i suoi due fratelli: Persefone alloggerà negli Inferi come sposa di Ade per metà dell’anno, mentre per l’altra metà tornerà con la madre sulla superficie della Terra.
A causa di questo fatto, nacquero le stagioni. Mentre durante l’autunno e l’inverno Persefone dimora nell’Ade con il suo sposo, di primavera e d’estate torna invece con la madre Demetra, e la Natura rifiorisce.
Questo mito, che noi moderni consideriamo solo una bella favola, ha invece un preciso significato simbolico, come ce l’hanno tutti i miti.
La dottrina dei Misteri Eleusini era infatti una dottrina salvifica fondata sul culto delle Due Dee come garanti della beatitudine nell’aldilà. Chi era devoto al culto delle Dee, riceveva in ricompensa dopo la morte l’eterno soggiorno in un paradiso sotterraneo, i Campi Elisi o l’Elisio, mentre chi non era stato seguace di Demetra e Persefone avrebbe avuto una grigia e spenta esistenza nell’Ade, come una sorta di vuoto fantasma.
È probabile che molti delle classi meno abbienti avessero abbracciato i Misteri Eleusini, in quanto prometteva una vita beata nell’aldilà, in contrapposizione alla vita di miserie che subivano in questo mondo, e anche dato che il culto di Zeus e degli altri Dei olimpici non parlava affatto di ricompense nell’aldilà.
Non deve stupire l’idea di un paradiso sotterraneo, in quanto per molti popoli antichi era un concetto molto comune. Mentre altri popoli, come gli Egiziani, i Cinesi e certi popoli precolombiani, immaginavano che la sede dei defunti fosse in cielo, ce ne erano altri che credevano che tale sede fosse nel sottosuolo, in base a dove si trovavano gli Dei maggiori adorati dal popolo stesso.
Se un popolo adora il Sole e la volta celeste, sarà portato a pensare la sede dei defunti in cielo, mentre se un popolo adora la Terra, ovviamente lo concepirà nel sottosuolo, come nel caso del culto di Demetra e Persefone.
In realtà, Demetra e Persefone sono due diversi aspetti della Dea Terra e dei suoi processi vitali.
Tutta la vita nasce dalla Terra, e ad essa ritorna. Gli uomini stessi alla fine vengono riaccolti nuovamente nel grembo della Terra dopo morti, ma la Terra genera sempre vita, così che la morte è sempre seguita dalla vita.
In origine, non doveva essere Ade il Dio degli Inferi, bensì Persefone, in quanto anche in altre tradizioni la divinità dell’oltretomba non è un Dio, ma una Dea, come la mesopotamica Ereshkigal o la nordica Hela. E la cosa non deve lasciare perplessità, proprio perché è la Madre Terra la sede ultima dei defunti, perlomeno se essi vengono inumati.
Così, come la Terra promette di riportare in vita le piante e le messi in primavera dopo l’inverno, Demetra e Persefone promettono di restituire la vita ai loro adoratori, concedendogli un soggiorno eterno e beato nei Campi Elisi, nell’eterna primavera.
L’immagine di Persefone che riemerge dall’Ade e riporta la primavera sulla Terra è il simbolo della vita eternamente rinnovantesi sia in questa vita che nell’aldilà, così come Demetra è il simbolo della forza vitale della Terra sulla sua superficie, che origina ogni vita.
In pratica, mentre Demetra è l’immagine della Dea Madre in questa vita, Persefone è l’immagine della stessa Dea nell’aldilà, due immagine unite da un’unica forza vitale.
I Misteri Eleusini dimostrano quanta forza ha il culto della Dea Madre, e il suo valore salvifico che ricorda in certi aspetti il messianismo cristiano e la fede nella vita eterna, anche se in un contesto molto diverso.
Finisco qui il primo brano della mia trattazione sulla storia della Dea Madre nel mondo occidentale, in quanto si tratta di un lavoro molto lungo, che richiederà molti messaggi scritti.
Tale culto sarebbe stato alla base di società preistoriche, fino al neolitico, fondate su modelli di tipo matriarcale, e sarebbe proseguito anche all’interno delle società patriarcali successive, sotto forma dei vari culti delle Dee Madri come per esempio Iside, Ishtar, Astarte, Afrodite, Demetra, Diana, Kalì e via dicendo.
Si tratta di teorie, che ancora devono essere dimostrate e che trovano non pochi detrattori.
Quando si parla di culture preistoriche, cioè anteriori all’esistenza di documenti scritti, esistono solo due fonti che ci possono dire qualcosa: i reperti archeologici, le tradizioni orali e i costumi popolari più antichi.
Ed è indubitabile che, anche se non dimostrano chiaramente tale tesi, tutte queste fonti in Europa e oltre mostrano chiari indizi sulla natura di questo antichissimo culto.
E oltre a questo, io personalmente porto un’altra argomentazione, che potremmo chiamare antropologica e filosofica.
Qual è la prima persona che ogni essere umano conosce nella sua vita? La madre, ovviamente. Con chi ha il primo rapporto, ancora prima di nascere? Con la madre, ovviamente. Qual è il primo rapporto umano in assoluto? Il rapporto fra madre e figlio, ovviamente.
Quindi, quando l’uomo guarda al divino, cioè all’Origine e al senso di tutte le cose, qual è la prima immagine a cui il divino stesso viene associato, istintivamente e quasi invincibilmente? Quella della madre, ovviamente.
Da un punto di vista astratto, si dice normalmente che Dio è senza sesso, senza forma e senza immagine. Praticamente uguale al vuoto assoluto. Almeno, questo è il risultato che ci porta una concezione puramente illuministica, intellettuale di Dio. Qualcosa di lontano ed astratto che alla fine serve solo come sfondo a un mondo che ha bisogno di essere concepito come ordinato razionalmente.
Ma di fatto, l’uomo della strada, non avendo bisogno di un Dio astratto, ha sempre seguito divinità dotate di precise immagini, anche se variabili e spesso contraddittorie. E di fatto, dobbiamo ammettere che l’umanità si è sempre sentita più vicina alle immagini della Dea Madre, piuttosto che a quelle del Dio Padre, che ha finito nella maggior parte dei casi per apparire lontano e distaccato dal mondo.
È quindi facile immaginare, anche se non è di per sé una prova, che le prime manifestazioni religiose dell’umanità siano state votate al culto di una Dea Madre, e che tale figura sia ancora attuale e diffusa, come di fatto è.
Per cominciare il nostro excursus fra le religioni antiche e moderne, cominciamo dalla prima fonte della classicità antica: l’antica Grecia.
Esisteva in Grecia un mito più arcaico degli altri più noti miti degli Dei dell’Olimpo, riferito da Esiodo nella sua raccolta di miti ellenici: “Le Opere e i Giorni”.
Tale mito proveniva dagli antichi Pelasgi, le antiche popolazioni pre-elleniche e pre-indoeuropee che vivevano in Grecia prima dell’arrivo delle orde indoeuropee nel 2000 a. C., popolazioni presumibilmente imparentate con altre popolazioni pre-indoeuropee come i Berberi del Nord Africa, o i Baschi dei Pirenei o gli Etruschi italici, e perciò provenienti da un’antica preistoria che conosciamo solo tramite i reperti archeologici, forse legata alle antiche popolazioni Cro-Magnon europee.
Secondo tale mito, in origine esisteva solo l’Abisso di acque fredde e buie, come in tanti altri miti cosmogonici, e in esso viveva una divinità originaria: Eurinome, cioè “Colei che vaga per ampi spazi”.
Poiché tutto era freddo e buio, Eurinome si mette a danzare per scacciare il freddo, e il vento del Nord la vede e la concupisce. Eurinome afferra il vento e lo trasforma in un serpente, Ofione, che si avvolge attorno a lei e la mette incinta.
Eurinome partorisce un uovo cosmogonico, poi riprende a danzare mentre Ofione, con le spire avvolte attorno al guscio, lo cova in attesa della sua schiusa.
Quando il guscio si rompe, le due metà del guscio si separano e la metà del superiore diventa il cielo, mentre la metà inferiore diventa la terra.
Eurinome ed Ofione diventano i Signori dell’Universo, ma Ofione pretende di essere l’unico padrone e di avere tutto il merito della Creazione, e perciò Eurinome lo getta giù dal cielo e lo relega nel mondo sotterraneo, dove rimarrà per sempre. Eurinome quindi organizza il dominio dell’universo per conto suo, e affida i sette cieli a sette Titani e sette Titanesse, mentre il primo uomo viene creato nella terra di Arcadia.
I Titani difatti erano presumibilmente le divinità dei Pelasgi che, una volta sconfitti e invasi dai primi Greci, videro le loro divinità venire relegate in secondo piano ed esiliate negli Inferi, sostituite da Zeus e le altre divinità classiche, che però conservavano tratti dell’antica religione.
Si noti che nel mito pelasgico la divinità principale è una Dea e non un Dio, Madre dell’Universo, che precipita giù dal cielo il Grande Serpente Ofione, esattamente come il Dio ebraico-cristiano scaraventa giù dal cielo sulla Terra e negli Inferi l’angelo ribelle Lucifero, che viene chiamato anche il Serpente Antico. Proprio come se a un certo punto la Dea Madre fosse stata sostituita da un Dio Padre, che originariamente era lo stesso Ofione, dato che nel mito lui era il Padre dell’Universo, e inoltre il serpente per gli antichi era un simbolo fallico e fluviale, simbolo di fecondità maschile.
Ma il Dio Padre delle religioni bibliche non è un Dio della fecondità, bensì un Dio astratto, la cui paternità è solo una relazione astratta. Il Dio Padre biblico è padre nello stesso senso in cui può esserlo un padre adottivo, o un artista nei confronti della sua opera. Nel Dio Padre del Cristianesimo la maternità è scomparsa, in quanto troppo “carnale”, e la paternità, tolto ogni riferimento sessuale, è ridotta a pura astrazione.
Ma in Grecia il culto della Dea Madre non scomparve. Certo, ora era Zeus il Re degli Dei, ma doveva vedersela con i culti misterici, che avevano molti seguaci.
Il prestigio del culto dei Misteri Eleusini nell’antica Grecia e nel mondo antico era molto diffuso, e scomparve solo quando il Cristianesimo la ebbe vinta, molti anni dopo l’Editto di Costantino nel 313 d.C.
I Misteri Eleusini si fondavano appunto sul culto di una Dea Madre, Demetra, e di Sua Figlia, Persefone, o anche Core (nome che significa “fanciulla”).
Poiché si trattava di culti misterici, ovviamente non ne conosciamo i particolari, dato che venivano rivelati solo ai suoi seguaci, e non potevano essere trasmessi per iscritto, però possiamo ricostruirne le linee guida attraverso le testimonianze storiche che parlano dei suoi aspetti pubblici.
Tale culto aveva il suo centro in un ipogeo presso la città ellenica di Eleusi, e tale culto durò circa mille anni.
Come forse saprete, su Demetra e sua figlia Persefone era diffuso un mito in Grecia, che mostrava come le due Dee fossero state essenzialmente delle divinità “ctonie”, cioè sotterranee, legate alla Terra e agli Inferi, in contrapposizione alle divinità celesti come Zeus.
Il nome di Demetra pare derivi dalla composizione delle parole “da” e “mater”, cioè “madre terra”. Ella infatti era la Dea delle Messi e quindi della Terra.
Pare che il suo culto sia proseguito fino quasi ai nostri giorni presso i contadini e i pastori delle isole dell’Egeo, a dimostrazione di quanto siano più legati agli antichi culti pagani i contadini, soprattutto nelle comunità più isolate.
Demetra aveva avuto una figlia dal fratello Zeus, di nome Persefone. Quando ancora era una fanciulla, Persefone fu rapita da Ade, fratello di Zeus e Demetra e Dio dell’Oltretomba, posto negli Inferi. Per questo l’aldilà veniva chiamato dai Greci con il nome del suo stesso Dio: Ade.
Per il dolore e la rabbia, Demetra si ritira dal mondo e la vita delle piante e degli animali cessa: gli alberi perdono le foglie e le messi non danno più frutto, la vita della Terra, senza il suo spirito vitale, rischia di estinguersi.
Per evitare la catastrofe universale, Zeus alla fine decide una situazione di compromesso fra i suoi due fratelli: Persefone alloggerà negli Inferi come sposa di Ade per metà dell’anno, mentre per l’altra metà tornerà con la madre sulla superficie della Terra.
A causa di questo fatto, nacquero le stagioni. Mentre durante l’autunno e l’inverno Persefone dimora nell’Ade con il suo sposo, di primavera e d’estate torna invece con la madre Demetra, e la Natura rifiorisce.
Questo mito, che noi moderni consideriamo solo una bella favola, ha invece un preciso significato simbolico, come ce l’hanno tutti i miti.
La dottrina dei Misteri Eleusini era infatti una dottrina salvifica fondata sul culto delle Due Dee come garanti della beatitudine nell’aldilà. Chi era devoto al culto delle Dee, riceveva in ricompensa dopo la morte l’eterno soggiorno in un paradiso sotterraneo, i Campi Elisi o l’Elisio, mentre chi non era stato seguace di Demetra e Persefone avrebbe avuto una grigia e spenta esistenza nell’Ade, come una sorta di vuoto fantasma.
È probabile che molti delle classi meno abbienti avessero abbracciato i Misteri Eleusini, in quanto prometteva una vita beata nell’aldilà, in contrapposizione alla vita di miserie che subivano in questo mondo, e anche dato che il culto di Zeus e degli altri Dei olimpici non parlava affatto di ricompense nell’aldilà.
Non deve stupire l’idea di un paradiso sotterraneo, in quanto per molti popoli antichi era un concetto molto comune. Mentre altri popoli, come gli Egiziani, i Cinesi e certi popoli precolombiani, immaginavano che la sede dei defunti fosse in cielo, ce ne erano altri che credevano che tale sede fosse nel sottosuolo, in base a dove si trovavano gli Dei maggiori adorati dal popolo stesso.
Se un popolo adora il Sole e la volta celeste, sarà portato a pensare la sede dei defunti in cielo, mentre se un popolo adora la Terra, ovviamente lo concepirà nel sottosuolo, come nel caso del culto di Demetra e Persefone.
In realtà, Demetra e Persefone sono due diversi aspetti della Dea Terra e dei suoi processi vitali.
Tutta la vita nasce dalla Terra, e ad essa ritorna. Gli uomini stessi alla fine vengono riaccolti nuovamente nel grembo della Terra dopo morti, ma la Terra genera sempre vita, così che la morte è sempre seguita dalla vita.
In origine, non doveva essere Ade il Dio degli Inferi, bensì Persefone, in quanto anche in altre tradizioni la divinità dell’oltretomba non è un Dio, ma una Dea, come la mesopotamica Ereshkigal o la nordica Hela. E la cosa non deve lasciare perplessità, proprio perché è la Madre Terra la sede ultima dei defunti, perlomeno se essi vengono inumati.
Così, come la Terra promette di riportare in vita le piante e le messi in primavera dopo l’inverno, Demetra e Persefone promettono di restituire la vita ai loro adoratori, concedendogli un soggiorno eterno e beato nei Campi Elisi, nell’eterna primavera.
L’immagine di Persefone che riemerge dall’Ade e riporta la primavera sulla Terra è il simbolo della vita eternamente rinnovantesi sia in questa vita che nell’aldilà, così come Demetra è il simbolo della forza vitale della Terra sulla sua superficie, che origina ogni vita.
In pratica, mentre Demetra è l’immagine della Dea Madre in questa vita, Persefone è l’immagine della stessa Dea nell’aldilà, due immagine unite da un’unica forza vitale.
I Misteri Eleusini dimostrano quanta forza ha il culto della Dea Madre, e il suo valore salvifico che ricorda in certi aspetti il messianismo cristiano e la fede nella vita eterna, anche se in un contesto molto diverso.
Finisco qui il primo brano della mia trattazione sulla storia della Dea Madre nel mondo occidentale, in quanto si tratta di un lavoro molto lungo, che richiederà molti messaggi scritti.
22/05/2011, 11:32
Grazie Enkidu, è tutto molto interessante.
Mentre tu prepari il resto, mi permetto un momento leggero. C'è una barzelletta molto carina. Chissà come sono andate veramente le cose. Poi ti farò alcune domande anche sul concetto attuale di Gesù sposo e Chiesa invisibile sposa.
MA DIO E’ DONNA???
Un giorno, nel giardino dell’Eden, Eva disse a Dio…
"Signore, ho un problema" …
"Che problema, Eva?"
"Signore, so che mi hai creata e che hai provveduto a questo giardino bellissimo, a tutti questi meravigliosi animali, e quell’allegro e buffo serpente… ma io non mi sento davvero felice."
"Come mai, Eva?" fu l’immediata replica dall’alto
"Signore, mi sento sola. E sono proprio stufa delle mele…"
"Bene Eva, in questo caso ho una soluzione. Creerò un uomo per te"
"Che cos’è un ‘uomo’, Signore?"
"Questo -uomo- sarà una creatura difettosa, con molti aspetti negativi.
Mentirà, ti prenderà in giro e sarà vanaglorioso, in pratica ti darà un sacco di problemi.
Sarà più grande di te e più veloce, e amerà cacciare e uccidere.
Avrà uno sguardo scioccamente curioso, ma visto che ti stai lamentando, lo creerò in modo che possa soddisfare le tue, ehm…., necessità fisiche.
Sarà scarso di intelletto e si impegnerà in occupazioni infantili come la lotta e prendere a calci una palla.
Non sarà molto sveglio, e avrà spesso bisogno dei tuoi consigli per pensare correttamente"
"Sembra una cosa divertente!" commento Eva ammiccando ironicamente. "Dove sta la fregatura?"
"Beh… lo puoi avere ad una condizione…"
"Quale?"
"Come ti ho detto, sarà orgoglioso, arrogante, autocompiacente… perciò dovrai fargli credere che è stato creato lui per primo… però ricorda… questo è il nostro grande segreto… da… donna a donna!"
Mentre tu prepari il resto, mi permetto un momento leggero. C'è una barzelletta molto carina. Chissà come sono andate veramente le cose. Poi ti farò alcune domande anche sul concetto attuale di Gesù sposo e Chiesa invisibile sposa.
MA DIO E’ DONNA???
Un giorno, nel giardino dell’Eden, Eva disse a Dio…
"Signore, ho un problema" …
"Che problema, Eva?"
"Signore, so che mi hai creata e che hai provveduto a questo giardino bellissimo, a tutti questi meravigliosi animali, e quell’allegro e buffo serpente… ma io non mi sento davvero felice."
"Come mai, Eva?" fu l’immediata replica dall’alto
"Signore, mi sento sola. E sono proprio stufa delle mele…"
"Bene Eva, in questo caso ho una soluzione. Creerò un uomo per te"
"Che cos’è un ‘uomo’, Signore?"
"Questo -uomo- sarà una creatura difettosa, con molti aspetti negativi.
Mentirà, ti prenderà in giro e sarà vanaglorioso, in pratica ti darà un sacco di problemi.
Sarà più grande di te e più veloce, e amerà cacciare e uccidere.
Avrà uno sguardo scioccamente curioso, ma visto che ti stai lamentando, lo creerò in modo che possa soddisfare le tue, ehm…., necessità fisiche.
Sarà scarso di intelletto e si impegnerà in occupazioni infantili come la lotta e prendere a calci una palla.
Non sarà molto sveglio, e avrà spesso bisogno dei tuoi consigli per pensare correttamente"
"Sembra una cosa divertente!" commento Eva ammiccando ironicamente. "Dove sta la fregatura?"
"Beh… lo puoi avere ad una condizione…"
"Quale?"
"Come ti ho detto, sarà orgoglioso, arrogante, autocompiacente… perciò dovrai fargli credere che è stato creato lui per primo… però ricorda… questo è il nostro grande segreto… da… donna a donna!"
22/05/2011, 12:57
La conosco già.... sono quelle barzellette che le femministe hanno creato per "vendicarsi" dei pregiudizi maschilisti trattando i maschi nello stesso modo in cui essi hanno trattato le donne.
Attenzione, però: il culto della Dea Madre, o della maternità divina, non deve essere confuso con una sorta di "sessismo al contrario", perché allora si esporrebbe alle stesse critiche a cui si espone il patriarcalismo biblico.
Te ne racconto io una, inventata dai pagani nei primi secoli del Cristianesimo per prendere in giro il monoteismo ebraico-cristiano.
Quando Jahwé si manifestò per la prima volta sul Sinai al popolo ebraico, si udì una voce tonante e maschile provenire dal cielo, che gridava: "Io sono l'unico Dio e non esistono altri Dei al di fuori di me!".
Ma subito dopo si udì una voce femminile provenire da un cielo più alto, e gridare: "Figliolo, non raccontar balle!"
Attenzione, però: il culto della Dea Madre, o della maternità divina, non deve essere confuso con una sorta di "sessismo al contrario", perché allora si esporrebbe alle stesse critiche a cui si espone il patriarcalismo biblico.
Te ne racconto io una, inventata dai pagani nei primi secoli del Cristianesimo per prendere in giro il monoteismo ebraico-cristiano.
Quando Jahwé si manifestò per la prima volta sul Sinai al popolo ebraico, si udì una voce tonante e maschile provenire dal cielo, che gridava: "Io sono l'unico Dio e non esistono altri Dei al di fuori di me!".
Ma subito dopo si udì una voce femminile provenire da un cielo più alto, e gridare: "Figliolo, non raccontar balle!"
22/05/2011, 13:17
Ok, era solo un intervallo in attesa dell'intervento successivo. 
Sono convinta che la ricerca del divino è un ha percorso individuale ma la storia di come l'uomo abbia cercato di rapportarsi al divino e di come l'abbia rappresentato sin dall'origine dei tempi sia uno degli argomenti più interessanti ed affascinanti.
Sono convinta che la ricerca del divino è un ha percorso individuale ma la storia di come l'uomo abbia cercato di rapportarsi al divino e di come l'abbia rappresentato sin dall'origine dei tempi sia uno degli argomenti più interessanti ed affascinanti.
22/05/2011, 13:26
Sarà stata la Sophia che rimproverava Yaldabaoth ![Goloso [:p]](./images/smilies/UF/icon_smile_tongue.gif) .
.
22/05/2011, 14:11
Blissenobiarella ha scritto:
Sarà stata la Sophia che rimproverava Yaldabaoth.
É probabile....
22/05/2011, 16:12
Mi avete fatto ricordare di un testo sull'argomento, che scrissi per i "Vespera Albana"- , un'iniziativa culturale dalle mie parti.
Tra l'altro forse qualche romano saprà che in corrispondenza del grande incrocio di Frattocchie, sull'Appia (area nota per le numerose abitazioni di prostitute, in tempi remoti ) esistevano anticamente (epoca pre cristiana) due pietrone-stele dette "le Madri", successivamente un dipinto raffigurante due apostoli ne prese il posto , da cui il nome di una zona nei pressi detta appunto "Due Santi"![Felice [:)]](./images/smilies/UF/icon_smile.gif) :
:
"20 ottobre 2001
Pur vivendo in un’epoca in cui le comunicazioni sono essenziali e facilitate da una tecnologia sempre più sofisticata ed invadente, il simbolo non ha affatto perso “smalto” e la sua importanza, se ce ne fosse bisogno, è sottolineata dai tristi eventi di recentissima data, che proprio a danno di imponenti simboli del benessere occidentale sono stati architettati.
Il peso della simbologia si fa tanto più evidente se ci si riferisce ad epoche in cui non si poteva usufruire neanche della scrittura ed in cui lo strumento più raffinato era una selce affilata.
Proprio tramite il simbolo dipinto o scalfito, ci si rende conto di quanto antico sia il senso del divino che permea l’ uomo.
Il suo stupore davanti agli eventi della natura e le domande che si pone sul senso della vita e della morte, provocano il bisogno di indagare ed interagire col metafisico.
Nel più normale ed intensamente vissuto degli accadimenti, quello della nascita della vita, il momento del parto, la creatura umana si fa “creatrice” ed in quanto tale s’avvicina alla divinità che genera il mondo.
Ecco perché in origine Dio è Madre.
Ecco perché della Grande Dea Madre è impregnata la simbologia di tutta l’antichità.
Quelle che spesso appaiono come pure decorazioni sono, nella stragrande maggioranza, stilizzazioni di quel personaggio divino che si invoca o si ringrazia, o comunque si menziona, si testimonia e la cui memoria si tramanda.
E la varietà di forme che si rifanno a quella imprescindibile divinità è così vasta che senza una ricerca filologica approfondita è spesso difficile intuire un riferimento ad essa.
Trascorrendo i millenni e spostandosi le tribù intercorrono scambi di informazioni e di oggetti, per cui si affermano “modi” di rappresentare la Dea comuni a vaste aree. La figuretta dagli attributi di madre molto accentuati, quasi caricaturali, è un manufatto modellato nell’argilla o scolpito nella pietra, legno, osso, che troviamo quasi ovunque sulla faccia della terra, ed ha a che vedere con ogni attività vitale per la sopravvivenza della comunità, soprattutto con quelle legate ai cicli naturali, come l’agricoltura, legata ai ritmi delle stagioni, o l’ allevamento, e quindi le nascite di nuovi capi di bestiame.
La Dea è anche Madre Terra ed, in quanto tale, associata agli elementi che la costituiscono: aria, acqua, terra e fuoco, ampiamente raffigurati.
Dispensatrice di vita
L’acqua è sinonimo di vita. Sono simboli acquatici d’ epoca paleolitica lo zig-zag, le linee ondulate e serpentine, a rete e scacchiera, pioggia, distese e corsi d’acqua. L’ uccello acquatico, la donna-uccello. Non si riteneva correlato l’ accoppiamento con la procreazione, quindi la divinità assume caratteri esagerati della figura femminile, il Corpo Magico, con seni e glutei sproporzionati, che origina la vita. L’umidità degli organi riproduttivi della Dea è la fonte della vita.
Nella personificazione della civetta troviamo come elementi importanti anche gli occhi della dea, dall’espressione fissa e allucinata, ma chiaroveggenti, tondi e circondati di raggi come una coppia di soli, sorgenti di lacrime, occhi come fonti: fonti di vita.
Troviamo tracce della Dea-uccello anche in epoca molto più recente ad es. nei miti mediterranei delle arpie e delle sirene; sono alati l’ ippogrifo, la sfinge, Iside, gli angeli ecc.
La terra eterna che si rinnova
Nel paleolitico superiore troviamo raffigurata la Dea partoriente e la stilizzazione della vulva (losanga) . Sono ad essa collegati la cerva , il daino, l’ orso, il bisonte femmina e la giumenta. Probabilmente nel neolitico si faceva già un collegamento tra ruolo paterno e riproduzione.
L’ ariete, primo animale domestico, divenne sacro alla Dea-uccello. Di qui l’ uso del simbolo del vello e l’ associazione della Dea alla filatura e tessitura, e quindi al Fato: nasce l’ idea di una divinità che dispensa la vita e ne decide la durata e l’ esito, fila e tesse la vita.
Compare la ceramica, e su di essa abbondano i segni della Dea: “M”, zig-zag, acqua, onde e spirali.
Nella nuova economia agricola la Dea gravida del paleolitico diventa la divinità della fertilità.
Fecondità di uomini e animali, abbondanza di raccolti, fioritura delle piante, processi di crescita e ingrassamento acquistano grande importanza.
La scrofa, animale di rapida crescita e ingrasso, divenne sacra a questa Dea.
In origine forse divinità lunare, tonda come la luna piena, la Dea gravida dell’epoca agricola divenne una divinità ctonia (terrestre), simbolo del ciclo vitale della vegetazione (nascita, fioritura e morte).
La rappresentazione del mutamento delle stagioni si intensificò, manifestandosi nei rituali estivi/invernali o primaverili/autunnali e nella comparsa dell’immagine di una madre/sorella e di un dio maschile, spirito della vegetazione che nasce e che muore.
Morte e rigenerazione
La Messaggera e la Reggitrice di Morte sono coinvolte nella rigenerazione: teste di avvoltoio tra i seni, zanne e bocche di feroci animali sono coperte di seni. Le immagini della Dea-civetta hanno i seni e il loro corpo è un labirinto creatore.
Come simbolo di rigenerazione l’ utero o cranio di bue (bucranio) o altre forme di animali (pesce, rana, rospo, porcospino, tartaruga), hanno svolto una funzione per quasi tutta la preistoria post-paleolitica e anche dopo, nel periodo storico.
Tombe e templi, nel Neolitico assumono la forma di uovo, degli organi riproduttivi della Dea, o anche del suo intero corpo. La forma della tomba è analoga ad una collina naturale, con una pietra alla sommità (omphalos) a simboleggiare l’ ombelico (ventre gravido e cordone ombelicale).
Nella sua veste di dea della morte, la divinità è raffigurata come un nudo rigido o un semplice osso, privo delle rotondità che donano la vita, con un enorme triangolo pubico in cui inizia la trasformazione da morte in vita.
A volte ha volto d’uccello e zampe di rapace, altre bocca larga, zanne e piccoli occhi tondi, come i serpenti. Forse, in tale aspetto è l’antenata della Gorgone greca.
Energia e sviluppo
I simboli dell’energia e sviluppo formano un’ ampia categoria: spirali, coni, falci di luna, semicerchi ad “U”, ganci, asce, cani, capri, itifalli, con a fianco una sorgente, una colonna di vita acquatica, un serpente, un albero della vita e la Dea antropomorfa o il suo ventre gravido, sono simboli di energia.
Serpenti antitetici,teste a spirali, vortici, croci e segni quadrangolari, sono segni di dinamismo della natura e del ciclo di morte – vita , che si rinnova per perpetuare la vita.
Era normale percepire il potere della dea nell’ uccello o nella pietra, nei suoi occhi o nei seni soltanto, o addirittura nei geroglifici (V, X, M), che la rappresentavano.
Ciò che appare evidente dall’ esame delle rappresentazioni del divino rinvenute in tutta l’Antica Europa, Anatolia, Creta minoica, è che in una società fortemente legata alla natura e ai suoi cicli, la donna e la sua feconda e sacra fisicità gode di grande considerazione. In un sistema matrilineare, le donne ricoprono cariche di capi e di sacerdotesse. La vita scorre con ritmi equilibrati e pacifici senza che uno dei due sessi prevarichi l’altro.
La fine dell’antica cultura europea si ha tra il 4300 e il 2800 a.C. con l’avvento dell’androcrazia e della patrilinearità . A partire dal VI millennio inizia l’ addomesticamento del cavallo. Questo fatto unito alla fabbricazione delle prime armi (arco, freccia, lancia e daga) segna l’ inizio di un epoca più turbolenta e l’introduzione della guerra come elemento costante nel cammino della storia.
Solo in poche isole il contagio bellico viene evitato fino al 1500 a.C.: Thera, Creta, Malta e Sardegna godono di una civiltà creativa e pacifica più a lungo del resto dell’Europa.
La Grande Dea Madre, dal grembo generoso, la gente che l’ ha adorata e le ha dedicato oggetti di innocente ed armoniosa bellezza sono stati i protagonisti di un passato che si è consumato nei luoghi che oggi sono i nostri. L’impronta della Grande Madre è fatta di equilibrio e di rispetto, il suo messaggio porta inevitabilmente a riflettere sulle aberrazioni dei nostri tempi.
Tra l'altro forse qualche romano saprà che in corrispondenza del grande incrocio di Frattocchie, sull'Appia (area nota per le numerose abitazioni di prostitute, in tempi remoti ) esistevano anticamente (epoca pre cristiana) due pietrone-stele dette "le Madri", successivamente un dipinto raffigurante due apostoli ne prese il posto , da cui il nome di una zona nei pressi detta appunto "Due Santi"
"20 ottobre 2001
Pur vivendo in un’epoca in cui le comunicazioni sono essenziali e facilitate da una tecnologia sempre più sofisticata ed invadente, il simbolo non ha affatto perso “smalto” e la sua importanza, se ce ne fosse bisogno, è sottolineata dai tristi eventi di recentissima data, che proprio a danno di imponenti simboli del benessere occidentale sono stati architettati.
Il peso della simbologia si fa tanto più evidente se ci si riferisce ad epoche in cui non si poteva usufruire neanche della scrittura ed in cui lo strumento più raffinato era una selce affilata.
Proprio tramite il simbolo dipinto o scalfito, ci si rende conto di quanto antico sia il senso del divino che permea l’ uomo.
Il suo stupore davanti agli eventi della natura e le domande che si pone sul senso della vita e della morte, provocano il bisogno di indagare ed interagire col metafisico.
Nel più normale ed intensamente vissuto degli accadimenti, quello della nascita della vita, il momento del parto, la creatura umana si fa “creatrice” ed in quanto tale s’avvicina alla divinità che genera il mondo.
Ecco perché in origine Dio è Madre.
Ecco perché della Grande Dea Madre è impregnata la simbologia di tutta l’antichità.
Quelle che spesso appaiono come pure decorazioni sono, nella stragrande maggioranza, stilizzazioni di quel personaggio divino che si invoca o si ringrazia, o comunque si menziona, si testimonia e la cui memoria si tramanda.
E la varietà di forme che si rifanno a quella imprescindibile divinità è così vasta che senza una ricerca filologica approfondita è spesso difficile intuire un riferimento ad essa.
Trascorrendo i millenni e spostandosi le tribù intercorrono scambi di informazioni e di oggetti, per cui si affermano “modi” di rappresentare la Dea comuni a vaste aree. La figuretta dagli attributi di madre molto accentuati, quasi caricaturali, è un manufatto modellato nell’argilla o scolpito nella pietra, legno, osso, che troviamo quasi ovunque sulla faccia della terra, ed ha a che vedere con ogni attività vitale per la sopravvivenza della comunità, soprattutto con quelle legate ai cicli naturali, come l’agricoltura, legata ai ritmi delle stagioni, o l’ allevamento, e quindi le nascite di nuovi capi di bestiame.
La Dea è anche Madre Terra ed, in quanto tale, associata agli elementi che la costituiscono: aria, acqua, terra e fuoco, ampiamente raffigurati.
Dispensatrice di vita
L’acqua è sinonimo di vita. Sono simboli acquatici d’ epoca paleolitica lo zig-zag, le linee ondulate e serpentine, a rete e scacchiera, pioggia, distese e corsi d’acqua. L’ uccello acquatico, la donna-uccello. Non si riteneva correlato l’ accoppiamento con la procreazione, quindi la divinità assume caratteri esagerati della figura femminile, il Corpo Magico, con seni e glutei sproporzionati, che origina la vita. L’umidità degli organi riproduttivi della Dea è la fonte della vita.
Nella personificazione della civetta troviamo come elementi importanti anche gli occhi della dea, dall’espressione fissa e allucinata, ma chiaroveggenti, tondi e circondati di raggi come una coppia di soli, sorgenti di lacrime, occhi come fonti: fonti di vita.
Troviamo tracce della Dea-uccello anche in epoca molto più recente ad es. nei miti mediterranei delle arpie e delle sirene; sono alati l’ ippogrifo, la sfinge, Iside, gli angeli ecc.
La terra eterna che si rinnova
Nel paleolitico superiore troviamo raffigurata la Dea partoriente e la stilizzazione della vulva (losanga) . Sono ad essa collegati la cerva , il daino, l’ orso, il bisonte femmina e la giumenta. Probabilmente nel neolitico si faceva già un collegamento tra ruolo paterno e riproduzione.
L’ ariete, primo animale domestico, divenne sacro alla Dea-uccello. Di qui l’ uso del simbolo del vello e l’ associazione della Dea alla filatura e tessitura, e quindi al Fato: nasce l’ idea di una divinità che dispensa la vita e ne decide la durata e l’ esito, fila e tesse la vita.
Compare la ceramica, e su di essa abbondano i segni della Dea: “M”, zig-zag, acqua, onde e spirali.
Nella nuova economia agricola la Dea gravida del paleolitico diventa la divinità della fertilità.
Fecondità di uomini e animali, abbondanza di raccolti, fioritura delle piante, processi di crescita e ingrassamento acquistano grande importanza.
La scrofa, animale di rapida crescita e ingrasso, divenne sacra a questa Dea.
In origine forse divinità lunare, tonda come la luna piena, la Dea gravida dell’epoca agricola divenne una divinità ctonia (terrestre), simbolo del ciclo vitale della vegetazione (nascita, fioritura e morte).
La rappresentazione del mutamento delle stagioni si intensificò, manifestandosi nei rituali estivi/invernali o primaverili/autunnali e nella comparsa dell’immagine di una madre/sorella e di un dio maschile, spirito della vegetazione che nasce e che muore.
Morte e rigenerazione
La Messaggera e la Reggitrice di Morte sono coinvolte nella rigenerazione: teste di avvoltoio tra i seni, zanne e bocche di feroci animali sono coperte di seni. Le immagini della Dea-civetta hanno i seni e il loro corpo è un labirinto creatore.
Come simbolo di rigenerazione l’ utero o cranio di bue (bucranio) o altre forme di animali (pesce, rana, rospo, porcospino, tartaruga), hanno svolto una funzione per quasi tutta la preistoria post-paleolitica e anche dopo, nel periodo storico.
Tombe e templi, nel Neolitico assumono la forma di uovo, degli organi riproduttivi della Dea, o anche del suo intero corpo. La forma della tomba è analoga ad una collina naturale, con una pietra alla sommità (omphalos) a simboleggiare l’ ombelico (ventre gravido e cordone ombelicale).
Nella sua veste di dea della morte, la divinità è raffigurata come un nudo rigido o un semplice osso, privo delle rotondità che donano la vita, con un enorme triangolo pubico in cui inizia la trasformazione da morte in vita.
A volte ha volto d’uccello e zampe di rapace, altre bocca larga, zanne e piccoli occhi tondi, come i serpenti. Forse, in tale aspetto è l’antenata della Gorgone greca.
Energia e sviluppo
I simboli dell’energia e sviluppo formano un’ ampia categoria: spirali, coni, falci di luna, semicerchi ad “U”, ganci, asce, cani, capri, itifalli, con a fianco una sorgente, una colonna di vita acquatica, un serpente, un albero della vita e la Dea antropomorfa o il suo ventre gravido, sono simboli di energia.
Serpenti antitetici,teste a spirali, vortici, croci e segni quadrangolari, sono segni di dinamismo della natura e del ciclo di morte – vita , che si rinnova per perpetuare la vita.
Era normale percepire il potere della dea nell’ uccello o nella pietra, nei suoi occhi o nei seni soltanto, o addirittura nei geroglifici (V, X, M), che la rappresentavano.
Ciò che appare evidente dall’ esame delle rappresentazioni del divino rinvenute in tutta l’Antica Europa, Anatolia, Creta minoica, è che in una società fortemente legata alla natura e ai suoi cicli, la donna e la sua feconda e sacra fisicità gode di grande considerazione. In un sistema matrilineare, le donne ricoprono cariche di capi e di sacerdotesse. La vita scorre con ritmi equilibrati e pacifici senza che uno dei due sessi prevarichi l’altro.
La fine dell’antica cultura europea si ha tra il 4300 e il 2800 a.C. con l’avvento dell’androcrazia e della patrilinearità . A partire dal VI millennio inizia l’ addomesticamento del cavallo. Questo fatto unito alla fabbricazione delle prime armi (arco, freccia, lancia e daga) segna l’ inizio di un epoca più turbolenta e l’introduzione della guerra come elemento costante nel cammino della storia.
Solo in poche isole il contagio bellico viene evitato fino al 1500 a.C.: Thera, Creta, Malta e Sardegna godono di una civiltà creativa e pacifica più a lungo del resto dell’Europa.
La Grande Dea Madre, dal grembo generoso, la gente che l’ ha adorata e le ha dedicato oggetti di innocente ed armoniosa bellezza sono stati i protagonisti di un passato che si è consumato nei luoghi che oggi sono i nostri. L’impronta della Grande Madre è fatta di equilibrio e di rispetto, il suo messaggio porta inevitabilmente a riflettere sulle aberrazioni dei nostri tempi.
Ultima modifica di melusina il 22/05/2011, 16:31, modificato 1 volta in totale.
23/05/2011, 10:18
Simbolismi ed evoluzioni della Grande Dea
di Ardath Lili Sekhet Babalon

I principali temi rappresentati nel simbolismo della Dea sono il mistero della nascita e della morte, come anche quello del rinnovarsi della vita, non solo umana, ma anche tutta la vita del pianeta e, naturalmente, del cosmo. Simboli e immagini si affollano intorno alla Dea partenogenica (autogeneratrice) e alle sue funzioni di base come Donatrice di Vita o Portatrice di Morte, e non meno importante, come Rigeneratrice della Madre Terra, la Dea della Fertilità, giovane e vecchia, che nasce e muore con la vita vegetale. Essa era l'unica fonte di vita, che prendeva la sua energia da sorgenti e pozzi, dal sole, dalla luna e dalla terra umida. Questo insieme di simboli rappresenta un tempo mitico che è ciclico, non lineare. Questo si manifesta nell'arte con segni di movimento dinamico: spirali che girano e si ritorcono, serpenti attorcigliati e ondulanti, circoli, alte maree, corna bovine, semi germinati e germogli.
Il serpente era il simbolo dell'energia vitale e della rigenerazione, una creatura delle più benevole, non malvagia. Anche i colori avevano un significato differente da quello del sistema simbolico indoeuropeo: il nero non significava morte o inferno; era il colore della fertilità, delle grotte umide e del suolo ferace, del seno della Dea, dove comincia la vita; il bianco, al contrario era il colore della morte, delle ossa, all'opposto del sistema indoeuropeo, nel quale sia il bianco che il giallo sono i colori del cielo e del sole raggiante.

In nessun modo si deve confondere la filosofia da cui derivano queste immagini con quella del mondo pastorale indoeuropeo, nel quale gli dei guerrieri a cavallo rappresentano il cielo radioso o tormentoso, o anche l'inferno paludoso, l'ideologia per cui le dee non sono creatrici, bensì bellezze ("Venus") sposate con gli dèi-cielo.
L'arte che riguarda la Dea, con la sua sorprendente assenza di immagini di guerra e di dominazione maschile, riflette un ordine sociale in cui le donne, in quanto capi di clan o sacerdotesse-regine, assumono un ruolo centrale. La Vecchia Europa(1) e l'Anatolia, come pure la Creta Minoica, erano una "gylania" (2). Questo sistema sociale equilibrato, nè patriarcale nè matriarcale, lascia il suo riflesso nella religione, nella mitologia e nel folklore che si ricavano dagli studi della struttura sociale corrispondente alle culture minoiche e della Vecchia Europa, ed è rafforzato dalla continuità degli elementi in un sistema matrilineare come quelli della Grecia Antica, dell'Etruria, di Roma, del Paese Basco e di altri paesi dell'Europa.
Tuttavia il sistema matrilineare e incentrato sulla Dea, tanto profondamente analizzato da Marija Gimbutas rispetto alla Vecchia Europa, non sembra che rimanesse limitato al continente eurasiatico, ma al contrario, fu anche esteso almeno a tutto il Vicino Oriente, all'Egitto e all'Africa Sahariana. Sebbene in queste ultime regioni non siano state trovate molte figure femminili come in Europa, se ne hanno a sufficienza per poter affermare che la religione della Dea fu universale fino a pochi millenni fa.
Alcuni storici specializzati in culture africane si spingono molto oltre, e sono giunti ad affermare che la Dea primigenia fu nera e nacque della regione nord-est dell'Africa, da dove si estese verso il continente eurasiatico insieme alle ondate migratorie che penetrarono in Europa circa 40.000 anni fa. L'ipotesi è suggestiva e probabile, dato che l'uomo moderno effettivamente proviene dal nord-est africano, proprio come la sofisticata tecnologia aurignaciana, e che la sua via di penetrazione coincide con il centro di espansione della cosidetta "cultura iconografica femminile", cioè della religione della Dea, ma non esiste alcuna attestazione archeologica circa possibili figure di dee africane che siano più antiche di quelle europee. E' possibile che la Dea nacque sia in Africa che in Europa, nessuno oggi sembra poter dire l'ultima parola a tale proposito.

Oya: Dea Madre dell'Africa Occidentale, alcune volte si presenta nella forma di un toro, è adorata dagli Yoruba, è probabilmente anche la dea dell'arcobaleno. E' inoltre la dea della Danza. Figlia unica della dea dell'acqua Yemanya. Oya fece il primo elemento, da cui l'universo esiste. Ella è una delle tre dee dei fiumi, che danno il nome ad un fiume. Lei personifica il fiume Niger, le altre sono Oshun e Oba. Suo fratello e marito era il dio Sjango, al quale lei offrì il governo del tuono e dei fulmini. Una volta egli la vide al fiume mentre mutava in toro, per fargli mantenere il segreto lei si uni a lui ma, egli rivelò ad altre donne il segreto mentre era ubriaco. A causa di ciò sfuggì alla morte molto faticosamente. Come la Dea Madre, Oya porta una doppia ascia sulla testa. Questo è attributo di Sjango, al quale sottrasse il segreto delle tempeste. Con l'avvento della cristianità Oya, Oshun e Oba furono convertiti in Santi. Durante il periodo della schiavitù, il suo culto fu trasportato alle Americhe dove fu adorata come la dea dell'arcobaleno Olla a Cuba e a Porto Rico. A Cuba è anche comparata alla Vergine Maria. In Brasile è chiamata Yansa do Yansan, e fu resa anche qui santa con il nome di Barbara. Nel Voodoo Haitiano è conosciuta come Maman Brigette o Damballah.
Nella regione eurasiatica e nel Vicino Oriente, con l'inizio del VII millennio a.C., le necessità mitologiche delle nuove società in formazione portarono la Gran Dea paleolitica a doversi manifestare attraverso un considerevole numero di appellativi o sembianze differenti, come Dea della Fertilità della Terra o Dea del Grano, Dea Serpente, Dea Pesce, Dea Rana, Dea Riccio e Dea Farfalla o Ape. Tuttavia la sua onnipotenza e le sue funzioni ancestrali rimasero intatte e indiscutibili; anche il suo simbolismo classico continuò ad esistere, seppure incorporando alcuni nuovi disegni che avrebbero finito per acquistare molta importanza rituale.

Ripercorrendo la storia evolutiva della fondamentale Dea Uccello paleolitica, vediamo che dall' VIII al VI millennio a.C. nella regione dell'Egeo e nei Balcani fu rappresentata attraverso un'immagine dotata di un lungo collo fallico, un precedente che, nel passaggio seguente, quando la cultura neolitica del sud-ovest europeo giunse al suo apogeo (circa 5000 a.C.), avrebbe trasformato la dea, (ispirandosi forse al collo serpentiforme di alcuni uccelli acquatici) e dato origine alla Dea Uccello e Serpente. Questa Dea veniva rappresentata sia sotto forma di due divinità distinte (Dea Uccello e Dea Serpente) che di una sola (Dea Uccello e Serpente).
La principale funzione della Dea nel suo nuovo aspetto di Serpente era quella di garantire la continuità dell'energia vitale e offrire rigenerazione ad ogni esistenza esaurita.
La Dea Serpente fu la prima divinità a presentarsi incoronata; così dal VII millennio a.C., le sue immagini apparvero frequentemente con una corona, simbolo di potere e saggezza, o con una pettinatura molto sofisticata, caratterizzata da ricci serpentiformi. Sia la Dea Uccello che la Dea Serpente, e la sintesi di ambedue, furono adorate in santuari specifici almeno dall'inizio del VI millennio a.C. Il rapporto fra il serpente e il potere generatore della Dea continuò nel tempo, ed era ancora evidente in casi come quelli di Hera e Hathor.
In tutta la civiltà greco-romana, come anche in molte culture africane ed asiatiche, si protrasse la credenza che i serpenti agissero da protettori del focolare e fossero fonti di fertilità e prosperità per gli uomini e per i loro raccolti e greggi; di fatto si credeva che il loro rinascere dopo l'inverno influisse positivamente sulla rigenerazione della natura. Questi poteri erano stati esclusivi della Dea fin dai tempi paleolitici.
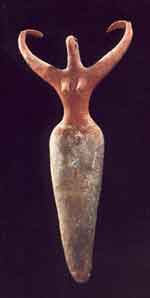
Dea Uccello o Dea con testa di Serpente- età 5000 anni

Dea dei Serpenti dal Tesoro Sacro del palazzo di Cnosso, 1600 a.C.

Dea dei Serpenti, Egeo, Creta 1600 a.C.
La Dea-maga Angizia (sorella di Medea e di Circe), aveva scelto come sua dimora le sponde del lago Fucino e con il canto riusciva a dominare i serpenti e comandarli secondo la sua volontà. L'Antico culto della dea Angizia raffigurava una donna con un serpente nella mano sinistra alzata, protettrice dal morso dei serpenti. Una sua statuetta è stata rinvenuta nel lago Fucino, dove si credeva che essa avesse dimora, e Virgilio ricorda la presenza di un "nemus Angitiae", cioè un bosco sacro a questa divinità, nei pressi del lago.
Un testo classico relativamente recente, la deliziosa narrazione L'Asino d'oro di Apuleio(114-184 d.C.) offre una descrizione riveduta della Dea, così come fu considerata nell'Antichità. Lucio Apuleio, viaggiatore instancabile e buon conoscitore delle religioni misteriche del suo tempo, fece parlare la Dea stessa:
"Eccomi Lucio commossa dalle tue preghiere. Io sono la Natura Genitrice di tutte le cose, signora di tutti gli elementi, principio e generazione dei secoli, la più grande dei Numi, la regina dei Mani, la prima fra i Celesti, forma tipica degli Dèi e delle Dee, che governano col mio cenno le luminose vette del cielo, le salutari brezze marine, i lacrimati silenzi degli Inferi. tutto il mondo venera il mio nome, unico se pure sotto molte e diverse forme, con vario rito e con diversi nomi. I Frigi primi abitatori della Terra, mi chiamano la Pessinunzia Madre degli Dèi; gli Attici autoctoni, Cecropia Minerva; ho nome Venere Pafia presso gli abitanti dell'isola di Cipro; Diana Dittina presso i Cretesi famosi arcieri; Proserpina Stigia fra i Siculi trilingui; Vetusta Cerere fra gli Eleusini; altri mi chiaman Giunone, altri Bellona; questi Ecate e quelli Ramnusia. Ma solamente coloro che sono illuminatidai primi raggi del nascente sole, cioè gli uni e gli altri Etiopi, e gli Egiziani ammirevoli per la loro antica dottrina, mi onorano con un culto di adeguate cerimonie e mi appellano col mio vero nome di Iside Regina".
In un erbario inglese del XII secolo conservato al British Museum e citato da Robert Graves, compare un'invocazione alla Dea Madre Terra, una manifestazione neolitica della Dea Gravida Paleolitica, che si rivela molto eloquente:
"Terra, Dea divina, Madre Natura, che generi ogni cosa e sempre fai riapparire il sole di cui hai fatto dono alle genti; guardiana del cielo, del mare e di tutti gli Dèi e le potenze; per il tuo influsso tutta la natura si si acqueta e sprofonda nel sonno..E di nuovo quando ti aggrada tu mandi innanzi la lieta luce del giorno e doni nutrimento alla vita con la tua eterna promessa; e quando lo spirito dell'uomo trapassa è a te che ritorna. A buon diritto invero tu sei detta Grande Madre degli Dèi; Vittoria è il tuo nome divino. Tu sei possente, Regina degli Dèi! O Dea io ti adoro come divina, io invoco il tuo nome, degnati di concedermi ciò che ti chiedo, in modo ch'io possa in cambio colmare di grazie la Tua dinività, con la fede che ti è dovuta.."
Note
(1)Il termine Vecchia Europa, come l'ha definito Marija Gimbutas, include tutta la zona geografica che comprende l'Egeo, i Balcani, l'Europa orientale e centrale, il Mediterraneo centrale e l'Europa occidentale.
(2)Marija Gimbutas ha preso il termine da Riana Eisler, che suo libro "The Chalice and the Blade" propose di denominare "gylania" (gy, di donna e an di andros-uomo) per riferirsi alla struttura sociale nella quale i due sessi mantengono un rapporto sociale egualitario.
Testi
P.Rodriguez, Dio è nato donna, Editori Riuniti
M.Gimbutas, Il Linguaggio della Dea
R.Graves, La Dea Bianca, Adelphi
[align=right]Fonte: http://www.arcadia93.org/simbolismi_dea.html
[/align]
di Ardath Lili Sekhet Babalon

I principali temi rappresentati nel simbolismo della Dea sono il mistero della nascita e della morte, come anche quello del rinnovarsi della vita, non solo umana, ma anche tutta la vita del pianeta e, naturalmente, del cosmo. Simboli e immagini si affollano intorno alla Dea partenogenica (autogeneratrice) e alle sue funzioni di base come Donatrice di Vita o Portatrice di Morte, e non meno importante, come Rigeneratrice della Madre Terra, la Dea della Fertilità, giovane e vecchia, che nasce e muore con la vita vegetale. Essa era l'unica fonte di vita, che prendeva la sua energia da sorgenti e pozzi, dal sole, dalla luna e dalla terra umida. Questo insieme di simboli rappresenta un tempo mitico che è ciclico, non lineare. Questo si manifesta nell'arte con segni di movimento dinamico: spirali che girano e si ritorcono, serpenti attorcigliati e ondulanti, circoli, alte maree, corna bovine, semi germinati e germogli.
Il serpente era il simbolo dell'energia vitale e della rigenerazione, una creatura delle più benevole, non malvagia. Anche i colori avevano un significato differente da quello del sistema simbolico indoeuropeo: il nero non significava morte o inferno; era il colore della fertilità, delle grotte umide e del suolo ferace, del seno della Dea, dove comincia la vita; il bianco, al contrario era il colore della morte, delle ossa, all'opposto del sistema indoeuropeo, nel quale sia il bianco che il giallo sono i colori del cielo e del sole raggiante.

In nessun modo si deve confondere la filosofia da cui derivano queste immagini con quella del mondo pastorale indoeuropeo, nel quale gli dei guerrieri a cavallo rappresentano il cielo radioso o tormentoso, o anche l'inferno paludoso, l'ideologia per cui le dee non sono creatrici, bensì bellezze ("Venus") sposate con gli dèi-cielo.
L'arte che riguarda la Dea, con la sua sorprendente assenza di immagini di guerra e di dominazione maschile, riflette un ordine sociale in cui le donne, in quanto capi di clan o sacerdotesse-regine, assumono un ruolo centrale. La Vecchia Europa(1) e l'Anatolia, come pure la Creta Minoica, erano una "gylania" (2). Questo sistema sociale equilibrato, nè patriarcale nè matriarcale, lascia il suo riflesso nella religione, nella mitologia e nel folklore che si ricavano dagli studi della struttura sociale corrispondente alle culture minoiche e della Vecchia Europa, ed è rafforzato dalla continuità degli elementi in un sistema matrilineare come quelli della Grecia Antica, dell'Etruria, di Roma, del Paese Basco e di altri paesi dell'Europa.
Tuttavia il sistema matrilineare e incentrato sulla Dea, tanto profondamente analizzato da Marija Gimbutas rispetto alla Vecchia Europa, non sembra che rimanesse limitato al continente eurasiatico, ma al contrario, fu anche esteso almeno a tutto il Vicino Oriente, all'Egitto e all'Africa Sahariana. Sebbene in queste ultime regioni non siano state trovate molte figure femminili come in Europa, se ne hanno a sufficienza per poter affermare che la religione della Dea fu universale fino a pochi millenni fa.
Alcuni storici specializzati in culture africane si spingono molto oltre, e sono giunti ad affermare che la Dea primigenia fu nera e nacque della regione nord-est dell'Africa, da dove si estese verso il continente eurasiatico insieme alle ondate migratorie che penetrarono in Europa circa 40.000 anni fa. L'ipotesi è suggestiva e probabile, dato che l'uomo moderno effettivamente proviene dal nord-est africano, proprio come la sofisticata tecnologia aurignaciana, e che la sua via di penetrazione coincide con il centro di espansione della cosidetta "cultura iconografica femminile", cioè della religione della Dea, ma non esiste alcuna attestazione archeologica circa possibili figure di dee africane che siano più antiche di quelle europee. E' possibile che la Dea nacque sia in Africa che in Europa, nessuno oggi sembra poter dire l'ultima parola a tale proposito.

Oya: Dea Madre dell'Africa Occidentale, alcune volte si presenta nella forma di un toro, è adorata dagli Yoruba, è probabilmente anche la dea dell'arcobaleno. E' inoltre la dea della Danza. Figlia unica della dea dell'acqua Yemanya. Oya fece il primo elemento, da cui l'universo esiste. Ella è una delle tre dee dei fiumi, che danno il nome ad un fiume. Lei personifica il fiume Niger, le altre sono Oshun e Oba. Suo fratello e marito era il dio Sjango, al quale lei offrì il governo del tuono e dei fulmini. Una volta egli la vide al fiume mentre mutava in toro, per fargli mantenere il segreto lei si uni a lui ma, egli rivelò ad altre donne il segreto mentre era ubriaco. A causa di ciò sfuggì alla morte molto faticosamente. Come la Dea Madre, Oya porta una doppia ascia sulla testa. Questo è attributo di Sjango, al quale sottrasse il segreto delle tempeste. Con l'avvento della cristianità Oya, Oshun e Oba furono convertiti in Santi. Durante il periodo della schiavitù, il suo culto fu trasportato alle Americhe dove fu adorata come la dea dell'arcobaleno Olla a Cuba e a Porto Rico. A Cuba è anche comparata alla Vergine Maria. In Brasile è chiamata Yansa do Yansan, e fu resa anche qui santa con il nome di Barbara. Nel Voodoo Haitiano è conosciuta come Maman Brigette o Damballah.
Nella regione eurasiatica e nel Vicino Oriente, con l'inizio del VII millennio a.C., le necessità mitologiche delle nuove società in formazione portarono la Gran Dea paleolitica a doversi manifestare attraverso un considerevole numero di appellativi o sembianze differenti, come Dea della Fertilità della Terra o Dea del Grano, Dea Serpente, Dea Pesce, Dea Rana, Dea Riccio e Dea Farfalla o Ape. Tuttavia la sua onnipotenza e le sue funzioni ancestrali rimasero intatte e indiscutibili; anche il suo simbolismo classico continuò ad esistere, seppure incorporando alcuni nuovi disegni che avrebbero finito per acquistare molta importanza rituale.

Ripercorrendo la storia evolutiva della fondamentale Dea Uccello paleolitica, vediamo che dall' VIII al VI millennio a.C. nella regione dell'Egeo e nei Balcani fu rappresentata attraverso un'immagine dotata di un lungo collo fallico, un precedente che, nel passaggio seguente, quando la cultura neolitica del sud-ovest europeo giunse al suo apogeo (circa 5000 a.C.), avrebbe trasformato la dea, (ispirandosi forse al collo serpentiforme di alcuni uccelli acquatici) e dato origine alla Dea Uccello e Serpente. Questa Dea veniva rappresentata sia sotto forma di due divinità distinte (Dea Uccello e Dea Serpente) che di una sola (Dea Uccello e Serpente).
La principale funzione della Dea nel suo nuovo aspetto di Serpente era quella di garantire la continuità dell'energia vitale e offrire rigenerazione ad ogni esistenza esaurita.
La Dea Serpente fu la prima divinità a presentarsi incoronata; così dal VII millennio a.C., le sue immagini apparvero frequentemente con una corona, simbolo di potere e saggezza, o con una pettinatura molto sofisticata, caratterizzata da ricci serpentiformi. Sia la Dea Uccello che la Dea Serpente, e la sintesi di ambedue, furono adorate in santuari specifici almeno dall'inizio del VI millennio a.C. Il rapporto fra il serpente e il potere generatore della Dea continuò nel tempo, ed era ancora evidente in casi come quelli di Hera e Hathor.
In tutta la civiltà greco-romana, come anche in molte culture africane ed asiatiche, si protrasse la credenza che i serpenti agissero da protettori del focolare e fossero fonti di fertilità e prosperità per gli uomini e per i loro raccolti e greggi; di fatto si credeva che il loro rinascere dopo l'inverno influisse positivamente sulla rigenerazione della natura. Questi poteri erano stati esclusivi della Dea fin dai tempi paleolitici.
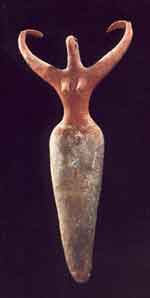
Dea Uccello o Dea con testa di Serpente- età 5000 anni

Dea dei Serpenti dal Tesoro Sacro del palazzo di Cnosso, 1600 a.C.

Dea dei Serpenti, Egeo, Creta 1600 a.C.
La Dea-maga Angizia (sorella di Medea e di Circe), aveva scelto come sua dimora le sponde del lago Fucino e con il canto riusciva a dominare i serpenti e comandarli secondo la sua volontà. L'Antico culto della dea Angizia raffigurava una donna con un serpente nella mano sinistra alzata, protettrice dal morso dei serpenti. Una sua statuetta è stata rinvenuta nel lago Fucino, dove si credeva che essa avesse dimora, e Virgilio ricorda la presenza di un "nemus Angitiae", cioè un bosco sacro a questa divinità, nei pressi del lago.
Un testo classico relativamente recente, la deliziosa narrazione L'Asino d'oro di Apuleio(114-184 d.C.) offre una descrizione riveduta della Dea, così come fu considerata nell'Antichità. Lucio Apuleio, viaggiatore instancabile e buon conoscitore delle religioni misteriche del suo tempo, fece parlare la Dea stessa:
"Eccomi Lucio commossa dalle tue preghiere. Io sono la Natura Genitrice di tutte le cose, signora di tutti gli elementi, principio e generazione dei secoli, la più grande dei Numi, la regina dei Mani, la prima fra i Celesti, forma tipica degli Dèi e delle Dee, che governano col mio cenno le luminose vette del cielo, le salutari brezze marine, i lacrimati silenzi degli Inferi. tutto il mondo venera il mio nome, unico se pure sotto molte e diverse forme, con vario rito e con diversi nomi. I Frigi primi abitatori della Terra, mi chiamano la Pessinunzia Madre degli Dèi; gli Attici autoctoni, Cecropia Minerva; ho nome Venere Pafia presso gli abitanti dell'isola di Cipro; Diana Dittina presso i Cretesi famosi arcieri; Proserpina Stigia fra i Siculi trilingui; Vetusta Cerere fra gli Eleusini; altri mi chiaman Giunone, altri Bellona; questi Ecate e quelli Ramnusia. Ma solamente coloro che sono illuminatidai primi raggi del nascente sole, cioè gli uni e gli altri Etiopi, e gli Egiziani ammirevoli per la loro antica dottrina, mi onorano con un culto di adeguate cerimonie e mi appellano col mio vero nome di Iside Regina".
In un erbario inglese del XII secolo conservato al British Museum e citato da Robert Graves, compare un'invocazione alla Dea Madre Terra, una manifestazione neolitica della Dea Gravida Paleolitica, che si rivela molto eloquente:
"Terra, Dea divina, Madre Natura, che generi ogni cosa e sempre fai riapparire il sole di cui hai fatto dono alle genti; guardiana del cielo, del mare e di tutti gli Dèi e le potenze; per il tuo influsso tutta la natura si si acqueta e sprofonda nel sonno..E di nuovo quando ti aggrada tu mandi innanzi la lieta luce del giorno e doni nutrimento alla vita con la tua eterna promessa; e quando lo spirito dell'uomo trapassa è a te che ritorna. A buon diritto invero tu sei detta Grande Madre degli Dèi; Vittoria è il tuo nome divino. Tu sei possente, Regina degli Dèi! O Dea io ti adoro come divina, io invoco il tuo nome, degnati di concedermi ciò che ti chiedo, in modo ch'io possa in cambio colmare di grazie la Tua dinività, con la fede che ti è dovuta.."
Note
(1)Il termine Vecchia Europa, come l'ha definito Marija Gimbutas, include tutta la zona geografica che comprende l'Egeo, i Balcani, l'Europa orientale e centrale, il Mediterraneo centrale e l'Europa occidentale.
(2)Marija Gimbutas ha preso il termine da Riana Eisler, che suo libro "The Chalice and the Blade" propose di denominare "gylania" (gy, di donna e an di andros-uomo) per riferirsi alla struttura sociale nella quale i due sessi mantengono un rapporto sociale egualitario.
Testi
P.Rodriguez, Dio è nato donna, Editori Riuniti
M.Gimbutas, Il Linguaggio della Dea
R.Graves, La Dea Bianca, Adelphi
[align=right]Fonte: http://www.arcadia93.org/simbolismi_dea.html
[/align]
Ultima modifica di Hynekeniano il 23/05/2011, 10:20, modificato 1 volta in totale.
23/05/2011, 12:38
Mi piacciono ste dee..
so' sempre co' le puppe di fuori.
(scusate l'ot)
so' sempre co' le puppe di fuori.
(scusate l'ot)
23/05/2011, 13:02

IL TRONO USURPATO
Il processo di trasformazione della Dea in Dio
di Ardath Lili Sekhet Babalon
Il processo di assorbimento e di soppiantamento della Dea ad opera di un dio maschile non si verificò ovunque nello stesso modo né allo stesso ritmo, ma il risultato finì con l’essere sempre lo stesso. Se ci soffermiamo, per esempio, a considerare il pantheon sumero dell’inizio del periodo dinastico antico (circa 2850-2340 a.C), momento a partire dal quale le divinità cominciarono ad essere rappresentate sempre più antropomorfizzate, assistiamo ad un caso esemplare: dalla scena scomparvero la Gran Dea Nammu e Ki, Dea della terra.

Dea Nammu

dettaglio della Stele di UR-Nammu
I primi miti conosciuti collocavano Nammu, Ama-to-an-Ki (Madre del cielo e della terra), all’origine di tutto. Come Gran Dea, procreò per partenogenesi gli importantissimi An (o Anu), Dio del cielo, e Ki, Dea della terra, e anche tutti gli altri dèi che esistevano. Nel più antico resoconto conosciuto del pantheon religioso sumero, la Dea Ki e il suo consorte An presiedono insieme all’universo (anki significa universo) e alla totalità degli dèi; ma in un altro documento posteriore datato circa 2400 a.C., i principali dèi cosmici erano quattro nell’ordine seguente: An (cielo), Enlil dio dell’aria, figlio di An e Ki; o di An e Antu (secondo la mitologia accadica posteriore), Ninkhursag (Signora della Montagna) e Enki (o Ea), Dio dell’acqua dolce (figlio di Enlil). Possiamo osservare che sia Nammu, la Gran Dea generatrice dell’universo e madre degli dèi, che la Dea Ki, contitolare del controllo universale, erano sparite dal quadro degli dèi, anche se invece rimaneva, al terzo posto per importanza, la Dea Ninkhursag, che ancora vagamente presentava alcune caratteristiche passate della Dea. Tuttavia, alcuni secoli più tardi, verso il 2000 a.C., Ninkhursag era passata ad occupare l’ultimo posto fra gli dèi cosmici. Sebbene fosse stata una delle divinità più potenti durante il III millennio a.C., finì per essere soppiantata dal Dio Enki, che prese per moglie Ninki, Dea della Terra, per poter assorbire (appropriarsi) le funzioni della potente Ki; e allo stesso dio passarono gran parte degli attributi che aveva avuto la grande Nammu.
Il caso di Enki appare particolarmente interessante. Era un dio dell’acqua, oceano primigenio sul quale riposava la terra, ed era anche un dio del mondo sotterraneo, della sapienza, delle arti e della magia, che organizzò il mondo e che veniva ritenuto molto compassionevole verso le tribolazioni umane. Una divinità costruita utilizzando le funzioni e i simboli che erano stati esclusivi della Dea neolitica. In più il suo numero sacro era il 40, lo stesso di Antu, la moglie del Dio del cielo An. Appare evidente che Enki in un passato remoto era stata una divinità femminile o, almeno, era stata intimamente e intrinsecamente associata alla Dea neolitica.

Il Dio Enki
Abitualmente, se non generalmente, gli attributi della Dea passarono nelle mani degli dèi del vento, dell’aria o del tuono (come Enlil o Zeus) che assunsero le forme e i modi dei re di ogni territorio, mentre invece le dee assorbite venivano eliminate o degradate ad occupare posti secondari come mogli, figlie o madri (o tutti nello stesso tempo) di antichi dèi della vegetazione che erano stati in precedenza i loro figli, amanti e vittime sacrificali.
Una strategia per riuscire a degradare e soppiantare la Dea fu quella di trasformarla in una potenza o essere maligno che, in certe occasioni, a seconda della cornice religiosa dominante, veniva messa in relazione a forze infernali. Così avvenne per esempio che le terribili Gorgoni, dalla testa coperta di minacciosi serpenti (il simbolo della Dea), lunghi denti canini ed occhi enormi, che in origine furono senz’altro dee benevole. Le Gorgoni o Furie derivano da Gea, Dea Madre Terra, e formavano un trio di sorelle, identificate con la Dea Luna, i cui nomi furono: Medusa(che significava saggezza), Steno (vigore), Curiale (universalità), concetti tutti molto lontani dagli esseri mostruosi in cui le trasformarono i greci.

Gorgone
Alcuni racconti mitici sumeri presentano dee come Ereskigal, che crearono e governarono i tre mondi (regno divino, mondo umano, e regno dei morti) fintanto che un dio maschio non limitò i loro poteri e le esiliò in un mondo infernale. Ereskigal, Signora del Grande Sotto, fu considerata la sorella o il lato oscuro della potente Dea astrale Inanna (Signora del Cielo, il cui culto riuscì a sostituire perfino quello dello stesso An a Uruk ) ed entrambe avevano condiviso il dominio sul mondo superiore ed inferiore.
Quando la Dea veniva trasformata in un essere demoniaco o mostruoso, o nella protettrice di esseri di quel tipo, la si faceva abitare negli oscuri abissi delle acque primigenie, rappresentandola esattamente al contrario di come era stata fino ad allora rappresentata. Tale per esempio fu il caso della grande Dea Tiamat, vinta e rimpiazzata dal dio Marduk, un cambiamento di sesso della divinità principale, con conseguente ristrutturazione mitologica, descritto nel testo accadico Enuma Elish (circa 1750 a.C.). La Mesopotamia cadde nel II mill. a.C. sotto il dominio della città di Babilonia il cui dio tutelare era Marduk.
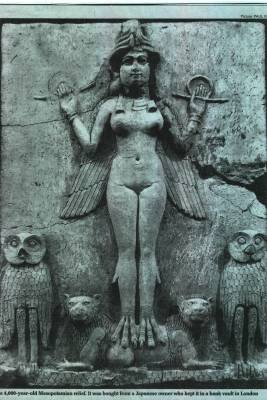
Lilith
Tutta la manipolazione fu realizzata servendosi dell’Epopea della Creazione o Enuma Elish, opera che fu redatta ex professo ed è considerata il primo esempio documentato della politica di trasformazione della divinità in demonio, in seno alle credenze culturali che venivano soppiantate dalla nuova religione dominante.
Troveremo questa stessa strategia nella religione giudaico-cristiana. Una volta postulato il monoteismo biblico, tutti gli dèi e le dee dei popoli vicini passarono ad essere visti come demoni.
La Chiesa cattolica fece altrettanto con la maggior parte delle divinità che trovò nel corso della sua espansione, anche se, quando il culto era molto radicato fra la popolazione e non era facile screditarlo, la Chiesa operò con pragmatismo e si inventò un santo o una santa che assimilò e si sovrappose al dio o alla dea originale.
Esempi di questa maniera di procedere li troviamo in San Giorgio, modello del Dio che come Murduk, lotta e vince la dea/dragone, o in santa Brigida, l’inesistente monaca inventata per sostituire il culto della dea triplice Brigit adorata dai Briganti(1).
La cultura indoeuropea trasformò in dragoni o serpenti tutte le manifestazioni della Dea che non potè assorbire, o le associò a esseri tanto potenti quanto maligni e traditori, facendo della loro persecuzione e morte la ragione della lotta protettiva degli dei guerrieri del cielo contro le forze delle tenebre.
L’accadico Marduk trionfò sui dragoni della Dea Tiamat; l’egiziano Ra lottava ogni notte contro Apofis, il serpente gigantesco del Caos che proteggeva la Dea Naunet nei suoi abissi acquatici; il greco Apollo uccise Pitone, il drago o serpente generato da Gea; l’indù Indra, dio del cielo, secondo i Veda, era in lotta perenne con il drago o demonio Vritra, figlio di Danu; e lo stesso Yahvè biblico ha un dragone come nemico.
L’immagine dell’eroe che uccide il dragone o il serpente, imposta dall’Oriente, arrivò fino alla nostra cultura religiosa attuale come simbolo della vittoria della luce e del maschile sulle tenebre e il femminile.
Nello stesso senso di demonizzazione della Dea e del femminile deve essere visto il noto racconto biblico di Eva.
L’iconografia della scena, con donna attiva e sicura di se stessa vicino all’albero (che in questo caso è della conoscenza) e un serpente, appare una rozza ed efficace degradazione del mito originale (con Dea=albero della vita e speranza di rigenerazione=serpente in virtù della femminilità) che stravolse il suo significato allegorico al fine di denigrare tutto ciò che è femminile. Col ridurre il serpente (Dea) in demonio, la Conoscenza in qualcosa di proibito e pericoloso e la donna nell’unica colpevole di tutti i mali, si chiuse il cerchio più tragico della nostra storia.
Nessun mito ha portato mai tanta sofferenza agli uomini in generale e alle donne in particolare come questo.
Accanto a quanto è stato detto deve essere aggiunto che, in ogni caso, una delle battaglie più decisive per riuscire a detronizzare la Gran Dea avvenne intorno al concetto basilare di generazione e origine dell’universo, causa di decine di cosmogonie e cosmologie che furono tanto variabili quanto gli interessi socio-politici che sostenevano i teologi che le elaborarono.

Lilith
[align=right]
Fonte: http://www.arcadia93.org/trono-usurpato.html[/align]
24/05/2011, 23:49
Kasimir ha scritto:
Mi piacciono ste dee..
so' sempre co' le puppe di fuori.
(scusate l'ot)
Non è affatto ot.... il culto della Dea Madre è, come si può immaginare, l'esatto opposto della sessuofobia cristiana patriarcale.... nel culto della Dea primigenia il sesso non è visto come "peccato", ma come fonte di vita e di gioia (quale è).
Ringrazio Hynekeniano (che non dubitavo sarebbe subito intervenuto) e Melusina (che guarda caso ha un nick che si riferisce a una delle immagini mitiche della Dea Madre) per le loro trattazioni fonti di molti interessanti argomenti che si aggiungono al mio e che mi studierò per arricchire i miei successivi post. Di carne al fuoco ne abbiamo ormai tantissima, resta solo da consumarla opportunamente... tempo permettendo!
25/05/2011, 09:40
Grazie Enki.
Ho letto tutti i post con abbastanza attenzione.
Millenni di repressione sessuale come li abbiamo subiti noi, si sentono...
Ho letto tutti i post con abbastanza attenzione.
Millenni di repressione sessuale come li abbiamo subiti noi, si sentono...
25/05/2011, 09:50
Il culto della Dea Madre in India
Autore: Lawrence Sudbury
Il culto di una “dea madre” è uno dei tratti che accomuna praticamente tutte le grandi religioni del mondo, derivando da un archetipo primario universale. Spesso, in aree in cui la religiosità ha assunto una fisionomia più strutturata e monodirezionale, tale culto ha finito per essere velato da tratti sempre più profondamente simbolici o dalla necessità di inserirsi in un contesto predefinito e “a tema”, fino a risultare quasi o totalmente irriconoscibile.
Ciò, ovviamente, non è avvenuto per una religione per molti versi “anarchica” come quella indù, in cui la caratteristica forma sincretica e aggregativa di tratti cultuali differenti[1] ha permesso il mantenimento di una chiarezza di delineamento del sistema prototipico di riferimento, tale da fungere quasi da paradigma della significazione primaria del culto stesso.

All’interno dell’Induismo, infatti, Devi, la “Femmina Divina”, riverita da qualsiasi scuola filosofico-religiosa della eterogenea tradizione indiana, è venerata come una divinità maternale, e, anzi, è addirittura meglio conosciuta proprio con il suo appellativo di “Dea Madre”. Tale culto universale viene spiegato dai Bramini come istintuale, insito in ogni essere generato che ha come primo impulso quello di amore verso chi lo genera. Così il primo uomo, a quanto pare, contemplando l’idea di divinità invisibile, guardò il volto della donna che lo aveva dato alla luce, la madre protettiva, attenta e amorevole, e scoprì in lei la “divinità assoluta”‘ e la forma manifesta dell’invisibile[2].
Conseguentemente diede a Devi, epitome celeste della maternità, un ruolo superiore nel pantheon degli dei, le eresse miriadi di templi e intesse intorno a lei innumerevoli miti ed elementi devozionali per invocare la sua protezione e il suo amore verso i “figli”. Per certi versi, questo impulso di cercare di coniugare il Divino con la madre sembra essere stato la prima esperienza dell’uomo spirituale[3].
A un certo punto della storia, forse per un più efficace svolgimento dei riti del culto, questa percezione della mente è stata trasformata in un supporto materiale: le figurine in terracotta della Dea Madre, recuperate in scavi in vari siti indù (ora in gran parte in Pakistan), sono non solo tra le prime manifestazioni tangibili di una fede resa manifesta, ma sono indicative di un ben sviluppato culto della Dea Madre databile dal 3000 a.C. al primo secolo a.C., con statuette che continuano ad essere prodotte fino all’inizio dell’era cristiana. Queste figure, fatte di argilla in modo da definire la loro parentela con la fertilità del suolo, di cui sono espressione, rappresentavano la Dea Madre come Madre Terra, con una iconografia significativa e suggestiva che comprendeva i grandi seni pieni di latte, gli organi genitali scoperti, i capelli splendidamente velati e un buon numero di braccialetti ai polsi[4]. Il significato simbolico è piuttosto chiaro: questo è l’Essere che dona, alimenta, prende tutte le calamità sulla propria testa e copre il proprio nato sotto il suo ombrello protettivo ma, al stesso tempo, definisce nel modellamento della proprie forme una assoluta bellezza estetica. Come suggeriscono i suoi bracciali, emblema tradizionale dello stato civile, oltre ad essere una madre è anche una consorte: così, nella sua manifestazione materiale, non solo viene a rappresentare la maternità assoluta ma anche, includendo il ruolo di sposa, la femminilità assoluta. In questo modo la dea diviene causa della vita e suo sostentamento e, in una estensione mistico-filosofica di tale concetto, come madre della vita diviene anche ispirazione della vita stessa e motivo di vita per i suoi fedeli.
Nella sua contemplazione nel Rig Veda, che sembra nel suo complesso avere una forte propensione per l’idea del Femminile Divino[5], la Dea Madre prende due diverse linee interpretative, una mistica e l’altro tradizionale. La linea tradizionale è la stessa che era prevalsa tra le antiche comunità induiste e che, come accennato, percepisce la Divina Femmina come divinità materna: il Rig Veda chiama il potere femminile “Mahimata”[6], termine che letteralmente significa “Madre Terra”, a tratti la letteratura vedica allude a lei come “Viraj”, la madre universale, come “Aditi”, la madre degli dei, e come “Ambhrini”, colei che è nata dall’oceano primevo. Allo stesso tempo, il Rig Veda adotta anche una linea descrittiva mistica, allorché ne tratta in congiunzione con il Proto-Maschio o “Vak-Vani” nella descrizione del processo creativo: nel misticismo vedico il cosmo e tutte le cose sono pre-esistenti ma non manifeste e il Vak-Vani le rende manifeste. Allo stesso modo, però, anche la Proto-Femmina è percepita come “Ushas”, la luce splendente delle prime ore del mattino, che rende manifesto ciò che il buio della notte rende non manifesto. Conseguentemente, nella teorizzazione metafisica della letteratura vedica si enuncia, un po’ cripticamente: “tutte le cose esistono, ma si manifestano in lei, che è, nel Proto-Maschio“[7]. L’Upanishad chiarisce questa proposizione: nella sua visione esso identifica questa Proto-Femmina vedica come “Prakriti”, la natura manifesta, che è l’aspetto materiale delle cose e che tutto pervade di quella energia cosmica che è intrinseca in ogni entità. Così, essa può essere vista come l’energia potenziale del creato, che viene posta in atto dall’azione Proto-Maschile, con un chiaro riferimento simbolico e astratto estrapolato dall’osservazione dell’atto generativo umano![Palla Otto [8]](./images/smilies/UF/icon_smile_8ball.gif) .
.
Per quanto parzialmente i Veda e in modo più massiccio l’Upanishad costruiscano intorno a Devi una sorta di corpo mistico, è, comunque, fondamentale che, di fatto, il radicamento del culto sia antichissimo e, come suggerisce l’”Harivansha Purana”, un trattato religioso del IV-V secolo, si radichi nel sentimento emotivo dell’uomo primitivo che vede la dea come signora della giungla, della natura che continuamente rifiorisce e come protettrice del villaggio a cui fornisce cibo.
Solo in un secondo tempo si avrà una sistematizzazione di tale culto naturale, una sistematizzazione che avrà il suo apice con il Mahabharata, il quale, mantenendosi in linea con il misticismo vedico, allude a lei come la fonte sia spirituale che materiale di tutte le cose. L’epopea enuncia che tutto, entità materiali e astratte, manifeste e non manifeste, sono solo manifestazioni del Divino Femminile. Secondo il Mahabharata, infatti, la Dea Madre diventa radice metafisica dello stesse esistere: lei è l’eterna difenditrice del Dharma e della verità, la promotrice di ogni felicità e colei che dona salvezza e prosperità, ma che può essere anche fonte di dolore e sofferenza[9].
Questo processo di metafisicizzazione di una istanza spontanea probabilmente finisce per rendere molto complessa l’assunzione cultuale di una divinità onminglobante all’interno del pantheon induista e, infatti, troviamo che, subito dopo il Mahabharata, al sorgere dell’era Puranica, verso il V secolo d.C., quello della Devi diventa un tema poco citato nella letteratura e l’arte d’élite. Certamente il suo resta un culto diffuso ma, fino alla elevazione della Dea Madre al rango di una divinità puranica, tale culto rimane limitato solo, o principalmente, agli angoli più remoti del mondo primitivo delle tribù, in tribù come i Santhal, i Bhumia e altri gruppi del Bihar, dell’Orissa e del Bastar che continuano, ad esempio durante le cerimonie nuziali, a definire il loro lignaggio come derivante da Devi nel suo avatar “Mahimata”, di “Terra Madre”, a seconda delle trazioni accoppiato alla divinità protettrice Shiva visto nell’avatar di “Dharini”, “il sostenitore” (in realtà, spesso è l’unione di Shiva e Devi a divenire, in una sorta di congiunzione simbiotica, emblema del sostentamento) ma, a volte, anche a Shiva visto nell’avatar di “Mahayogi”, che rappresenta il Male Divino, dando così conto di una sorta di ambivalenza ben chiara nell’inconscio collettivo dell’istanza naturale[10].
Come detto, solo dopo che viene ospitata nel pantheon brahmanico, la Dea Madre diviene oggetto di culto anche nel mondo delle élite: siamo intorno al V secolo e, in questo periodo, si nota una sorta di esplosione del tema “maternale” nella letteratura puranica: praticamente ogni testo dei Purana finisce per mettere in luce un aspetto o un altro della Dea Madre, non soltanto ragionando sulle sue qualità astratte, ma anche istituendone un culto formalizzato, nel quale essa viene invocata sì come solo Potere supremo regnante sul cosmo, ma, soprattutto, riprendendo e portando a compimento la concezione già insita nella raffigurazione della dea come “Prakriti”, come incarnazione dell’energia (procreativa) cosmica, così come appare evidente nella formula d’invocazione, “sì, o Dea che riempi e dai forma al’intero cosmo con la tua energia, noi rivolgiamo a te i nostri saluti perché tu sei oltre la nostra comprensione e così più grande di noi“[11], che le viene rivolta nel Markandeya Purana, tra tutti i testi puranici forse il più elaborato nella sua concezione della Devi e dei riti a lei connessi, tanto da essere considerato ancora oggi il documento più autentico sul culto della dea.
Di primo acchito, il Markandeya Purana sembra, dunque, allontanarsi dalla prima manifestazione della Devi come Dea Madre, o Madre Terra, ma, in realtà, la sua visione è perfettamente in continuità con la più antica tradizione della valle dell’Indo. Si tratta, al massimo, di una “fuga metafisica” dalla pura manifestazione iconica della Dea Madre come principio passivo del proto-induismo per focalizzarsi su un’ottica in cui si sottolinea il suo status attivo e operativo così come, in fondo, proprio dei miti d’origine legati alla comprensione del femminino maternale divino.
La funzione di Dea Madre Terra è, simbolicamente, molto facilmente rinvenibile soprattutto leggendo il trattato “Devi Mahatmya” del Markandeya Purana, laddove si narra di come il re Suratha e il mercante Samadhi, avendo perso rispettivamente il proprio regno e la propria attività commerciale, si rivolgano al saggio Markandeya per sapere da lui come recuperare il loro stato precedente. Dopo aver narrato il significato della Madre divina e la sua grandiosa potenza, il saggio Markandeya chiede loro di preparare un’immagine di terra della Madre Divina e di adorarla: proprio questa necessità di ricostruire il legame con la fisicità della terra ci dice di come la concezione della Devi come Madre Natura non si sia persa ma, unicamente, sia rimasta alla base di una sorta di “balzo spirituale” che estende il concetto di maternità a prospettive più astratte, metafisiche e, in fin dei conti, omninglobanti, retaggio ultimo della lettura del Mahabharata.
In questo quadro, sebbene nella letteratura puranica le convenzioni religiose, l’iconografia antropomorfa e le pratiche rituali legate alla Dea Madre siano state concepite variamente e persino variamente denominate, esiste una meravigliosa unanimità nella sua visualizzazione metafisica e nella sua percezione cosmica. Per quanto riguarda la sua percezione metafisica, sia che si incontri la sua figura in miti o leggende, in rituali o in trattati di retorica, in testi classici o nelle tradizioni popolari, o nella visione di un pittore, uno scultore o un poeta, lei è l’”Adi Shakti”, la proto-energia che comprende tutte le forme di vitalità, forza, potenza, abilità, dinamismo e facoltà operative. E’ in questa accezione, come “Adi Shakti”, che la Devi presenta nell’avatar “Prakriti”, che opera in e su tutte le cose, manifeste o meno che siano. Così essa è puro fattore dinamico del cosmo ma, al tempo stesso, come pura energia che informa l’ente, è “Dhatri”, la titolare di tutte le cose, sia statiche che in movimento, potendo anche, così, essere forza costante e ferma. In definitiva, Devi è, conseguentemente, la natura manifesta e quindi è materialmente presente, ma è anche la proiezione dell’entità possibile, come coscienza assoluta, mente pensante, Intelletto universale e potenza che controlla tutti i sensi. Essa è, così, a seconda del volto con cui presenta la propria energia universale, colei che governa il sonno, la sete, la fame, la luce, l’ombra e il buio, il pudore, la gioia, la compassione, la misericordia, la bellezza, il fascino, la fede, la pazienza, la violenza, la quiete, l’attività, il movimento e, persino, la vendetta[12].
E, sopra ognuno di questi aspetti, ciò che più di ogni altra cosa emerge è che essa è, in una percezione cosmica che deriva da una mescolanza di metafisica e mitologia, la Madre Universale di qualunque realtà visibile o pensabile: la Devi è la più pura rappresentazione formalizzata del principio di generatività e ciò si esplica apertamente proprio nella cosmologia indù. In India la percezione metafisica della creazione avviene, come si è accennato, attraverso la composizione di due fattori, variamente definiti come “Prakriti” e “Purusha”, “Shiva” e “Shakti”, “Materia” e “Conscio” maschio e femmina o simili . “Prakriti” è la materia, che in area metafisica equivale al femminino e che rappresenta l’aspetto manifesto della creazione, mentre “Purusha” è lo “spirito conscio” che rappresenta il suo aspetto non manifesto. Nella percezione più popolare, a volte questa strutturazione mitologica subisce un cambiamento: Shiva viene visto con il suo avatar “Shava”, cioè come l’entità inanimata, e Shakti viene a incarnare l’energia, che anima l’inerte con il suo potere operativo. Senza Shakti Shiva non sarebbe che massa morta, cosicché simbolicamente Shakti diventa l’energia intrinseca di tutte le cose di cui si parlava in precedenza[13]. Ancora una volta, è palese il richiamo all’atto generativo umano come atto cooperativo tra uomo e donna, semplicemente osservato da due ottiche differenti: con il principio maschile che instilla il seme primario poi sviluppato dal principio femminile nel primo caso e con il seme visto come inerte se non nutrito dal principio femminile nel secondo.
In secondo piano rispetto a questo ruolo generativo assoluto, ma pur sempre chiaramente presenti, sono altri aspetti della Devi legati al suo essere “puro femminino”.
Già il concetto primitivo della “femmina divina” sembra essere legato alla sua capacità di donare che di generare. Al dì là degli aspetti metafisici, essa appare una sorta di divinità antropomorfizzata in cui si sommano, attraverso storie leggendarie, vari aspetti della personalità che, in linea assoluta, appaiono legati dalla caratteristica di arrecare abbondanza agli uomini. Non per nulla, nei miti che la circondano, i tratti più ricorrenti sono quelli relativi alle sue azioni di carità e benevolenza[14].
Anche per quanto riguarda la sua origine, esistono innumerevoli tratti mitologici, ma due di loro sono sicuramente più diffusi e hanno assunto una maggiore rilevanza nel culto. Il primo si riferisce al suo essere sorta per vincere il male e ristabilire la giustizia e il secondo la concepisce in forma triadico/trinitaria come tutti i grandi dei centrali (sul calco della triade Brahma, Vishnu, Shiva). Conseguentemente, nel primo caso essa viene creata dalla potenza celeste degli dei, mentre nell’altro essa è sempre esistita. Vediamo come si esprimo le due leggende.
Secondo la tradizione più antica, inizialmente il demone bufalo “Mahishasura” governava la terra, ma era un demonio tirannico e infliggeva grandi sofferenze a tutte le creature, rendendone la vita miserabile. Aveva anche invaso il cielo, sede di Indra e degli altri dèi, cacciandoli dal luogo sacro ma, per un dettame di Brahma, egli era invincibile contro ogni essere maschile, animale o umano che fosse. Sapendo ciò, gli dèi decisero di cercare una femmina guerriera per eliminarlo e, non trovando nessun modello che si prestasse all’uopo, decisero di usare le proprie caratteristiche per realizzare una nuova divinità che assommasse i loro poteri. Di conseguenza, la nuova creatura venne formata con la testa modellata su quella di Shiva, i capelli ripresi da Yama e braccia, seni, vita, piedi, artigli, unghie, naso, denti, occhi, sopracciglia e orecchie, rispettivamente copiati da quelli di Vishnu, Luna, Indra, Brahma, Sole, Vasu, Kuber, Prajapati, Agni, Vayu e Alba. I suoi gioielli e ornamenti scintillanti erano dono dell’Oceano e la sua collana intarsiata di gemme celesti era quella del grande serpente Shesh. La Devi emerse con tre occhi e diciotto mani che impugnavano varie armi celesti: il tridente di Shiva, lo scudo di Vishnu, la corazza di Varuna, l’arco di Vayu, il dardo di Agni, la lancia di ferro di Yama, la faretra di Surya, il fulmine di Indra, il macete di Kuber, il rosario di Brahma, la spada di Kala, l’ascia da battaglia di Vishwakarma, etc. Himvana le diede un leone da cavalcare e tutti gli dei le si prostrarono innanzi. Dopo che Mahamuni Narada le narrò la difficile situazione degli dei, ella affrontò Mahishasura e lo uccise in poco tempo e ciò la pose al di sopra di tutto il pantheon che aveva difeso[15].
Il secondo mito appare per la prima volta nel testo chiamato “Devi Bhagawat”. Dopo il Grande Diluvio Vishnu emerse come un bambino che galleggiava su una foglia di fico. Sgomento si chiedeva quale fosse la sua origine, chi lo avesse creato e perché si trovasse lì. Improvvisamente si udì una voce celeste che gli annunciò di essere la sua origine e la sola creatura eterna. Vishnu, perplesso, si guardò intorno e vide emergere davanti a sé una donna celeste con quattro mani che sostenevano una conchiglia, uno scudo, una mazza e un loto. La donna indossava abiti e gioielli divini ed era partecipe dei poteri di ventuno dei, i più importanti dei quali erano Rati, la dea dell’amore e dell’erotismo, Bhuti, la dea della ricchezza e della prosperità, Buddhi, la dea della saggezza, Kirti, la dea della credibilità, Smriti, la dea della memoria, Nidra, il dio del sonno, Daya, la dea della compassione, Gati, il dio del movimento e del ritmo, Tusti, il dio della gioia, Pusti, il dio della crescita e dell’affermazione, Kshama, la dea della tolleranza, Lajja, la dea della grazia e Tandra, il dio della letargia. Vishnu allora capì che lei era la “Adi Shakti Mahadevi” e le s’inchinò in segno di riverenza[16].
Cerchiamo di comprendere quali simbolismi sono sottesi a queste leggende.
Nella prima tradizione mitologica, l’emergere di Devi viene collegato a Mahishasura, che rappresenta non tanto la bestia insita nell’uomo, ma piuttosto il volto umano della bestia (il bufalo) che risiede nell’animo dell’uomo, compendio ultimo del male. Ciò suggerisce il totale fallimento umano, che nessuno degli dei, dotato solo di questo o quell’attributo, rappresentanti solo di questa o quella virtù, è in grado di sanare. Solo Devi, la virtù suprema dotata di tutte le “armi”, divinità “totale”, può cambiare tale stato di cose. Lei non solo ha annientato il male e ha aperto la strada perché la virtù e il bene prevalgano, ma ha anche rivelato il mistero cosmico. Il suo essere dotata di molte armi suggerisce il suo ruolo protettivo multiforme, mentre il suo opporsi a Mahishasura, il maschio per eccellenza, portatore di energia malevola, auto-centrato e mosso dalla brama di acquisire e conquistare, sta ad indicare il ruolo di moderazione femminile che è celeste, così come dimostrato dal fatto che pur avendo diciotto braccia, la Devi ha una sola testa, ad indicare la facoltà divina di guidare ogni razza secondo il volere unico e benigno del cielo.

Il secondo mito è ancora più evidente nel suo significato: il principio maternale risulta primigenio e increato e assomma in sé una quantità di caratteristiche divine che si fondono in un unicum creativo/protettivo del genere umano che alla divinità che ne deriva deve gratitudine e riverenza.
Si è parlato di forma trinitaria della Devi: ciò riguarda soprattutto le caratteristiche attribuitele nel Purana Markandeya. Così essa è “Mahakali”, la distruttrice che sradica il male, i malvagi e i torti per ripristinare il bene e la giustizia. Come sostenitrice, essa è “Mahalakshmi” che dà felicità, prosperità, ricchezza e benessere materiale. Infine, come saggezza suprema, essa è “Mahasaraswati”, che nutre tutte le facoltà creative, l’arte, la musica, la danza e la creatività. Come Mahakali, essa viene antropomorfizzata come “Shaktirupa”, l’energia dalle molte braccia (da quattro a diciotto) che portano armi, ognuna delle quali è strumento di distruzione del male e di protezione del bene. Ma quelle stesse braccia portano, nell’avatar Mahalakshmi, anche il loto che è dono dell’acqua e della terra ed è simbolo dell’abbondanza e della vita ma che è, a sua volta, tratto distintivo dell’avatar Mahasaraswati, che proprio il loto cavalca, rendendolo anche simbolo di purezza, castità e conoscenza individuale.
E’ interessante, infine, notare come solo in epoca post-puranica, quando si diffonde maggiormente l’idea di una ricerca ascetica della verità che non debba necessariamente essere legata alla vita sociale, famigliare o al ruolo di propagazione della specie, comincia una sorta di assimilazione della divinità suprema Devi con principi maschili. Tale assimilazione avviene, nella maggioranza dei casi, nella forma classica induista dell’assunzione di una divinità come avatar di un’altra, cosicché, nella letteratura più tarda, in numerosi casi avviene che gli avatar triadici di Devi vengano attribuiti alla triade divina principale: Mahakali diventa avatar di Shiva, Mahalakshmi di Vishnu e Mahalakshmi di Brahma. In elaborazioni meno spirituali e più folkloristiche, tale processo avviene, invece, per abbassamento a divinità di livello inferiore, cosicché, ad esempio, in alcune leggende popolari Devi viene ad essere identificata con Parvati, la bianca sposa himalayana di Shiva. In ogni caso, si tratta, evidentemente, del seme di un processo di passaggio verso una società fortemente patriarcalizzata, in cui il principio del femminino sacro perde la sua valenza centrale, per essere degradato ad un ruolo secondario[17].
Resta il fatto che in una religione politeista e fortemente sincretico-inglobante come quella induista, tale processo non può svilupparsi in forma completamente compiuta, restando sempre lo spazio per la sua riemersione o per la sua riproposizione nel pantheon divino allorché i principi sia generativo che difensivo ritornano particolarmente necessari alla comunità. Non è, dunque, un caso che durante la lotta per la libertà dell’India gli induisti, prima di ogni manifestazione, usassero rivolgersi alla Devi, principio vitale della terra per cui combattevano, attraverso la recita del “Vande Mataram”, cioè del “Saluto Te, Madre”, che è la più diffusa preghiera alla dea[18].
Ovviamente, una tale ciclica riproposizione non sarebbe mai potuta avvenire in religioni più fortemente strutturate, direzionate e monoteisticamente indirizzate verso principi maschili assoluti.
[1] S. Bhaskarananda, The Essentials of Hinduism: A Comprehensive Overview of the World’s Oldest Religion, Viveka Press 2002, p.28.
[2]N.N. Bhattacharya, The Indian Mother Goddness, Manoharlal Publishers 2000, pp. 11-47 passim.
[3] Ivi
[4] D. Pattanaik, Devi/The Mother Goddess. An Introduction,Vakils Feffer And simons Pvt Ltd. 2000, pp.41 ss.
[5] W. Doniger O’Flaherty, The Rig Veda: An Anthology of One Hundred Eight Hymns, Penguin 1982, pp.7-8.
[6] Rig Veda 1.164.33.
[7] Rig Veda 3.703.11.
[8 ] E. Easwaran, The Upanishads, Nilgiri Press 2007, pp. 108-121.
[9] W. Buck, Mahabharata, University of California Press 2000, pp.19-23.
[10] N.N. Bhattacharya, Citato, pp. 136 ss.
[11] Markandeya Purana, “Mahatmya Devi”, 1.31.
[12] H. T. Bakker, Origin and Growth of the Puranic Text Corpus, Motilal Banarsidass 2004, passim.
[13] S. Krsna-Dvaipayana Vyasa, D. Goswami, Puranic Cosmology, Volume 1, Rupanuga Vedic College 2007, passim.
[14] N.N. Bhattacharya, Citato, pp. 161 ss.
[15] F. Ramen, Indian Mythology, Rosen Central2007, pp.46-49.
[16] A. Pai, Stories from the Bhagawat, India Book House 2001, pp. 38 ss.
[17] N.N. Bhattacharya, Citato, pp. 207 ss.
[18] J. Hornbay, Spirituality and Freedom. The Religious Base of the Indian Liberation Movement, Oxford U.P., 1991, pp. 87-88.
[align=right]
Fonte: http://www.centrostudilaruna.it/il-cult ... india.html[/align]
Autore: Lawrence Sudbury
Il culto di una “dea madre” è uno dei tratti che accomuna praticamente tutte le grandi religioni del mondo, derivando da un archetipo primario universale. Spesso, in aree in cui la religiosità ha assunto una fisionomia più strutturata e monodirezionale, tale culto ha finito per essere velato da tratti sempre più profondamente simbolici o dalla necessità di inserirsi in un contesto predefinito e “a tema”, fino a risultare quasi o totalmente irriconoscibile.
Ciò, ovviamente, non è avvenuto per una religione per molti versi “anarchica” come quella indù, in cui la caratteristica forma sincretica e aggregativa di tratti cultuali differenti[1] ha permesso il mantenimento di una chiarezza di delineamento del sistema prototipico di riferimento, tale da fungere quasi da paradigma della significazione primaria del culto stesso.

All’interno dell’Induismo, infatti, Devi, la “Femmina Divina”, riverita da qualsiasi scuola filosofico-religiosa della eterogenea tradizione indiana, è venerata come una divinità maternale, e, anzi, è addirittura meglio conosciuta proprio con il suo appellativo di “Dea Madre”. Tale culto universale viene spiegato dai Bramini come istintuale, insito in ogni essere generato che ha come primo impulso quello di amore verso chi lo genera. Così il primo uomo, a quanto pare, contemplando l’idea di divinità invisibile, guardò il volto della donna che lo aveva dato alla luce, la madre protettiva, attenta e amorevole, e scoprì in lei la “divinità assoluta”‘ e la forma manifesta dell’invisibile[2].
Conseguentemente diede a Devi, epitome celeste della maternità, un ruolo superiore nel pantheon degli dei, le eresse miriadi di templi e intesse intorno a lei innumerevoli miti ed elementi devozionali per invocare la sua protezione e il suo amore verso i “figli”. Per certi versi, questo impulso di cercare di coniugare il Divino con la madre sembra essere stato la prima esperienza dell’uomo spirituale[3].
A un certo punto della storia, forse per un più efficace svolgimento dei riti del culto, questa percezione della mente è stata trasformata in un supporto materiale: le figurine in terracotta della Dea Madre, recuperate in scavi in vari siti indù (ora in gran parte in Pakistan), sono non solo tra le prime manifestazioni tangibili di una fede resa manifesta, ma sono indicative di un ben sviluppato culto della Dea Madre databile dal 3000 a.C. al primo secolo a.C., con statuette che continuano ad essere prodotte fino all’inizio dell’era cristiana. Queste figure, fatte di argilla in modo da definire la loro parentela con la fertilità del suolo, di cui sono espressione, rappresentavano la Dea Madre come Madre Terra, con una iconografia significativa e suggestiva che comprendeva i grandi seni pieni di latte, gli organi genitali scoperti, i capelli splendidamente velati e un buon numero di braccialetti ai polsi[4]. Il significato simbolico è piuttosto chiaro: questo è l’Essere che dona, alimenta, prende tutte le calamità sulla propria testa e copre il proprio nato sotto il suo ombrello protettivo ma, al stesso tempo, definisce nel modellamento della proprie forme una assoluta bellezza estetica. Come suggeriscono i suoi bracciali, emblema tradizionale dello stato civile, oltre ad essere una madre è anche una consorte: così, nella sua manifestazione materiale, non solo viene a rappresentare la maternità assoluta ma anche, includendo il ruolo di sposa, la femminilità assoluta. In questo modo la dea diviene causa della vita e suo sostentamento e, in una estensione mistico-filosofica di tale concetto, come madre della vita diviene anche ispirazione della vita stessa e motivo di vita per i suoi fedeli.
Nella sua contemplazione nel Rig Veda, che sembra nel suo complesso avere una forte propensione per l’idea del Femminile Divino[5], la Dea Madre prende due diverse linee interpretative, una mistica e l’altro tradizionale. La linea tradizionale è la stessa che era prevalsa tra le antiche comunità induiste e che, come accennato, percepisce la Divina Femmina come divinità materna: il Rig Veda chiama il potere femminile “Mahimata”[6], termine che letteralmente significa “Madre Terra”, a tratti la letteratura vedica allude a lei come “Viraj”, la madre universale, come “Aditi”, la madre degli dei, e come “Ambhrini”, colei che è nata dall’oceano primevo. Allo stesso tempo, il Rig Veda adotta anche una linea descrittiva mistica, allorché ne tratta in congiunzione con il Proto-Maschio o “Vak-Vani” nella descrizione del processo creativo: nel misticismo vedico il cosmo e tutte le cose sono pre-esistenti ma non manifeste e il Vak-Vani le rende manifeste. Allo stesso modo, però, anche la Proto-Femmina è percepita come “Ushas”, la luce splendente delle prime ore del mattino, che rende manifesto ciò che il buio della notte rende non manifesto. Conseguentemente, nella teorizzazione metafisica della letteratura vedica si enuncia, un po’ cripticamente: “tutte le cose esistono, ma si manifestano in lei, che è, nel Proto-Maschio“[7]. L’Upanishad chiarisce questa proposizione: nella sua visione esso identifica questa Proto-Femmina vedica come “Prakriti”, la natura manifesta, che è l’aspetto materiale delle cose e che tutto pervade di quella energia cosmica che è intrinseca in ogni entità. Così, essa può essere vista come l’energia potenziale del creato, che viene posta in atto dall’azione Proto-Maschile, con un chiaro riferimento simbolico e astratto estrapolato dall’osservazione dell’atto generativo umano
Per quanto parzialmente i Veda e in modo più massiccio l’Upanishad costruiscano intorno a Devi una sorta di corpo mistico, è, comunque, fondamentale che, di fatto, il radicamento del culto sia antichissimo e, come suggerisce l’”Harivansha Purana”, un trattato religioso del IV-V secolo, si radichi nel sentimento emotivo dell’uomo primitivo che vede la dea come signora della giungla, della natura che continuamente rifiorisce e come protettrice del villaggio a cui fornisce cibo.
Solo in un secondo tempo si avrà una sistematizzazione di tale culto naturale, una sistematizzazione che avrà il suo apice con il Mahabharata, il quale, mantenendosi in linea con il misticismo vedico, allude a lei come la fonte sia spirituale che materiale di tutte le cose. L’epopea enuncia che tutto, entità materiali e astratte, manifeste e non manifeste, sono solo manifestazioni del Divino Femminile. Secondo il Mahabharata, infatti, la Dea Madre diventa radice metafisica dello stesse esistere: lei è l’eterna difenditrice del Dharma e della verità, la promotrice di ogni felicità e colei che dona salvezza e prosperità, ma che può essere anche fonte di dolore e sofferenza[9].
Questo processo di metafisicizzazione di una istanza spontanea probabilmente finisce per rendere molto complessa l’assunzione cultuale di una divinità onminglobante all’interno del pantheon induista e, infatti, troviamo che, subito dopo il Mahabharata, al sorgere dell’era Puranica, verso il V secolo d.C., quello della Devi diventa un tema poco citato nella letteratura e l’arte d’élite. Certamente il suo resta un culto diffuso ma, fino alla elevazione della Dea Madre al rango di una divinità puranica, tale culto rimane limitato solo, o principalmente, agli angoli più remoti del mondo primitivo delle tribù, in tribù come i Santhal, i Bhumia e altri gruppi del Bihar, dell’Orissa e del Bastar che continuano, ad esempio durante le cerimonie nuziali, a definire il loro lignaggio come derivante da Devi nel suo avatar “Mahimata”, di “Terra Madre”, a seconda delle trazioni accoppiato alla divinità protettrice Shiva visto nell’avatar di “Dharini”, “il sostenitore” (in realtà, spesso è l’unione di Shiva e Devi a divenire, in una sorta di congiunzione simbiotica, emblema del sostentamento) ma, a volte, anche a Shiva visto nell’avatar di “Mahayogi”, che rappresenta il Male Divino, dando così conto di una sorta di ambivalenza ben chiara nell’inconscio collettivo dell’istanza naturale[10].
Come detto, solo dopo che viene ospitata nel pantheon brahmanico, la Dea Madre diviene oggetto di culto anche nel mondo delle élite: siamo intorno al V secolo e, in questo periodo, si nota una sorta di esplosione del tema “maternale” nella letteratura puranica: praticamente ogni testo dei Purana finisce per mettere in luce un aspetto o un altro della Dea Madre, non soltanto ragionando sulle sue qualità astratte, ma anche istituendone un culto formalizzato, nel quale essa viene invocata sì come solo Potere supremo regnante sul cosmo, ma, soprattutto, riprendendo e portando a compimento la concezione già insita nella raffigurazione della dea come “Prakriti”, come incarnazione dell’energia (procreativa) cosmica, così come appare evidente nella formula d’invocazione, “sì, o Dea che riempi e dai forma al’intero cosmo con la tua energia, noi rivolgiamo a te i nostri saluti perché tu sei oltre la nostra comprensione e così più grande di noi“[11], che le viene rivolta nel Markandeya Purana, tra tutti i testi puranici forse il più elaborato nella sua concezione della Devi e dei riti a lei connessi, tanto da essere considerato ancora oggi il documento più autentico sul culto della dea.
Di primo acchito, il Markandeya Purana sembra, dunque, allontanarsi dalla prima manifestazione della Devi come Dea Madre, o Madre Terra, ma, in realtà, la sua visione è perfettamente in continuità con la più antica tradizione della valle dell’Indo. Si tratta, al massimo, di una “fuga metafisica” dalla pura manifestazione iconica della Dea Madre come principio passivo del proto-induismo per focalizzarsi su un’ottica in cui si sottolinea il suo status attivo e operativo così come, in fondo, proprio dei miti d’origine legati alla comprensione del femminino maternale divino.
La funzione di Dea Madre Terra è, simbolicamente, molto facilmente rinvenibile soprattutto leggendo il trattato “Devi Mahatmya” del Markandeya Purana, laddove si narra di come il re Suratha e il mercante Samadhi, avendo perso rispettivamente il proprio regno e la propria attività commerciale, si rivolgano al saggio Markandeya per sapere da lui come recuperare il loro stato precedente. Dopo aver narrato il significato della Madre divina e la sua grandiosa potenza, il saggio Markandeya chiede loro di preparare un’immagine di terra della Madre Divina e di adorarla: proprio questa necessità di ricostruire il legame con la fisicità della terra ci dice di come la concezione della Devi come Madre Natura non si sia persa ma, unicamente, sia rimasta alla base di una sorta di “balzo spirituale” che estende il concetto di maternità a prospettive più astratte, metafisiche e, in fin dei conti, omninglobanti, retaggio ultimo della lettura del Mahabharata.
In questo quadro, sebbene nella letteratura puranica le convenzioni religiose, l’iconografia antropomorfa e le pratiche rituali legate alla Dea Madre siano state concepite variamente e persino variamente denominate, esiste una meravigliosa unanimità nella sua visualizzazione metafisica e nella sua percezione cosmica. Per quanto riguarda la sua percezione metafisica, sia che si incontri la sua figura in miti o leggende, in rituali o in trattati di retorica, in testi classici o nelle tradizioni popolari, o nella visione di un pittore, uno scultore o un poeta, lei è l’”Adi Shakti”, la proto-energia che comprende tutte le forme di vitalità, forza, potenza, abilità, dinamismo e facoltà operative. E’ in questa accezione, come “Adi Shakti”, che la Devi presenta nell’avatar “Prakriti”, che opera in e su tutte le cose, manifeste o meno che siano. Così essa è puro fattore dinamico del cosmo ma, al tempo stesso, come pura energia che informa l’ente, è “Dhatri”, la titolare di tutte le cose, sia statiche che in movimento, potendo anche, così, essere forza costante e ferma. In definitiva, Devi è, conseguentemente, la natura manifesta e quindi è materialmente presente, ma è anche la proiezione dell’entità possibile, come coscienza assoluta, mente pensante, Intelletto universale e potenza che controlla tutti i sensi. Essa è, così, a seconda del volto con cui presenta la propria energia universale, colei che governa il sonno, la sete, la fame, la luce, l’ombra e il buio, il pudore, la gioia, la compassione, la misericordia, la bellezza, il fascino, la fede, la pazienza, la violenza, la quiete, l’attività, il movimento e, persino, la vendetta[12].
E, sopra ognuno di questi aspetti, ciò che più di ogni altra cosa emerge è che essa è, in una percezione cosmica che deriva da una mescolanza di metafisica e mitologia, la Madre Universale di qualunque realtà visibile o pensabile: la Devi è la più pura rappresentazione formalizzata del principio di generatività e ciò si esplica apertamente proprio nella cosmologia indù. In India la percezione metafisica della creazione avviene, come si è accennato, attraverso la composizione di due fattori, variamente definiti come “Prakriti” e “Purusha”, “Shiva” e “Shakti”, “Materia” e “Conscio” maschio e femmina o simili . “Prakriti” è la materia, che in area metafisica equivale al femminino e che rappresenta l’aspetto manifesto della creazione, mentre “Purusha” è lo “spirito conscio” che rappresenta il suo aspetto non manifesto. Nella percezione più popolare, a volte questa strutturazione mitologica subisce un cambiamento: Shiva viene visto con il suo avatar “Shava”, cioè come l’entità inanimata, e Shakti viene a incarnare l’energia, che anima l’inerte con il suo potere operativo. Senza Shakti Shiva non sarebbe che massa morta, cosicché simbolicamente Shakti diventa l’energia intrinseca di tutte le cose di cui si parlava in precedenza[13]. Ancora una volta, è palese il richiamo all’atto generativo umano come atto cooperativo tra uomo e donna, semplicemente osservato da due ottiche differenti: con il principio maschile che instilla il seme primario poi sviluppato dal principio femminile nel primo caso e con il seme visto come inerte se non nutrito dal principio femminile nel secondo.
In secondo piano rispetto a questo ruolo generativo assoluto, ma pur sempre chiaramente presenti, sono altri aspetti della Devi legati al suo essere “puro femminino”.
Già il concetto primitivo della “femmina divina” sembra essere legato alla sua capacità di donare che di generare. Al dì là degli aspetti metafisici, essa appare una sorta di divinità antropomorfizzata in cui si sommano, attraverso storie leggendarie, vari aspetti della personalità che, in linea assoluta, appaiono legati dalla caratteristica di arrecare abbondanza agli uomini. Non per nulla, nei miti che la circondano, i tratti più ricorrenti sono quelli relativi alle sue azioni di carità e benevolenza[14].
Anche per quanto riguarda la sua origine, esistono innumerevoli tratti mitologici, ma due di loro sono sicuramente più diffusi e hanno assunto una maggiore rilevanza nel culto. Il primo si riferisce al suo essere sorta per vincere il male e ristabilire la giustizia e il secondo la concepisce in forma triadico/trinitaria come tutti i grandi dei centrali (sul calco della triade Brahma, Vishnu, Shiva). Conseguentemente, nel primo caso essa viene creata dalla potenza celeste degli dei, mentre nell’altro essa è sempre esistita. Vediamo come si esprimo le due leggende.
Secondo la tradizione più antica, inizialmente il demone bufalo “Mahishasura” governava la terra, ma era un demonio tirannico e infliggeva grandi sofferenze a tutte le creature, rendendone la vita miserabile. Aveva anche invaso il cielo, sede di Indra e degli altri dèi, cacciandoli dal luogo sacro ma, per un dettame di Brahma, egli era invincibile contro ogni essere maschile, animale o umano che fosse. Sapendo ciò, gli dèi decisero di cercare una femmina guerriera per eliminarlo e, non trovando nessun modello che si prestasse all’uopo, decisero di usare le proprie caratteristiche per realizzare una nuova divinità che assommasse i loro poteri. Di conseguenza, la nuova creatura venne formata con la testa modellata su quella di Shiva, i capelli ripresi da Yama e braccia, seni, vita, piedi, artigli, unghie, naso, denti, occhi, sopracciglia e orecchie, rispettivamente copiati da quelli di Vishnu, Luna, Indra, Brahma, Sole, Vasu, Kuber, Prajapati, Agni, Vayu e Alba. I suoi gioielli e ornamenti scintillanti erano dono dell’Oceano e la sua collana intarsiata di gemme celesti era quella del grande serpente Shesh. La Devi emerse con tre occhi e diciotto mani che impugnavano varie armi celesti: il tridente di Shiva, lo scudo di Vishnu, la corazza di Varuna, l’arco di Vayu, il dardo di Agni, la lancia di ferro di Yama, la faretra di Surya, il fulmine di Indra, il macete di Kuber, il rosario di Brahma, la spada di Kala, l’ascia da battaglia di Vishwakarma, etc. Himvana le diede un leone da cavalcare e tutti gli dei le si prostrarono innanzi. Dopo che Mahamuni Narada le narrò la difficile situazione degli dei, ella affrontò Mahishasura e lo uccise in poco tempo e ciò la pose al di sopra di tutto il pantheon che aveva difeso[15].
Il secondo mito appare per la prima volta nel testo chiamato “Devi Bhagawat”. Dopo il Grande Diluvio Vishnu emerse come un bambino che galleggiava su una foglia di fico. Sgomento si chiedeva quale fosse la sua origine, chi lo avesse creato e perché si trovasse lì. Improvvisamente si udì una voce celeste che gli annunciò di essere la sua origine e la sola creatura eterna. Vishnu, perplesso, si guardò intorno e vide emergere davanti a sé una donna celeste con quattro mani che sostenevano una conchiglia, uno scudo, una mazza e un loto. La donna indossava abiti e gioielli divini ed era partecipe dei poteri di ventuno dei, i più importanti dei quali erano Rati, la dea dell’amore e dell’erotismo, Bhuti, la dea della ricchezza e della prosperità, Buddhi, la dea della saggezza, Kirti, la dea della credibilità, Smriti, la dea della memoria, Nidra, il dio del sonno, Daya, la dea della compassione, Gati, il dio del movimento e del ritmo, Tusti, il dio della gioia, Pusti, il dio della crescita e dell’affermazione, Kshama, la dea della tolleranza, Lajja, la dea della grazia e Tandra, il dio della letargia. Vishnu allora capì che lei era la “Adi Shakti Mahadevi” e le s’inchinò in segno di riverenza[16].
Cerchiamo di comprendere quali simbolismi sono sottesi a queste leggende.
Nella prima tradizione mitologica, l’emergere di Devi viene collegato a Mahishasura, che rappresenta non tanto la bestia insita nell’uomo, ma piuttosto il volto umano della bestia (il bufalo) che risiede nell’animo dell’uomo, compendio ultimo del male. Ciò suggerisce il totale fallimento umano, che nessuno degli dei, dotato solo di questo o quell’attributo, rappresentanti solo di questa o quella virtù, è in grado di sanare. Solo Devi, la virtù suprema dotata di tutte le “armi”, divinità “totale”, può cambiare tale stato di cose. Lei non solo ha annientato il male e ha aperto la strada perché la virtù e il bene prevalgano, ma ha anche rivelato il mistero cosmico. Il suo essere dotata di molte armi suggerisce il suo ruolo protettivo multiforme, mentre il suo opporsi a Mahishasura, il maschio per eccellenza, portatore di energia malevola, auto-centrato e mosso dalla brama di acquisire e conquistare, sta ad indicare il ruolo di moderazione femminile che è celeste, così come dimostrato dal fatto che pur avendo diciotto braccia, la Devi ha una sola testa, ad indicare la facoltà divina di guidare ogni razza secondo il volere unico e benigno del cielo.

Il secondo mito è ancora più evidente nel suo significato: il principio maternale risulta primigenio e increato e assomma in sé una quantità di caratteristiche divine che si fondono in un unicum creativo/protettivo del genere umano che alla divinità che ne deriva deve gratitudine e riverenza.
Si è parlato di forma trinitaria della Devi: ciò riguarda soprattutto le caratteristiche attribuitele nel Purana Markandeya. Così essa è “Mahakali”, la distruttrice che sradica il male, i malvagi e i torti per ripristinare il bene e la giustizia. Come sostenitrice, essa è “Mahalakshmi” che dà felicità, prosperità, ricchezza e benessere materiale. Infine, come saggezza suprema, essa è “Mahasaraswati”, che nutre tutte le facoltà creative, l’arte, la musica, la danza e la creatività. Come Mahakali, essa viene antropomorfizzata come “Shaktirupa”, l’energia dalle molte braccia (da quattro a diciotto) che portano armi, ognuna delle quali è strumento di distruzione del male e di protezione del bene. Ma quelle stesse braccia portano, nell’avatar Mahalakshmi, anche il loto che è dono dell’acqua e della terra ed è simbolo dell’abbondanza e della vita ma che è, a sua volta, tratto distintivo dell’avatar Mahasaraswati, che proprio il loto cavalca, rendendolo anche simbolo di purezza, castità e conoscenza individuale.
E’ interessante, infine, notare come solo in epoca post-puranica, quando si diffonde maggiormente l’idea di una ricerca ascetica della verità che non debba necessariamente essere legata alla vita sociale, famigliare o al ruolo di propagazione della specie, comincia una sorta di assimilazione della divinità suprema Devi con principi maschili. Tale assimilazione avviene, nella maggioranza dei casi, nella forma classica induista dell’assunzione di una divinità come avatar di un’altra, cosicché, nella letteratura più tarda, in numerosi casi avviene che gli avatar triadici di Devi vengano attribuiti alla triade divina principale: Mahakali diventa avatar di Shiva, Mahalakshmi di Vishnu e Mahalakshmi di Brahma. In elaborazioni meno spirituali e più folkloristiche, tale processo avviene, invece, per abbassamento a divinità di livello inferiore, cosicché, ad esempio, in alcune leggende popolari Devi viene ad essere identificata con Parvati, la bianca sposa himalayana di Shiva. In ogni caso, si tratta, evidentemente, del seme di un processo di passaggio verso una società fortemente patriarcalizzata, in cui il principio del femminino sacro perde la sua valenza centrale, per essere degradato ad un ruolo secondario[17].
Resta il fatto che in una religione politeista e fortemente sincretico-inglobante come quella induista, tale processo non può svilupparsi in forma completamente compiuta, restando sempre lo spazio per la sua riemersione o per la sua riproposizione nel pantheon divino allorché i principi sia generativo che difensivo ritornano particolarmente necessari alla comunità. Non è, dunque, un caso che durante la lotta per la libertà dell’India gli induisti, prima di ogni manifestazione, usassero rivolgersi alla Devi, principio vitale della terra per cui combattevano, attraverso la recita del “Vande Mataram”, cioè del “Saluto Te, Madre”, che è la più diffusa preghiera alla dea[18].
Ovviamente, una tale ciclica riproposizione non sarebbe mai potuta avvenire in religioni più fortemente strutturate, direzionate e monoteisticamente indirizzate verso principi maschili assoluti.
[1] S. Bhaskarananda, The Essentials of Hinduism: A Comprehensive Overview of the World’s Oldest Religion, Viveka Press 2002, p.28.
[2]N.N. Bhattacharya, The Indian Mother Goddness, Manoharlal Publishers 2000, pp. 11-47 passim.
[3] Ivi
[4] D. Pattanaik, Devi/The Mother Goddess. An Introduction,Vakils Feffer And simons Pvt Ltd. 2000, pp.41 ss.
[5] W. Doniger O’Flaherty, The Rig Veda: An Anthology of One Hundred Eight Hymns, Penguin 1982, pp.7-8.
[6] Rig Veda 1.164.33.
[7] Rig Veda 3.703.11.
[8 ] E. Easwaran, The Upanishads, Nilgiri Press 2007, pp. 108-121.
[9] W. Buck, Mahabharata, University of California Press 2000, pp.19-23.
[10] N.N. Bhattacharya, Citato, pp. 136 ss.
[11] Markandeya Purana, “Mahatmya Devi”, 1.31.
[12] H. T. Bakker, Origin and Growth of the Puranic Text Corpus, Motilal Banarsidass 2004, passim.
[13] S. Krsna-Dvaipayana Vyasa, D. Goswami, Puranic Cosmology, Volume 1, Rupanuga Vedic College 2007, passim.
[14] N.N. Bhattacharya, Citato, pp. 161 ss.
[15] F. Ramen, Indian Mythology, Rosen Central2007, pp.46-49.
[16] A. Pai, Stories from the Bhagawat, India Book House 2001, pp. 38 ss.
[17] N.N. Bhattacharya, Citato, pp. 207 ss.
[18] J. Hornbay, Spirituality and Freedom. The Religious Base of the Indian Liberation Movement, Oxford U.P., 1991, pp. 87-88.
[align=right]
Fonte: http://www.centrostudilaruna.it/il-cult ... india.html[/align]
Ultima modifica di Hynekeniano il 25/05/2011, 09:51, modificato 1 volta in totale.
25/05/2011, 10:06
Un culto della dea madre all’origine della religione greca?
Autore: Lawrence Sudbury
È possibile parlare di “femminino sacro” e di “culto della dea madre” nella cultura greca classica?
A dare uno sguardo al pantheon ellenico si sarebbe immediatamente tentati di rispondere negativamente: pur essendo presenti divinità sia maschili che femminili, queste ultime rivestono sempre ruoli che, dal punto di vista dell’”imperium” sugli esseri umani, sono considerabili subalterni, chiaro rispecchiamento di una società in cui la donna aveva un ruolo da “comprimario”, limitato quasi unicamente alle funzioni di moglie e madre[1].
Se, però, ampliamo il nostro terreno di analisi fino ad includere il periodo arcaico, l’ottica muta radicalmente.
Prima di procedere ad una ricognizione, seppur sommaria, di tale periodo, è, però, necessario effettuare una disamina relativa ai termini definitori che devono muovere il nostro approccio, a partire da una domanda fondamentale: che cosa si intende quando si identifica una divinità femminile come dea madre? Significa che le si attribuisce il compito di nutrire e proteggere i giovani? Che la si vede come dea del parto? Che è una dea creatrice o la dea della terra (in genere conosciuto come Terra Madre)? O vuol dire che è la dea della natura e della fertilità? Probabilmente proprio quest’ultima definizione risulta essere la più comune ma il termine “fertilità” è di per sé piuttosto vago e può comportare un certo numero di elementi diversi: fertilità potrebbe significare la terra stessa, per esempio, nel senso di fertilità del terreno, oppure potrebbe essere riferita alla coltivazione dei prodotti agricoli o alla vita delle piante, ma potrebbe anche significare la fertilità degli animali, così come degli esseri umani, riferendosi all’accoppiamento o ai rapporti sessuali[2].
Di fatto, tutte queste definizioni sono, allo stesso tempo, adeguate ma parziali nel momento in cui la dea madre può assumere ruoli anche molto diversi, tanto che, solo per fare un esempio, in tutte le mitologie troviamo una notevole confusione tra dea madre e Madre Terra (dea della terra).
In linea generale, l’elemento definitorio di “livello 0#8243;, il minimo comun denominatore che unisce tutti gli attributi della dea madre è dato dal suo essere forza primordiale e sorgente di tutta la vita, sebbene non necessariamente legata alla creazione della vita e al suo nutrimento (ad esempio, in molti casi riscontriamo come caratteristica principale non la generatività ma il mantenimento dell’esistente, in particolare in correlazione ad un determinato gruppo sociale, etnico, tribale o persino ad una determinata gerarchia divina)[3].
Mantenendo una definizione ampia come quella appena espressa, possiamo notare come, in realtà, evidenti reminiscenze di un culto maternale siano ben presenti anche in periodo greco-classico, sebbene con una sorta di “frantumazione” delle caratteristiche ataviche proprie di tale culto e una loro ri-attribuzione a divinità diverse, per molti versi chiaramente depotenziate rispetto all’originale dall’essere portatrici di una sola caratteristica per ciascuna, probabilmente in un tentativo da parte della componente maschile socialmente dominante di attenuare il potere insito nella divinità femminina.
Abbiamo così, ad esempio:
- Gea, a cui vengono attribuite le caratteristiche proprie del culto della madre terra in senso stretto;
- Rea, che riprende l’idea di “mater deorum”, portando la figura maternale ad un livello sacrale primigenio;
- Cibele, che incarna l’aspetto generativo sessuale con il suo rituale d’accoppiamento che rinnova le stagioni della natura;
- Demetra, che riunisce in sé sia le caratteristiche del nutrimento dei mortali (come dea del grano), della cura dei figli e della fertilità naturale[4].
L’elenco potrebbe proseguire, ma ciò che conta è rendersi conto che non siamo di fronte a “doppioni”, divinità con caratteristiche analoghe, quanto, piuttosto, a frammenti rimanenti, eredità frantumate di una concezione teologica precedente, preesistente e fondativa.
Alla ricerca del nucleo mitologemetico primario, dobbiamo, allora, spingerci verso un’epoca antecedente all’invasione dorica, fino a quell’età del bronzo delle civiltà dell’Egeo in cui si sviluppano le basi delle concezioni religiose successive.
Si tratta, tuttavia, di un’impresa ardua: di quel periodo abbiamo solo pochissime fonti, non sviluppate in forma letteraria e, perlopiù, siamo in possesso unicamente di nomi di divinità rinvenuti sulle tavole lineare B di Cnosso e di Pilo, solo pochi dei quali sono sopravvissuti fin al periodo classico, essendo la maggior parte, soprattutto per quanto riguarda le divinità locali, totalmente irriconoscibili per noi oggi.
E’, comunque, estremamente significativa la presenza ripetitiva in molte tavolette in lineare B di Pilo della dicitura MA-TE-RE TE-I-JA, o “Theia Mater”, che, significa proprio “Dea Madre”. Purtroppo, però, possiamo solo immaginare le caratteristiche di questa divinità.
Un aiuto considerevole per la comprensione del pantheon arcaico ci può essere fornito dall’arte tramite i reperti archeologici e, seppur per alcune figure femminili risulti difficile stabilire se raffigurino una dea, una sacerdotessa o una governante femminile, l’enorme presenza di statuette e immagini votive femminili pre-doriche può addirittura far supporre che a Creta la civiltà minoica adorasse prevalentemente o solo dee o, secondo una recente interpretazione, addirittura una sola divinità femminile dal potere illimitato (il lineare B, nel palazzo di Cnosso ha mostrato i nomi di alcune divinità maschili, come Zeus, Poseidone e Ares, ma è emerso che la datazione di questi scritti è certamente posteriore all’invasione micenea, intorno al 1450 a.C.). Si tratta, certamente, solo di speculazioni che tali resteranno fino a che non verrà completamente decifrato il lineare minoico, ma, in ogni caso, gli indizi a riguardo sembrano piuttosto concreti[5].
In particolare, molto interessanti risultano gli studi effettuati sulla “Potnia”, la dea più importante e incontrastata del Mediterraneo nell’età del bronzo, raffigurata in tutta l’area mediorientale ma con particolare frequenza proprio a Creta.
Da quanto possiamo comprendere, PO-TI-NI-JA o “Potnia” risulta essere più un titolo che un nome: il significato sarebbe stato “signora” o “padrona” e, in sostanza, si sarebbe trattato di un esempio classico di “dea madre” a tutto tondo.
Nelle tavolette di Cnosso e Pilo il termine “potnia” è spesso associato ad epiteti diversi, tanto che si è a lungo discusso se tali epiteti indicassero divinità diverse o fossero tutti attributi della stessa dea. In particolare, a Cnosso è stato possibile rinvenire le seguenti specificazioni:
- A-TA-NA PO-TI-NI-JA (Atana Potnia);
- DA-PU-RI-TO-PO-JO-NI-TI (“Signora del Labirinto”);
- (PO-TI-NI-) JA A-SI-WI-JA (Potnia Aswia).
A Pilo, invece, troviamo:
- PO-TI-NI-JA I-QE-JA (Potnia Hikkweia o “Signora dei cavalli);
- PA-KI-JA-NI-JA (forse Potnia Sphagianeia);
-A-SI-WI-JA (ancora Potnia Aswia);
- PO-TI-NI-JA NE-WO-PE-O;
- MA-TE-RE TE-I-JA (la Theia Mater già menzionata, letteralmente “madre divina”, che è la prova più certa di un culto maternale in epoca arcaica).
Infine, in epoca più tarda, sparse in varie località dell’oriente mediterraneo, troviamo iscrizioni riguardanti una PO-TI-NI-JA THE-RON, (Potnia Theron) una “Signora degli animali”, il cui culto si diffuse certamente in periodo miceneo come evidente derivazione di culti precedenti.
Abbiamo la certezza che due di queste divinità (o due di questi attributi di divinità), la Potnia Sphagianeia e la Potnia Newopeo fossero, in realtà, semplicemente rappresentazioni locali della Potnia, essendo “Sphagianeia” e “Newopeo” non aggettivi ma locativi. Per le altre rappresentazioni, però, le nostre sicurezze, allo stato dell’arte, sono molto minori[6].
Due di tali rappresentazioni, comunque, appaiono particolarmente interessanti nel quadro che stiamo delineando: la “Potnia Theron” e la “Atana Potnia”.
La Potnia Theron è la figura che si trova più comunemente (forse anche per il suo sorgere più tardo), sia nell’arte minoica che in quella micenea rispetto a qualsiasi altra Potnia. Era anche conosciuta come “Signora delle cose selvagge”, “Signora delle fiere”, o con molti altri titoli simili.
La Potnia Theron era una dea della natura, soprattutto degli animali selvatici e domestici: era lei a controllare le forze naturali e a sottometterle, a suo piacimento, al volere degli uomini.
Il culto della Signora degli animali non si limitava alla Creta minoica e alla Grecia continentale: divinità simili (o declinazioni della medesima divinità) sono rappresentate nei manufatti artistici di tutto il Vicino Oriente, dalla antica Siria a Babilonia, facendo pensare a influenze culturali derivanti da legami commerciali delle aree orientali più prospere in particolare con Creta.
Soprattutto nelle zone mediorientali, la Signora degli animali è spesso raffigurata nuda, affiancata da entrambi i lati da animali che in in gran parte delle rappresentazioni tiene vicino a sé afferrandoli con entrambe le mani per le orecchie, per la gola o per le zampe posteriori, mentre in altri momenti viene raffigurata in piedi sul dorso di uno di essi: in entrambi i casi il significato simbolico relativo al suo potere di sottomettere le forze più selvagge della natura è chiarissimo.
Ciò che per noi è fondamentale è confrontare queste raffigurazioni con la immagine di Artemide sul “Vaso François” del IV secolo a.C.: su di esso è rappresentata la dea Artemide che tiene un leone e un cervo per la gola e, sebbene Artemide appaia vestita con un abito lungo a differenza sua controparte orientale, è impossibile non vedere una profonda analogia tra il suo ruolo di dea della caccia, dei boschi e degli animali selvatici e quello della Signora degli animali.
Cosa è accaduto tra le due rappresentazioni? Evidentemente un processo di depotenziamento che si esprime nell’annullamento di qualsiasi connotazione sessuale femminile: la nudità (procreatrice) viene coperta, Artemide diventa “vergine” e il suo potere sulla natura diventa predatorio (la caccia) e non rigenerativo (il dominio sulla natura della Potnia). Anche in termini di contestualizzazione si assiste allo stesso processo: la dea cacciatrice Artemide viene normalmente raffigurata con altre donne o ninfe, mentre la Signora degli animali veniva spesso vista in compagnia di una figura maschile, di solito un sovrano mortale o un guerriero, risultando, infatti, patrona dei giovani soldati pronti all’iniziazione sia bellica che amorosa e, come tale, essendo adorata a Sparta, dove era la divinità che presiedeva alla iniziazione dei ragazzi in giovani guerrieri[7].
Un processo analogo di depotenziamento si ha nei confronti della Atana Potnia delle tavolette in lineare B di Cnosso, che, con altissimo grado di probabilità, corrisponde alla Theia Mater di Pilo, venendo a rappresentare in termini molto più evidenti della Potnia Theron la figura classica della “dea madre”: era, infatti, la dea della fertilità di piante e animali (esseri umani compresi) e, forse, in un connubio che risulta particolarmente difficile da spiegare, madre delle montagne (i suoi santuari erano tutti su cime di monti), forse per una visione atavica delle catene montuose come “spina dorsale della terra”.
Come si è accennato, nel periodo classico i suoi attributi vengono frantumati e suddivisi tra Rea, Demetra, Artemide e la Cibele frigia, ma alcuni studiosi ritengono, a partire dalle similitudini nel nome, che l’erede diretta di Atana potesse essere Atena, nel qual caso, tenendo conto della verginità della dea della saggezza, saremmo di nuovo di fronte a una “de-sessualizzazione” della divinità ad opera della società dorica e post-dorica che riflette nella sua riflessione religiosa le componenti maschiliste predominanti di un assetto sociale che pone l’aspetto guerriero al primo posto e che deve, conseguentemente, mettere in ombra qualunque assunto legato al potere generativo femminile![Palla Otto [8]](./images/smilies/UF/icon_smile_8ball.gif) .
.
Possiamo ritenere che la Potnia Theron e l’Atana Potnia fossero la stessa divinità declinata in due forme differenti? Ancora una volta è necessario ricordare che non esistono, per mancanza di fonti, prove risolutive in questo senso. Ciò detto, è altresì vero che esiste una possibilità, almeno in via ipotetica, di suffragare l’identità tra le due divinità (peraltro di epoche, come detto, diverse) attraverso la figura della cosiddetta “dea dei serpenti”[9].

Nel 1903 l’archeologo Sir Arthur Evans, scoprì, all’interno di quello che doveva essere probabilmente un tempio nel palazzo di Cnosso, due statuette di donna molto simili tra loro ed entrambi databili attorno al 1700 a.C. In tutti e due i casi la donna aveva in mano serpenti, la qual cosa, essendo particolarmente insolita, ha dato la stura ad una ridda di ipotesi diverse: alcuni hanno suggerito che si tratti semplicemente della raffigurazione di una incantatrice di serpenti, altri hanno pensato ad una sacerdotessa ma la maggior parte degli studiosi sono propensi a credere che i due manufatti siano immagini votive di una divinità.
Le due statuette sono molto simili.
Una figurina mostra una donna in abito insolito con balze sovrapposte e con i seni scoperti, che indossa un cappello con un gatto seduto sulla parte superiore e che in ogni mano tiene un piccolo serpente. Quest’ultimo particolare rimanda immediatamente alla Potnia Theron, ma l’elemento dei seni scoperti è un evidente attributo della Atana Potnia, con il suo chiaro riferimento all’ambito sessuale-generativo e all’allattamento degli esseri viventi. Anche i serpenti risultano simboli della “dea madre”, nella loro associazione alla vita e alla guarigione dai mali, mentre il gatto sul cappello viene perlopiù interpretato come un riferimento all’aldilà.
L’altra statuetta è leggermente più alta e indossa un diverso tipo di abito, ma come nella prima, il seno è scoperto e si ha sul capo un cappello molto alto da cui spunta una testa di serpente il cui corpo si dipana lungo il braccio destro della donna, sulle spalle, lungo un lato della schiena fino alle natiche e poi su l’altro lato della schiena, sulla spalla sinistra e intorno al braccio sinistro, con la coda nella mano sinistra della figura.
Anche in questo caso la simbolicità fallico-generativa e di alimentazione del genere umano è evidente e, anzi, si fa più insistita che nel manufatto precedente, tanto che, se non fosse per quella coda afferrata con la sinistra, come detto richiamo piuttosto lampante alla Potnia Theron, potremmo ritenere il tutto una raffigurazione standardizzata della Atana Potnia.
Ovviamente, ciò che risulta più interessante è l’unione in una sola raffigurazione delle caratteristiche di due divinità che dai testi delle tavolette potrebbero apparire distinte. La domanda che sorge spontanea è se, invece, non dovremmo parlare di una divinità suprema unica e “multiforme”, capace di assumere caratteristiche diverse a seconda dell’interpretazione del concetto di “fertilità” che le si vuole attribuire e che viene specificata, per iscritto, dall’aggettivizzazione del termine “Potnia”.
Ovviamente, si tratta di una domanda che, come detto, attende ancora risposta dalla decifrazione del lineare minoico, ma, indubbiamente, dal punto di vista dell’analisi simbolica, le prove indiziarie che portano a ipotizzare un culto primario e archetipico monoteistico della dea madre sussistono.
A questo punto potremmo chiederci se una “dea dei serpenti” è rinvenibile anche nel pantheon post-dorico. Le ipotesi di derivazione sono state numerose e riguardano molte divinità a cui si è già accennato, da Artemide ad Atena, da Rea a Cibele. In realtà, però, nessuna di esse ha come tratto caratteristico il serpente: per trovare un rettile come tratto simbolico distintivo dobbiamo, piuttosto, rifarci alle poche divinità tardo-cretesi sopravvissute nel periodo classico, quali la dea del parto Eleuthia, la dea della guerra Enyo e, soprattutto, la dea della natura e della caccia Britomartis, che potrebbe essere addirittura una filiazione diretta proprio della dea dei serpenti.
Il nome Britomartis significa “dolce signora” e la dea era, appunto nella mitologia tardo-cretese, figlia di Zeus e di Carme, a sua volta figlia di Eubulo. Nata a Caeno sull’isola di Creta, Britomartis era una delle ninfe cacciatrici compagne di Artemide e, come la sua divinità principale, voleva rimanere vergine. Un giorno, però, narra la leggenda mitologica, Minosse, re di Creta, la vide e si innamorò di lei. Britomartis non voleva avere niente a che fare con il re, soprattutto considerando che egli era suo fratellastro (in quanto figlio di Zeus e Europa): Minosse la inseguì a lungo, senza mai riuscire a catturarla, fino al giorno in cui il re riuscì a chiudere l’amata in una sorta di vicolo cieco, con una scogliera alle spalle. Piuttosto che farsi catturare, però, la ninfa si gettò in mare, dove venne salvata da alcuni pescatori che la raccolsero nelle loro reti. Per la dedizione alla castità dimostrata, Artemide decise di premiarla, donandole l’immortalità e attribuendole il titolo di “Dictynna”, che significa la “Signora delle reti”.
Anche in questo caso (e persino in modo più esplicito di quanto rilevato in precedenza), è evidente il tentativo di depotenziamento simbolico della divinità. In primo luogo, essa viene desessualizzata radicalmente, eliminando il pericolo insito nella potenza generativa dell’”antenata” Atana e, anzi, rendendola una paladina della castità sterile in contrapposizione alla figura maschile di Minosse (che diventa egli stesso simbolo generativo, assumendo su di sé il “potere” che da ciò deriva). In secondo luogo, si amplificano gli attributi della Theron signora degli animali, fino a nascondere completamente le caratteristiche della Atana che, ipoteticamente, potevano compenetrarsi con tali attributi in una divinità unica (c’è anche chi sostiene, seppur senza prove concrete, che tale divinità sia ricordata in un paio di tavolette in lineare con l’aggettivo PI-PI-TU-NA[10]). In terzo luogo, si sminuisce persino la forza intrinseca della divinità, rendendola un alterego subalterno di Artemide, della quale possiede le medesime caratteristiche al punto tale da ingenerare confusione tra le due divinità (tanto che si arrivò a costruire santuari di “Artemide Diktynna” a Chania e Cherson).
Restano, però, pur dopo questo lavorio simbolico culturale, tracce evidenti della derivazione primigenia: non solo la simbolicità delle numerose rappresentazioni di Britomartis in compagnia di uno o più serpenti costituisce un rimando diretto piuttosto ineludibile alla Potnia, ma persino il suo titolo di “Diktynna” è, in realtà, non un collegamento a ipotetiche reti da pesca (l’intera leggenda del salvataggio in mare presenta tratti che fanno percepire un tentativo di costruire spiegazioni del titolo a posteriori, tanto che, in altre versioni, Britomartis diviene signora delle reti da caccia e non da pesca), quanto al Monte Dicte, una montagna cretese dove, guarda caso, spesso venivano tenuti i giochi di Artemide e che, originariamente, ospitava un santuario dedicato proprio alla Atana Potnia[11].
Sono questi elementi che ci permettono di rispondere in forma dubitativa al nostro quesito iniziale: possiamo pensare che alla radice ultima della religione ellenica, poi sviluppata in forma chiaramente maschilista dopo l’invasione dorica, potesse esistere un culto, politeistico o monoteistico, di divinità maternali, dissolto in seguito ad un intenso lavorio culturale di depotenziamento delle caratteristiche generative femminili? Allo stato delle ricerche possiamo rispondere con un “forse”. Ma, alla luce di quanto visto fino ad ora e delle conoscenze su processi analoghi avvenuti in pressoché ogni civiltà antica, in realtà, possiamo sbilanciarsi ad azzardare un “probabilmente”, non sussistendo prove contrarie allo sviluppo, in Grecia, di un iter differente da quello seguito in tutto il Medio Oriente e, anzi sussistendo alcuni indizi di un processo comune di “mascolinizzazione” tardiva del potere religioso rispetto ad un nucleo archetipico di femminino sacro generativo.
[1] A.B. Lloyd, What is a God?: Studies in the Nature of Greek Divinity, Classical Press of Wales 2009, pp.36 ss.
[2] M. Rigoglioso, Virgin Mother Goddesses of Antiquity, Palgrave Macmillan 2010, pp. 15-18
[3] Ivi, pp.21-22
[4] C.P. Christ, Rebirth of the Goddess: Finding Meaning in Feminist Spirituality, Routledge 1998, passim
[5] M. Rigoglioso, The Cult of Divine Birth in Ancient Greece, Palgrave Macmillan 2009, pp. 51 ss.
[6] B.C. Dietrich, The Origins of Greek Religion, Walter De Gruyter Inc. 1974, pp.74-83
[7] AA.VV., Archaeological Sources on Greek Mythology: Mopsus, Potnia Theron, Milawata letter, Manapa-Tarhunta letter, Tawagalawa letter, Alaksandu, Books LLC 1996, passim
![Palla Otto [8]](./images/smilies/UF/icon_smile_8ball.gif) G. Zorzos, Knossos And Pylos Linear B, CreateSpace 2010, pp. 41 ss.
G. Zorzos, Knossos And Pylos Linear B, CreateSpace 2010, pp. 41 ss.
[9] Qui e in seguito cfr. K.D.S. Lapatin, Mysteries Of The Snake Goddess: Art, Desire, And The Forging Of History, Da Capo Press 2003, passim e L. Foubister, Goddess in the Grass: Serpentine Mythology and the Great Goddess, EcceNova Editions 2003, passim
[10] G. Zorzos, Citato, p.94
[11] B. Auset, The Goddess Guide: Exploring the Attributes and Correspondences of the Divine Feminine, Llewellyn Publications 2009, pp. 69 ss.
[align=right]
Fonte: http://www.centrostudilaruna.it/un-cult ... greca.html[/align]
Autore: Lawrence Sudbury
È possibile parlare di “femminino sacro” e di “culto della dea madre” nella cultura greca classica?
A dare uno sguardo al pantheon ellenico si sarebbe immediatamente tentati di rispondere negativamente: pur essendo presenti divinità sia maschili che femminili, queste ultime rivestono sempre ruoli che, dal punto di vista dell’”imperium” sugli esseri umani, sono considerabili subalterni, chiaro rispecchiamento di una società in cui la donna aveva un ruolo da “comprimario”, limitato quasi unicamente alle funzioni di moglie e madre[1].
Se, però, ampliamo il nostro terreno di analisi fino ad includere il periodo arcaico, l’ottica muta radicalmente.
Prima di procedere ad una ricognizione, seppur sommaria, di tale periodo, è, però, necessario effettuare una disamina relativa ai termini definitori che devono muovere il nostro approccio, a partire da una domanda fondamentale: che cosa si intende quando si identifica una divinità femminile come dea madre? Significa che le si attribuisce il compito di nutrire e proteggere i giovani? Che la si vede come dea del parto? Che è una dea creatrice o la dea della terra (in genere conosciuto come Terra Madre)? O vuol dire che è la dea della natura e della fertilità? Probabilmente proprio quest’ultima definizione risulta essere la più comune ma il termine “fertilità” è di per sé piuttosto vago e può comportare un certo numero di elementi diversi: fertilità potrebbe significare la terra stessa, per esempio, nel senso di fertilità del terreno, oppure potrebbe essere riferita alla coltivazione dei prodotti agricoli o alla vita delle piante, ma potrebbe anche significare la fertilità degli animali, così come degli esseri umani, riferendosi all’accoppiamento o ai rapporti sessuali[2].
Di fatto, tutte queste definizioni sono, allo stesso tempo, adeguate ma parziali nel momento in cui la dea madre può assumere ruoli anche molto diversi, tanto che, solo per fare un esempio, in tutte le mitologie troviamo una notevole confusione tra dea madre e Madre Terra (dea della terra).
In linea generale, l’elemento definitorio di “livello 0#8243;, il minimo comun denominatore che unisce tutti gli attributi della dea madre è dato dal suo essere forza primordiale e sorgente di tutta la vita, sebbene non necessariamente legata alla creazione della vita e al suo nutrimento (ad esempio, in molti casi riscontriamo come caratteristica principale non la generatività ma il mantenimento dell’esistente, in particolare in correlazione ad un determinato gruppo sociale, etnico, tribale o persino ad una determinata gerarchia divina)[3].
Mantenendo una definizione ampia come quella appena espressa, possiamo notare come, in realtà, evidenti reminiscenze di un culto maternale siano ben presenti anche in periodo greco-classico, sebbene con una sorta di “frantumazione” delle caratteristiche ataviche proprie di tale culto e una loro ri-attribuzione a divinità diverse, per molti versi chiaramente depotenziate rispetto all’originale dall’essere portatrici di una sola caratteristica per ciascuna, probabilmente in un tentativo da parte della componente maschile socialmente dominante di attenuare il potere insito nella divinità femminina.
Abbiamo così, ad esempio:
- Gea, a cui vengono attribuite le caratteristiche proprie del culto della madre terra in senso stretto;
- Rea, che riprende l’idea di “mater deorum”, portando la figura maternale ad un livello sacrale primigenio;
- Cibele, che incarna l’aspetto generativo sessuale con il suo rituale d’accoppiamento che rinnova le stagioni della natura;
- Demetra, che riunisce in sé sia le caratteristiche del nutrimento dei mortali (come dea del grano), della cura dei figli e della fertilità naturale[4].
L’elenco potrebbe proseguire, ma ciò che conta è rendersi conto che non siamo di fronte a “doppioni”, divinità con caratteristiche analoghe, quanto, piuttosto, a frammenti rimanenti, eredità frantumate di una concezione teologica precedente, preesistente e fondativa.
Alla ricerca del nucleo mitologemetico primario, dobbiamo, allora, spingerci verso un’epoca antecedente all’invasione dorica, fino a quell’età del bronzo delle civiltà dell’Egeo in cui si sviluppano le basi delle concezioni religiose successive.
Si tratta, tuttavia, di un’impresa ardua: di quel periodo abbiamo solo pochissime fonti, non sviluppate in forma letteraria e, perlopiù, siamo in possesso unicamente di nomi di divinità rinvenuti sulle tavole lineare B di Cnosso e di Pilo, solo pochi dei quali sono sopravvissuti fin al periodo classico, essendo la maggior parte, soprattutto per quanto riguarda le divinità locali, totalmente irriconoscibili per noi oggi.
E’, comunque, estremamente significativa la presenza ripetitiva in molte tavolette in lineare B di Pilo della dicitura MA-TE-RE TE-I-JA, o “Theia Mater”, che, significa proprio “Dea Madre”. Purtroppo, però, possiamo solo immaginare le caratteristiche di questa divinità.
Un aiuto considerevole per la comprensione del pantheon arcaico ci può essere fornito dall’arte tramite i reperti archeologici e, seppur per alcune figure femminili risulti difficile stabilire se raffigurino una dea, una sacerdotessa o una governante femminile, l’enorme presenza di statuette e immagini votive femminili pre-doriche può addirittura far supporre che a Creta la civiltà minoica adorasse prevalentemente o solo dee o, secondo una recente interpretazione, addirittura una sola divinità femminile dal potere illimitato (il lineare B, nel palazzo di Cnosso ha mostrato i nomi di alcune divinità maschili, come Zeus, Poseidone e Ares, ma è emerso che la datazione di questi scritti è certamente posteriore all’invasione micenea, intorno al 1450 a.C.). Si tratta, certamente, solo di speculazioni che tali resteranno fino a che non verrà completamente decifrato il lineare minoico, ma, in ogni caso, gli indizi a riguardo sembrano piuttosto concreti[5].
In particolare, molto interessanti risultano gli studi effettuati sulla “Potnia”, la dea più importante e incontrastata del Mediterraneo nell’età del bronzo, raffigurata in tutta l’area mediorientale ma con particolare frequenza proprio a Creta.
Da quanto possiamo comprendere, PO-TI-NI-JA o “Potnia” risulta essere più un titolo che un nome: il significato sarebbe stato “signora” o “padrona” e, in sostanza, si sarebbe trattato di un esempio classico di “dea madre” a tutto tondo.
Nelle tavolette di Cnosso e Pilo il termine “potnia” è spesso associato ad epiteti diversi, tanto che si è a lungo discusso se tali epiteti indicassero divinità diverse o fossero tutti attributi della stessa dea. In particolare, a Cnosso è stato possibile rinvenire le seguenti specificazioni:
- A-TA-NA PO-TI-NI-JA (Atana Potnia);
- DA-PU-RI-TO-PO-JO-NI-TI (“Signora del Labirinto”);
- (PO-TI-NI-) JA A-SI-WI-JA (Potnia Aswia).
A Pilo, invece, troviamo:
- PO-TI-NI-JA I-QE-JA (Potnia Hikkweia o “Signora dei cavalli);
- PA-KI-JA-NI-JA (forse Potnia Sphagianeia);
-A-SI-WI-JA (ancora Potnia Aswia);
- PO-TI-NI-JA NE-WO-PE-O;
- MA-TE-RE TE-I-JA (la Theia Mater già menzionata, letteralmente “madre divina”, che è la prova più certa di un culto maternale in epoca arcaica).
Infine, in epoca più tarda, sparse in varie località dell’oriente mediterraneo, troviamo iscrizioni riguardanti una PO-TI-NI-JA THE-RON, (Potnia Theron) una “Signora degli animali”, il cui culto si diffuse certamente in periodo miceneo come evidente derivazione di culti precedenti.
Abbiamo la certezza che due di queste divinità (o due di questi attributi di divinità), la Potnia Sphagianeia e la Potnia Newopeo fossero, in realtà, semplicemente rappresentazioni locali della Potnia, essendo “Sphagianeia” e “Newopeo” non aggettivi ma locativi. Per le altre rappresentazioni, però, le nostre sicurezze, allo stato dell’arte, sono molto minori[6].
Due di tali rappresentazioni, comunque, appaiono particolarmente interessanti nel quadro che stiamo delineando: la “Potnia Theron” e la “Atana Potnia”.
La Potnia Theron è la figura che si trova più comunemente (forse anche per il suo sorgere più tardo), sia nell’arte minoica che in quella micenea rispetto a qualsiasi altra Potnia. Era anche conosciuta come “Signora delle cose selvagge”, “Signora delle fiere”, o con molti altri titoli simili.
La Potnia Theron era una dea della natura, soprattutto degli animali selvatici e domestici: era lei a controllare le forze naturali e a sottometterle, a suo piacimento, al volere degli uomini.
Il culto della Signora degli animali non si limitava alla Creta minoica e alla Grecia continentale: divinità simili (o declinazioni della medesima divinità) sono rappresentate nei manufatti artistici di tutto il Vicino Oriente, dalla antica Siria a Babilonia, facendo pensare a influenze culturali derivanti da legami commerciali delle aree orientali più prospere in particolare con Creta.
Soprattutto nelle zone mediorientali, la Signora degli animali è spesso raffigurata nuda, affiancata da entrambi i lati da animali che in in gran parte delle rappresentazioni tiene vicino a sé afferrandoli con entrambe le mani per le orecchie, per la gola o per le zampe posteriori, mentre in altri momenti viene raffigurata in piedi sul dorso di uno di essi: in entrambi i casi il significato simbolico relativo al suo potere di sottomettere le forze più selvagge della natura è chiarissimo.
Ciò che per noi è fondamentale è confrontare queste raffigurazioni con la immagine di Artemide sul “Vaso François” del IV secolo a.C.: su di esso è rappresentata la dea Artemide che tiene un leone e un cervo per la gola e, sebbene Artemide appaia vestita con un abito lungo a differenza sua controparte orientale, è impossibile non vedere una profonda analogia tra il suo ruolo di dea della caccia, dei boschi e degli animali selvatici e quello della Signora degli animali.
Cosa è accaduto tra le due rappresentazioni? Evidentemente un processo di depotenziamento che si esprime nell’annullamento di qualsiasi connotazione sessuale femminile: la nudità (procreatrice) viene coperta, Artemide diventa “vergine” e il suo potere sulla natura diventa predatorio (la caccia) e non rigenerativo (il dominio sulla natura della Potnia). Anche in termini di contestualizzazione si assiste allo stesso processo: la dea cacciatrice Artemide viene normalmente raffigurata con altre donne o ninfe, mentre la Signora degli animali veniva spesso vista in compagnia di una figura maschile, di solito un sovrano mortale o un guerriero, risultando, infatti, patrona dei giovani soldati pronti all’iniziazione sia bellica che amorosa e, come tale, essendo adorata a Sparta, dove era la divinità che presiedeva alla iniziazione dei ragazzi in giovani guerrieri[7].
Un processo analogo di depotenziamento si ha nei confronti della Atana Potnia delle tavolette in lineare B di Cnosso, che, con altissimo grado di probabilità, corrisponde alla Theia Mater di Pilo, venendo a rappresentare in termini molto più evidenti della Potnia Theron la figura classica della “dea madre”: era, infatti, la dea della fertilità di piante e animali (esseri umani compresi) e, forse, in un connubio che risulta particolarmente difficile da spiegare, madre delle montagne (i suoi santuari erano tutti su cime di monti), forse per una visione atavica delle catene montuose come “spina dorsale della terra”.
Come si è accennato, nel periodo classico i suoi attributi vengono frantumati e suddivisi tra Rea, Demetra, Artemide e la Cibele frigia, ma alcuni studiosi ritengono, a partire dalle similitudini nel nome, che l’erede diretta di Atana potesse essere Atena, nel qual caso, tenendo conto della verginità della dea della saggezza, saremmo di nuovo di fronte a una “de-sessualizzazione” della divinità ad opera della società dorica e post-dorica che riflette nella sua riflessione religiosa le componenti maschiliste predominanti di un assetto sociale che pone l’aspetto guerriero al primo posto e che deve, conseguentemente, mettere in ombra qualunque assunto legato al potere generativo femminile
Possiamo ritenere che la Potnia Theron e l’Atana Potnia fossero la stessa divinità declinata in due forme differenti? Ancora una volta è necessario ricordare che non esistono, per mancanza di fonti, prove risolutive in questo senso. Ciò detto, è altresì vero che esiste una possibilità, almeno in via ipotetica, di suffragare l’identità tra le due divinità (peraltro di epoche, come detto, diverse) attraverso la figura della cosiddetta “dea dei serpenti”[9].

Nel 1903 l’archeologo Sir Arthur Evans, scoprì, all’interno di quello che doveva essere probabilmente un tempio nel palazzo di Cnosso, due statuette di donna molto simili tra loro ed entrambi databili attorno al 1700 a.C. In tutti e due i casi la donna aveva in mano serpenti, la qual cosa, essendo particolarmente insolita, ha dato la stura ad una ridda di ipotesi diverse: alcuni hanno suggerito che si tratti semplicemente della raffigurazione di una incantatrice di serpenti, altri hanno pensato ad una sacerdotessa ma la maggior parte degli studiosi sono propensi a credere che i due manufatti siano immagini votive di una divinità.
Le due statuette sono molto simili.
Una figurina mostra una donna in abito insolito con balze sovrapposte e con i seni scoperti, che indossa un cappello con un gatto seduto sulla parte superiore e che in ogni mano tiene un piccolo serpente. Quest’ultimo particolare rimanda immediatamente alla Potnia Theron, ma l’elemento dei seni scoperti è un evidente attributo della Atana Potnia, con il suo chiaro riferimento all’ambito sessuale-generativo e all’allattamento degli esseri viventi. Anche i serpenti risultano simboli della “dea madre”, nella loro associazione alla vita e alla guarigione dai mali, mentre il gatto sul cappello viene perlopiù interpretato come un riferimento all’aldilà.
L’altra statuetta è leggermente più alta e indossa un diverso tipo di abito, ma come nella prima, il seno è scoperto e si ha sul capo un cappello molto alto da cui spunta una testa di serpente il cui corpo si dipana lungo il braccio destro della donna, sulle spalle, lungo un lato della schiena fino alle natiche e poi su l’altro lato della schiena, sulla spalla sinistra e intorno al braccio sinistro, con la coda nella mano sinistra della figura.
Anche in questo caso la simbolicità fallico-generativa e di alimentazione del genere umano è evidente e, anzi, si fa più insistita che nel manufatto precedente, tanto che, se non fosse per quella coda afferrata con la sinistra, come detto richiamo piuttosto lampante alla Potnia Theron, potremmo ritenere il tutto una raffigurazione standardizzata della Atana Potnia.
Ovviamente, ciò che risulta più interessante è l’unione in una sola raffigurazione delle caratteristiche di due divinità che dai testi delle tavolette potrebbero apparire distinte. La domanda che sorge spontanea è se, invece, non dovremmo parlare di una divinità suprema unica e “multiforme”, capace di assumere caratteristiche diverse a seconda dell’interpretazione del concetto di “fertilità” che le si vuole attribuire e che viene specificata, per iscritto, dall’aggettivizzazione del termine “Potnia”.
Ovviamente, si tratta di una domanda che, come detto, attende ancora risposta dalla decifrazione del lineare minoico, ma, indubbiamente, dal punto di vista dell’analisi simbolica, le prove indiziarie che portano a ipotizzare un culto primario e archetipico monoteistico della dea madre sussistono.
A questo punto potremmo chiederci se una “dea dei serpenti” è rinvenibile anche nel pantheon post-dorico. Le ipotesi di derivazione sono state numerose e riguardano molte divinità a cui si è già accennato, da Artemide ad Atena, da Rea a Cibele. In realtà, però, nessuna di esse ha come tratto caratteristico il serpente: per trovare un rettile come tratto simbolico distintivo dobbiamo, piuttosto, rifarci alle poche divinità tardo-cretesi sopravvissute nel periodo classico, quali la dea del parto Eleuthia, la dea della guerra Enyo e, soprattutto, la dea della natura e della caccia Britomartis, che potrebbe essere addirittura una filiazione diretta proprio della dea dei serpenti.
Il nome Britomartis significa “dolce signora” e la dea era, appunto nella mitologia tardo-cretese, figlia di Zeus e di Carme, a sua volta figlia di Eubulo. Nata a Caeno sull’isola di Creta, Britomartis era una delle ninfe cacciatrici compagne di Artemide e, come la sua divinità principale, voleva rimanere vergine. Un giorno, però, narra la leggenda mitologica, Minosse, re di Creta, la vide e si innamorò di lei. Britomartis non voleva avere niente a che fare con il re, soprattutto considerando che egli era suo fratellastro (in quanto figlio di Zeus e Europa): Minosse la inseguì a lungo, senza mai riuscire a catturarla, fino al giorno in cui il re riuscì a chiudere l’amata in una sorta di vicolo cieco, con una scogliera alle spalle. Piuttosto che farsi catturare, però, la ninfa si gettò in mare, dove venne salvata da alcuni pescatori che la raccolsero nelle loro reti. Per la dedizione alla castità dimostrata, Artemide decise di premiarla, donandole l’immortalità e attribuendole il titolo di “Dictynna”, che significa la “Signora delle reti”.
Anche in questo caso (e persino in modo più esplicito di quanto rilevato in precedenza), è evidente il tentativo di depotenziamento simbolico della divinità. In primo luogo, essa viene desessualizzata radicalmente, eliminando il pericolo insito nella potenza generativa dell’”antenata” Atana e, anzi, rendendola una paladina della castità sterile in contrapposizione alla figura maschile di Minosse (che diventa egli stesso simbolo generativo, assumendo su di sé il “potere” che da ciò deriva). In secondo luogo, si amplificano gli attributi della Theron signora degli animali, fino a nascondere completamente le caratteristiche della Atana che, ipoteticamente, potevano compenetrarsi con tali attributi in una divinità unica (c’è anche chi sostiene, seppur senza prove concrete, che tale divinità sia ricordata in un paio di tavolette in lineare con l’aggettivo PI-PI-TU-NA[10]). In terzo luogo, si sminuisce persino la forza intrinseca della divinità, rendendola un alterego subalterno di Artemide, della quale possiede le medesime caratteristiche al punto tale da ingenerare confusione tra le due divinità (tanto che si arrivò a costruire santuari di “Artemide Diktynna” a Chania e Cherson).
Restano, però, pur dopo questo lavorio simbolico culturale, tracce evidenti della derivazione primigenia: non solo la simbolicità delle numerose rappresentazioni di Britomartis in compagnia di uno o più serpenti costituisce un rimando diretto piuttosto ineludibile alla Potnia, ma persino il suo titolo di “Diktynna” è, in realtà, non un collegamento a ipotetiche reti da pesca (l’intera leggenda del salvataggio in mare presenta tratti che fanno percepire un tentativo di costruire spiegazioni del titolo a posteriori, tanto che, in altre versioni, Britomartis diviene signora delle reti da caccia e non da pesca), quanto al Monte Dicte, una montagna cretese dove, guarda caso, spesso venivano tenuti i giochi di Artemide e che, originariamente, ospitava un santuario dedicato proprio alla Atana Potnia[11].
Sono questi elementi che ci permettono di rispondere in forma dubitativa al nostro quesito iniziale: possiamo pensare che alla radice ultima della religione ellenica, poi sviluppata in forma chiaramente maschilista dopo l’invasione dorica, potesse esistere un culto, politeistico o monoteistico, di divinità maternali, dissolto in seguito ad un intenso lavorio culturale di depotenziamento delle caratteristiche generative femminili? Allo stato delle ricerche possiamo rispondere con un “forse”. Ma, alla luce di quanto visto fino ad ora e delle conoscenze su processi analoghi avvenuti in pressoché ogni civiltà antica, in realtà, possiamo sbilanciarsi ad azzardare un “probabilmente”, non sussistendo prove contrarie allo sviluppo, in Grecia, di un iter differente da quello seguito in tutto il Medio Oriente e, anzi sussistendo alcuni indizi di un processo comune di “mascolinizzazione” tardiva del potere religioso rispetto ad un nucleo archetipico di femminino sacro generativo.
[1] A.B. Lloyd, What is a God?: Studies in the Nature of Greek Divinity, Classical Press of Wales 2009, pp.36 ss.
[2] M. Rigoglioso, Virgin Mother Goddesses of Antiquity, Palgrave Macmillan 2010, pp. 15-18
[3] Ivi, pp.21-22
[4] C.P. Christ, Rebirth of the Goddess: Finding Meaning in Feminist Spirituality, Routledge 1998, passim
[5] M. Rigoglioso, The Cult of Divine Birth in Ancient Greece, Palgrave Macmillan 2009, pp. 51 ss.
[6] B.C. Dietrich, The Origins of Greek Religion, Walter De Gruyter Inc. 1974, pp.74-83
[7] AA.VV., Archaeological Sources on Greek Mythology: Mopsus, Potnia Theron, Milawata letter, Manapa-Tarhunta letter, Tawagalawa letter, Alaksandu, Books LLC 1996, passim
[9] Qui e in seguito cfr. K.D.S. Lapatin, Mysteries Of The Snake Goddess: Art, Desire, And The Forging Of History, Da Capo Press 2003, passim e L. Foubister, Goddess in the Grass: Serpentine Mythology and the Great Goddess, EcceNova Editions 2003, passim
[10] G. Zorzos, Citato, p.94
[11] B. Auset, The Goddess Guide: Exploring the Attributes and Correspondences of the Divine Feminine, Llewellyn Publications 2009, pp. 69 ss.
[align=right]
Fonte: http://www.centrostudilaruna.it/un-cult ... greca.html[/align]
Ultima modifica di Hynekeniano il 25/05/2011, 10:06, modificato 1 volta in totale.
25/05/2011, 10:10
Lo sviluppo del femminino sacro in Egitto
Autore: Lawrence Sudbury
Per una donna del mondo antico vivere in Egitto era preferibile rispetto al vivere in qualunque società coeva. Sorprendentemente, le donne in Egitto godevano di uno status sociale più elevato rispetto alle donne provenienti da tutte le altre civiltà più importanti, come quelle di Roma e della Grecia: la società dell’antico Egitto era matrilineare con il lignaggio che veniva tracciato attraverso la donna e, conseguentemente, anche con passaggi di eredità che avvenivano per linea femminile, i diritti femminili erano fortemente rispettati con la possibilità per le donne di partecipare al sistema politico, di amministrare proprietà e di scegliere i propri partner e, in linea generale, il genere femminile era visto come soffuso da un alone mistico, legato alle sue capacità procreative[1]. Persino la prostituzione (forse praticata anche per il suo significato sacro) era una professione rispettata in una società fortemente sessualizzata, che poneva un forte accento sulla fertilità e che riteneva che l’attività sessuale sarebbe proseguita anche nella vita ultraterrena[2].
In queste circostanze, è facile rendersi conto come la mitologia religiosa riflettesse un equilibrio tra maschile e femminile con poche contraddizioni derivanti da repressi conflitti sessuali e di genere e come essa raffigurasse le donne in forma realisticamente sfaccettata, come capaci di nutrire il genera umano e come tali da venerare, ma allo stesso tempo anche come esseri da temere per lo loro capacità di togliere quella stessa vita che creavano: si veniva così a creare, a livello sacrale, un equilibrio uomo-donna inesistente nella maggior parte delle principali religioni odierne, tendenti alla patriarcalità[3].
Conseguentemente, le dee femminili egizie, pur nella tipizzazione stereotipica normale nelle caratterizzazioni mitologemetiche, rappresentano lati di ambivalenza erotico-thanatica molto marcati, come è facilmente visibile anche solo da una rapida scorsa delle principali divinità.
Forse una delle donne più note nella mitologia egizia, era la dea Iside, moglie di Osiride, che, nel corso degli anni, assunse un certo numero di ruoli differenti: nel “Libro dei Morti” Iside era considerata come colei che concedeva la vita e forniva cibo ai morti, dei quali era anche uno dei giudici. Era, inoltre conosciuta come un grande maga, famosa per l’uso delle sue abilità creative. Ma, soprattutto, Iside era ritenuta, a partire dall’inizio della storia d’Egitto fino alla sua fine, come la più grande dea del pantheon egizio: era conosciuta come la dea madre e benefica il cui amore comprendeva ogni creature e che manteneva il legame vitale tra le divinità e l’umanità e come il più puro esempio di moglie e madre amorevole, elemento questo che la rendeva amatissima dal popolo[4]. Madre e sposa, dunque, ma anche donna capace di qualunque azione per raggiungere i suoi scopi (per altro sempre positivi): proprio in questo senso si parlava di figure sfaccettate mai unidirezionali, riflesso di una visione realistica della femminilità.
Un altro esempio in questo senso è fornito dalla dea Ma’at, la dea della legge fisica e morale dell’Egitto e, in generale, dell’ordine e della verità, moglie di Thoth e madre di otto figli che sarebbero divenuti le otto principali divinità di Hermopolis come reggitori della Terra e di tutto quanto è in essa[5]. Ma’at, di base, è colei i cui principi sono stati fissati come capisaldi quando il mondo è stato creato e il caos è stato eliminato: di conseguenza gli Egizi credevano che se il faraone non fosse riuscito a vivere secondo tali principi e a mantenerli vivi, il caos sarebbe tornato in Egitto e nel mondo e tutto ciò che esisteva sarebbe stato distrutto[6]. Ma’at era anche colei che più di ogni altra divinità era incaricata di giudicare i morti: i loro cuori venivano soppesati dalla dea mettendo come contrappeso una piuma e se i cuori bilanciavano la piuma, le anime dei defunti erano libere dal peso del peccato e veniva loro concessa la vita eterna[7]. Infine la dea aveva il ruolo di determinare il corso che la barca del sole avrebbe preso attraverso il cielo ogni giorno, in una ulteriore sottolineatura del ruolo decisionale condiviso tra divinità maschili e femminili![Palla Otto [8]](./images/smilies/UF/icon_smile_8ball.gif) . Anche in questo caso, comunque, troviamo la stessa ambivalenza erotico-thanatica del femminino: Ma’at ordina il creato, ma è anche giudice inflessibile, pronta a scacciare le anime dal “paradiso” se indegne.
. Anche in questo caso, comunque, troviamo la stessa ambivalenza erotico-thanatica del femminino: Ma’at ordina il creato, ma è anche giudice inflessibile, pronta a scacciare le anime dal “paradiso” se indegne.
Un ulteriore rappresentazione di tale ambivalenza è data dalla dea Hator, spesso rappresentata da una mucca dalle lunghe corna, il cui ruolo era quello di sovraintendere all’amore e che, per estensione, era anche nota come divinità della felicità, della danza e della musica e protettrice delle donne. E’ interessante notare come questa divinità giochi un ruolo diverso nell’evolversi della mitologia egiziana: inizialmente era conosciuta come la madre del dio Horus, venendo però poi sostituita da Iside in questa funzione nello sviluppo delle leggende religiose e assumendo, come “rovescio della medaglia”, anche la funzione di “Sekhmet”, la dea creata da Ra per distruggere gli uomini che si erano a lui ribellati, così feroce che anche quando Ra cambiò idea e decise di salvare il genere umano, nessuno riuscì a fermare il suo sterminio fino a che Ra stesso non intervenne tramutando il sangue di cui si nutriva in birra per farla ubriacare. A Dendera, la città in cui il suo culto era particolarmente sentito, però, Hator veniva venerata anche come dea della fertilità e del parto, mentre a Tebe era conosciuta come Dea dei morti e, in periodo tolemaico, venne assimilata ad Afrodite[9].
La disamina della complessità del femminino sacro egizio potrebbe continuare ancora a lungo, dal momento che pressoché ogni divinità presenta le stesse caratteristiche di dualità. Brevemente possiamo, ad esempio, ricordare:
- Meretserger, Dea della Valle dei Re durante il Nuovo Regno, nota per essere insieme pericolosa e misericordiosa, capace di punire i peccatori e i bugiardi con cecità e morsi di serpente e feroce nella sua lotta contro l’iniquità, ma anche protettrice dei lavoratori dei templi;
- Anquet, antichissima dea dell’acqua dal Sudan, assorbita dalla religione egizia come Dea dell’isola di Sahal e della lussuria, con tutto quello che, in termini di piacere e follia, ciò poteva comportare;
- Bastet, conosciuta per il suo ruolo di dea del fuoco, dei gatti, della casa e delle donne in gravidanza, nota per essere docile e gentile nel suo ruolo di protettrice del focolare, ma descritta anche come aggressiva e feroce nei racconti delle battaglie combattute dal faraone;
- Neith, una delle più antiche dee egizie, in origine dea della guerra e in seguito divenuta dea della tessitura;
- Qetesh, divinità di origine semitica, dea della natura, dell’estasi sacra e del piacere sessuale il cui culto divenne molto popolare nel Nuovo Regno, ma che, proprio nel rapimento dell’estasi, era in grado di assumere il ruolo vindice di Hator, alla quale era in alcuni casi assimilata[10].
Tentando di riassumere in macro-categorie i ruoli comuni per le donne nella mitologia egizia, potremmo, pur con una certa dose di generalizzazione, suddividere la figura sacra femminile in tre funzioni principali.
1) La madre
Le donne del pantheon egiziano (e, ancora una volta è il caso di ricordare che esse erano un riflesso del ruolo femminile nella società egiziana) erano definite in primo luogo dalla loro capacità di partorire. Da tale capacità derivava, come corollario, la capacità di sostenere e dare nutrimento e, quindi, di proteggere il popolo. Si tratta, indubbiamente, della caratteristica più amata e adorata dai fedeli ed è probabilmente per questo che Iside, che rappresenta le virtù generative al massimo grado, diventa la dea principale della mitologia egizia, nelle sue caratteristiche di divinità protettrice, in primo luogo del principio maschile che le sta a fianco: quando suo marito, il re Osiride, viene ucciso dal fratello geloso Seth che h intenzione di usurparne il trono, Iside recupera il corpo dello sposo, i cui pezzi erano stati sparsi da Seth per tutto l’Egitto, lo rimette insieme, lo mummifica e, infine, attraverso la pratica mistica, gli ridà vita, facendo di lui il dio degli inferi. Così viene reso il ruolo femminile di “donatrice di vita” a cui segue, nella mistica popolare, il ruolo di madre, che ne risulta ovvia conseguenza e che viene reso dipingendo Iside anche come protettrice del figlio Horus che lei riesce a rendere re per diritto di nascita, favorendone la vendetta contro Seth[11].
2) L’amante / prostituta
Come accennato gli egiziani godevano del sesso apertamente e liberamente: era assolutamente normale per le giovani donne non sposate avere rapporti sessuali e anche la prostituzione era non solo accettata ma anche molto apprezzata, tanto che le prostitute avevano un elevato status sociale e la loro pratica della sessualità era assimilata a qualcosa di addirittura superiore ad un rituale sacro nel momento in cui esse erano in realtà percepite come sacerdotesse che eseguivano riti sessuali sacri nel momento in cui il sesso portava a un concepimento. La prostituzione sacra e generativa era a tal punto venerata che persino Iside venne mitologicamente legata a tale pratica, allorché nel corso degli anni, mentre era la ricerca di parti del corpo sparse del marito morto, essa venne dipinta anche come una prostituta di Tiro[12].
Quello che va notato è che, comunque, la sessualità non viene mai adorata come fine a se stessa, ma sempre come atto passibile di generatività, in una riproposizione del quadro maternale/creativo precedente, in cui, a seguito della sacralità del possibile risultato dell’atto sessuale, si estende l’alone sacrale all’atto stesso, in qualsiasi sua variante.
3) La guerriera
Così come le donne sono descritte come donatrici di vita, vengono anche spesso ritratte come distruttrici di vita. Paradigmatico è il caso citato ai Sekhmet, ma abbiamo visto che una tale caratteristica sia presente in gran parte delle divinità.
Anche in questo caso, però, la visione della donna guerriera è un elemento derivato. Se, infatti, l’ira femminile viene considerata terribile, come specchio di una società in cui le donne hanno piena possibilità espressiva, essa, nella mitologia egiziana, non è mai dovuta a gelosie, ripicche o odi personali, ma a un desiderio di difesa del creato cioè del prodotto della generatività: la dea diviene guerriera implacabile per difendere la sua prole, per difendere l’ordine cosmico, per difendere il padre… Insomma, la dea guerriera è, in fondo, il riflesso della dea generatrice, nel momento in cui conserva ciò a cui ha dato vita e nel momento in cui uccide compiendo, in ultima analisi, un atto di conservazione dell’esistenza stessa, minacciata in qualunque modo[13].
Ecco, allora, che l’intera essenza del femminino sacro egizio può essere in fin dei conti, ricondotta al minimo comun denominatore dell’archetipo della “dea madre”, di cui, in diverse articolazioni, vengono continuamente riproposti gli elementi salienti.
E’ particolarmente significativo che in un universo religioso molto fluido come quello egiziano, con continui atti di sincretismo e assorbimento di divinità straniere, nuove o locali, si assista ad una progressiva ascesa de culto di una divinità Mut, che sembra assommare e delineare in modo più preciso proprio quelle caratteristiche della “dea madre” che, fino al periodo della XVIII Dinastia, erano state distribuite in forma più disseminata tra dee diverse.
Lo sviluppo del culto di Mut è interessante, nella sua evoluzione, proprio in relazione a tale progressiva focalizzazione. Inizialmente “Mut” era un titolo attribuito alle acque primordiali del cosmo, impersonificate nella cosmogonia Ogdoad, durante quello che viene chiamato Antico Regno, tra II e VI Dinastia (databili tra il 2.686 e il 2.134 a.C.), dalla dea Naunet. Tuttavia, la distinzione tra maternità e acqua cosmica viene in seguito resa palese e portata alla statuizione della separazione di queste identità: Mut viene così a guadagnare aspetti di una dea creatrice vista come la madre primordiale da cui è emerso il cosmo.
Non è un caso che i geroglifici del nome Mut e del termine “madre” siano uguali e siano dati da un avvoltoio bianco, che gli Egizi credevano essere una creatura molto materna per la mancanza di evidenti dismorfismi sessuali tra maschi e femmine della stessa specie, tanto da portare a credenze partenogenetiche nei suoi confronti (si credeva che tutti gli avvoltoi concepissero i loro figli dal vento).
Molto più tardi in una serie di miti originari di Tebe, l’idea di generatività assoluta di Mut sembra venire a decadere nel momento in cui si dichiara che, essendo Mut increata e senza genitori ma sorta dal nulla, fosse per lei impossibile avere figli naturali ma fosse costretta a adottarne uno. In realtà, però, non ci troviamo di fronte a una negazione del concetto di “dea madre”, quanto piuttosto ad un suo allargamento: nel momento in cui Mut adotta figli non generati direttamente da lei, diviene madre adottiva universale, genitrice vicaria dell’intera umanità. Nel ciclo tebano inizialmente l’adozione diretta avviene su Menthu, dio della guerra, a simboleggiare il completamento dei principi maternali femminili con quelli guerrieri maschili, ma, in seguito, dal momento che l’Isheru, il lago sacro al di fuori antico tempio di Mut a Karnak, era a forma di una falce di luna, si decise di sostituire Menthu con Khonsu, dio della luna, che, comunque, racchiudeva in sé principi androgeni e lunari (quindi femminili).
Con lo sviluppo della potenza tebana, il culto di Mut finì per assorbire le divinità patrone di Basso e Alto Egitto, Wadjet e Nekhbet e le rispettive raffigurazioni protettrici (in entrambi i casi una leonessa) Bast e Sekhmet: così Mut divenne, prima di tutto, Mut-Wadjet-Bast, poi Mut-Sekhmet-Bast (Wadjet era stata assorbita da Bast), poi, assimilando anche Menhit, un’altra dea leonessa, moglie del figlio adottato, diventò Mut-Sekhmet-Bast-Menhit, e, infine, in un processo di semplificazione, Mut-Nekhbet.
Più tardi, allorché in tutto il Paese si diffuse una religione unificata, in cui le antiche divinità del pantheon venivano identificate come coppie uguali, controparti femminili e maschili con le stesse funzioni, Mut subì ulteriori evoluzioni: quando, nel tardo Medio Regno, Tebe impose il suo patrono, Amon, come divinità principale, Amaunet, che era stata la sua controparte femminile, fu sostituita con una più sostanziale dea-madre, che desse conto della paternità universale di Amon (e del suo rappresentante faraonico) sull’Egitto e Mut divenne sua moglie (adottandone, come visto, il figlio Khonsu, unione dei principi paternali e maternali).
Solo quando l’autorità di Tebe decrebbe e Amon venne inglobato nella nuova divinità Amon Ra, Mut, la madre affettuosa, fu assimilata a Hathor, riprendendo, in un nuovo progressivo processo di semplificazione teologica, caratteristiche di generatività diretta come madre di Horus e, infine, venendo inglobata, dopo la rivoluzione del culto di Aton e in un ulteriore passaggio semplificatorio che portò alla sparizione (tramite sincretismo) di un numero notevole di divinità, nel culto di Iside che si diffuse in tutto il bacino mediterraneo[14].
Con Mut, in ogni caso, vediamo l’apoteosi del culto universale della “dea madre”, presente fin dai primordi della civiltà egizia e mai morto (per quanto assorbito, in fase finale, nella triade divina che rispecchia il senso del nucleo familiare e la perpetuazione dell’esistenza ad esso correlato e in cui Iside assomma tutte le qualità del femminino sacro), fino allo sviluppo del Cristianesimo, che imporrà la sua visione teologica androcentrica di stampo semita.
[1] G. Robins, Women in Ancien Egypt, Harvard University Press 1993, passim
[2] J. Tyldesley, Daughters of Isis: Women of Ancient Egypt, Penguin 1995, pp. 18 ss.
[3] D.B. Redford, The Ancient Gods Speak: A Guide to Egyptian Religion, Oxford University Press 2002, pp. 36 ss.
[4] R.H. Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, Thames & Hudson 2003, pp.103-114
[5] Ivi, p.166
[6] G. Pintch, Egyptian Myth: a Very Short Introduction, Oxford University Press 2004, pp. 43 ss
[7] Ivi, p.46
![Palla Otto [8]](./images/smilies/UF/icon_smile_8ball.gif) R.H. Wilkinson, Citato, pp.112
R.H. Wilkinson, Citato, pp.112
[9] V. Essene, T. Kenyon, The Hathor Material: Messages from an Ascended Civilization, S.E.E. Pub. Co., passim
[10] H. Barker, Egyptian Gods and Goddesses, Grosset & Dunlap 1999, passim
[11] G. Pintch, Citato, pp. 23 ss.
[12] Ivi
[13] G. Hart, Egyptian Myths, University of Texas Press, pp. 81-82
[14] S.H. D’Auria, Servant of Mut: Studies in Honor of Richard A. Fazzini, Brill Academic Pub 2007, passim
[align=right]Fornte: http://www.centrostudilaruna.it/lo-svil ... gitto.html[/align]
Autore: Lawrence Sudbury
Per una donna del mondo antico vivere in Egitto era preferibile rispetto al vivere in qualunque società coeva. Sorprendentemente, le donne in Egitto godevano di uno status sociale più elevato rispetto alle donne provenienti da tutte le altre civiltà più importanti, come quelle di Roma e della Grecia: la società dell’antico Egitto era matrilineare con il lignaggio che veniva tracciato attraverso la donna e, conseguentemente, anche con passaggi di eredità che avvenivano per linea femminile, i diritti femminili erano fortemente rispettati con la possibilità per le donne di partecipare al sistema politico, di amministrare proprietà e di scegliere i propri partner e, in linea generale, il genere femminile era visto come soffuso da un alone mistico, legato alle sue capacità procreative[1]. Persino la prostituzione (forse praticata anche per il suo significato sacro) era una professione rispettata in una società fortemente sessualizzata, che poneva un forte accento sulla fertilità e che riteneva che l’attività sessuale sarebbe proseguita anche nella vita ultraterrena[2].
In queste circostanze, è facile rendersi conto come la mitologia religiosa riflettesse un equilibrio tra maschile e femminile con poche contraddizioni derivanti da repressi conflitti sessuali e di genere e come essa raffigurasse le donne in forma realisticamente sfaccettata, come capaci di nutrire il genera umano e come tali da venerare, ma allo stesso tempo anche come esseri da temere per lo loro capacità di togliere quella stessa vita che creavano: si veniva così a creare, a livello sacrale, un equilibrio uomo-donna inesistente nella maggior parte delle principali religioni odierne, tendenti alla patriarcalità[3].
Conseguentemente, le dee femminili egizie, pur nella tipizzazione stereotipica normale nelle caratterizzazioni mitologemetiche, rappresentano lati di ambivalenza erotico-thanatica molto marcati, come è facilmente visibile anche solo da una rapida scorsa delle principali divinità.
Forse una delle donne più note nella mitologia egizia, era la dea Iside, moglie di Osiride, che, nel corso degli anni, assunse un certo numero di ruoli differenti: nel “Libro dei Morti” Iside era considerata come colei che concedeva la vita e forniva cibo ai morti, dei quali era anche uno dei giudici. Era, inoltre conosciuta come un grande maga, famosa per l’uso delle sue abilità creative. Ma, soprattutto, Iside era ritenuta, a partire dall’inizio della storia d’Egitto fino alla sua fine, come la più grande dea del pantheon egizio: era conosciuta come la dea madre e benefica il cui amore comprendeva ogni creature e che manteneva il legame vitale tra le divinità e l’umanità e come il più puro esempio di moglie e madre amorevole, elemento questo che la rendeva amatissima dal popolo[4]. Madre e sposa, dunque, ma anche donna capace di qualunque azione per raggiungere i suoi scopi (per altro sempre positivi): proprio in questo senso si parlava di figure sfaccettate mai unidirezionali, riflesso di una visione realistica della femminilità.
Un altro esempio in questo senso è fornito dalla dea Ma’at, la dea della legge fisica e morale dell’Egitto e, in generale, dell’ordine e della verità, moglie di Thoth e madre di otto figli che sarebbero divenuti le otto principali divinità di Hermopolis come reggitori della Terra e di tutto quanto è in essa[5]. Ma’at, di base, è colei i cui principi sono stati fissati come capisaldi quando il mondo è stato creato e il caos è stato eliminato: di conseguenza gli Egizi credevano che se il faraone non fosse riuscito a vivere secondo tali principi e a mantenerli vivi, il caos sarebbe tornato in Egitto e nel mondo e tutto ciò che esisteva sarebbe stato distrutto[6]. Ma’at era anche colei che più di ogni altra divinità era incaricata di giudicare i morti: i loro cuori venivano soppesati dalla dea mettendo come contrappeso una piuma e se i cuori bilanciavano la piuma, le anime dei defunti erano libere dal peso del peccato e veniva loro concessa la vita eterna[7]. Infine la dea aveva il ruolo di determinare il corso che la barca del sole avrebbe preso attraverso il cielo ogni giorno, in una ulteriore sottolineatura del ruolo decisionale condiviso tra divinità maschili e femminili
Un ulteriore rappresentazione di tale ambivalenza è data dalla dea Hator, spesso rappresentata da una mucca dalle lunghe corna, il cui ruolo era quello di sovraintendere all’amore e che, per estensione, era anche nota come divinità della felicità, della danza e della musica e protettrice delle donne. E’ interessante notare come questa divinità giochi un ruolo diverso nell’evolversi della mitologia egiziana: inizialmente era conosciuta come la madre del dio Horus, venendo però poi sostituita da Iside in questa funzione nello sviluppo delle leggende religiose e assumendo, come “rovescio della medaglia”, anche la funzione di “Sekhmet”, la dea creata da Ra per distruggere gli uomini che si erano a lui ribellati, così feroce che anche quando Ra cambiò idea e decise di salvare il genere umano, nessuno riuscì a fermare il suo sterminio fino a che Ra stesso non intervenne tramutando il sangue di cui si nutriva in birra per farla ubriacare. A Dendera, la città in cui il suo culto era particolarmente sentito, però, Hator veniva venerata anche come dea della fertilità e del parto, mentre a Tebe era conosciuta come Dea dei morti e, in periodo tolemaico, venne assimilata ad Afrodite[9].
La disamina della complessità del femminino sacro egizio potrebbe continuare ancora a lungo, dal momento che pressoché ogni divinità presenta le stesse caratteristiche di dualità. Brevemente possiamo, ad esempio, ricordare:
- Meretserger, Dea della Valle dei Re durante il Nuovo Regno, nota per essere insieme pericolosa e misericordiosa, capace di punire i peccatori e i bugiardi con cecità e morsi di serpente e feroce nella sua lotta contro l’iniquità, ma anche protettrice dei lavoratori dei templi;
- Anquet, antichissima dea dell’acqua dal Sudan, assorbita dalla religione egizia come Dea dell’isola di Sahal e della lussuria, con tutto quello che, in termini di piacere e follia, ciò poteva comportare;
- Bastet, conosciuta per il suo ruolo di dea del fuoco, dei gatti, della casa e delle donne in gravidanza, nota per essere docile e gentile nel suo ruolo di protettrice del focolare, ma descritta anche come aggressiva e feroce nei racconti delle battaglie combattute dal faraone;
- Neith, una delle più antiche dee egizie, in origine dea della guerra e in seguito divenuta dea della tessitura;
- Qetesh, divinità di origine semitica, dea della natura, dell’estasi sacra e del piacere sessuale il cui culto divenne molto popolare nel Nuovo Regno, ma che, proprio nel rapimento dell’estasi, era in grado di assumere il ruolo vindice di Hator, alla quale era in alcuni casi assimilata[10].
Tentando di riassumere in macro-categorie i ruoli comuni per le donne nella mitologia egizia, potremmo, pur con una certa dose di generalizzazione, suddividere la figura sacra femminile in tre funzioni principali.
1) La madre
Le donne del pantheon egiziano (e, ancora una volta è il caso di ricordare che esse erano un riflesso del ruolo femminile nella società egiziana) erano definite in primo luogo dalla loro capacità di partorire. Da tale capacità derivava, come corollario, la capacità di sostenere e dare nutrimento e, quindi, di proteggere il popolo. Si tratta, indubbiamente, della caratteristica più amata e adorata dai fedeli ed è probabilmente per questo che Iside, che rappresenta le virtù generative al massimo grado, diventa la dea principale della mitologia egizia, nelle sue caratteristiche di divinità protettrice, in primo luogo del principio maschile che le sta a fianco: quando suo marito, il re Osiride, viene ucciso dal fratello geloso Seth che h intenzione di usurparne il trono, Iside recupera il corpo dello sposo, i cui pezzi erano stati sparsi da Seth per tutto l’Egitto, lo rimette insieme, lo mummifica e, infine, attraverso la pratica mistica, gli ridà vita, facendo di lui il dio degli inferi. Così viene reso il ruolo femminile di “donatrice di vita” a cui segue, nella mistica popolare, il ruolo di madre, che ne risulta ovvia conseguenza e che viene reso dipingendo Iside anche come protettrice del figlio Horus che lei riesce a rendere re per diritto di nascita, favorendone la vendetta contro Seth[11].
2) L’amante / prostituta
Come accennato gli egiziani godevano del sesso apertamente e liberamente: era assolutamente normale per le giovani donne non sposate avere rapporti sessuali e anche la prostituzione era non solo accettata ma anche molto apprezzata, tanto che le prostitute avevano un elevato status sociale e la loro pratica della sessualità era assimilata a qualcosa di addirittura superiore ad un rituale sacro nel momento in cui esse erano in realtà percepite come sacerdotesse che eseguivano riti sessuali sacri nel momento in cui il sesso portava a un concepimento. La prostituzione sacra e generativa era a tal punto venerata che persino Iside venne mitologicamente legata a tale pratica, allorché nel corso degli anni, mentre era la ricerca di parti del corpo sparse del marito morto, essa venne dipinta anche come una prostituta di Tiro[12].
Quello che va notato è che, comunque, la sessualità non viene mai adorata come fine a se stessa, ma sempre come atto passibile di generatività, in una riproposizione del quadro maternale/creativo precedente, in cui, a seguito della sacralità del possibile risultato dell’atto sessuale, si estende l’alone sacrale all’atto stesso, in qualsiasi sua variante.
3) La guerriera
Così come le donne sono descritte come donatrici di vita, vengono anche spesso ritratte come distruttrici di vita. Paradigmatico è il caso citato ai Sekhmet, ma abbiamo visto che una tale caratteristica sia presente in gran parte delle divinità.
Anche in questo caso, però, la visione della donna guerriera è un elemento derivato. Se, infatti, l’ira femminile viene considerata terribile, come specchio di una società in cui le donne hanno piena possibilità espressiva, essa, nella mitologia egiziana, non è mai dovuta a gelosie, ripicche o odi personali, ma a un desiderio di difesa del creato cioè del prodotto della generatività: la dea diviene guerriera implacabile per difendere la sua prole, per difendere l’ordine cosmico, per difendere il padre… Insomma, la dea guerriera è, in fondo, il riflesso della dea generatrice, nel momento in cui conserva ciò a cui ha dato vita e nel momento in cui uccide compiendo, in ultima analisi, un atto di conservazione dell’esistenza stessa, minacciata in qualunque modo[13].
Ecco, allora, che l’intera essenza del femminino sacro egizio può essere in fin dei conti, ricondotta al minimo comun denominatore dell’archetipo della “dea madre”, di cui, in diverse articolazioni, vengono continuamente riproposti gli elementi salienti.
E’ particolarmente significativo che in un universo religioso molto fluido come quello egiziano, con continui atti di sincretismo e assorbimento di divinità straniere, nuove o locali, si assista ad una progressiva ascesa de culto di una divinità Mut, che sembra assommare e delineare in modo più preciso proprio quelle caratteristiche della “dea madre” che, fino al periodo della XVIII Dinastia, erano state distribuite in forma più disseminata tra dee diverse.
Lo sviluppo del culto di Mut è interessante, nella sua evoluzione, proprio in relazione a tale progressiva focalizzazione. Inizialmente “Mut” era un titolo attribuito alle acque primordiali del cosmo, impersonificate nella cosmogonia Ogdoad, durante quello che viene chiamato Antico Regno, tra II e VI Dinastia (databili tra il 2.686 e il 2.134 a.C.), dalla dea Naunet. Tuttavia, la distinzione tra maternità e acqua cosmica viene in seguito resa palese e portata alla statuizione della separazione di queste identità: Mut viene così a guadagnare aspetti di una dea creatrice vista come la madre primordiale da cui è emerso il cosmo.
Non è un caso che i geroglifici del nome Mut e del termine “madre” siano uguali e siano dati da un avvoltoio bianco, che gli Egizi credevano essere una creatura molto materna per la mancanza di evidenti dismorfismi sessuali tra maschi e femmine della stessa specie, tanto da portare a credenze partenogenetiche nei suoi confronti (si credeva che tutti gli avvoltoi concepissero i loro figli dal vento).
Molto più tardi in una serie di miti originari di Tebe, l’idea di generatività assoluta di Mut sembra venire a decadere nel momento in cui si dichiara che, essendo Mut increata e senza genitori ma sorta dal nulla, fosse per lei impossibile avere figli naturali ma fosse costretta a adottarne uno. In realtà, però, non ci troviamo di fronte a una negazione del concetto di “dea madre”, quanto piuttosto ad un suo allargamento: nel momento in cui Mut adotta figli non generati direttamente da lei, diviene madre adottiva universale, genitrice vicaria dell’intera umanità. Nel ciclo tebano inizialmente l’adozione diretta avviene su Menthu, dio della guerra, a simboleggiare il completamento dei principi maternali femminili con quelli guerrieri maschili, ma, in seguito, dal momento che l’Isheru, il lago sacro al di fuori antico tempio di Mut a Karnak, era a forma di una falce di luna, si decise di sostituire Menthu con Khonsu, dio della luna, che, comunque, racchiudeva in sé principi androgeni e lunari (quindi femminili).
Con lo sviluppo della potenza tebana, il culto di Mut finì per assorbire le divinità patrone di Basso e Alto Egitto, Wadjet e Nekhbet e le rispettive raffigurazioni protettrici (in entrambi i casi una leonessa) Bast e Sekhmet: così Mut divenne, prima di tutto, Mut-Wadjet-Bast, poi Mut-Sekhmet-Bast (Wadjet era stata assorbita da Bast), poi, assimilando anche Menhit, un’altra dea leonessa, moglie del figlio adottato, diventò Mut-Sekhmet-Bast-Menhit, e, infine, in un processo di semplificazione, Mut-Nekhbet.
Più tardi, allorché in tutto il Paese si diffuse una religione unificata, in cui le antiche divinità del pantheon venivano identificate come coppie uguali, controparti femminili e maschili con le stesse funzioni, Mut subì ulteriori evoluzioni: quando, nel tardo Medio Regno, Tebe impose il suo patrono, Amon, come divinità principale, Amaunet, che era stata la sua controparte femminile, fu sostituita con una più sostanziale dea-madre, che desse conto della paternità universale di Amon (e del suo rappresentante faraonico) sull’Egitto e Mut divenne sua moglie (adottandone, come visto, il figlio Khonsu, unione dei principi paternali e maternali).
Solo quando l’autorità di Tebe decrebbe e Amon venne inglobato nella nuova divinità Amon Ra, Mut, la madre affettuosa, fu assimilata a Hathor, riprendendo, in un nuovo progressivo processo di semplificazione teologica, caratteristiche di generatività diretta come madre di Horus e, infine, venendo inglobata, dopo la rivoluzione del culto di Aton e in un ulteriore passaggio semplificatorio che portò alla sparizione (tramite sincretismo) di un numero notevole di divinità, nel culto di Iside che si diffuse in tutto il bacino mediterraneo[14].
Con Mut, in ogni caso, vediamo l’apoteosi del culto universale della “dea madre”, presente fin dai primordi della civiltà egizia e mai morto (per quanto assorbito, in fase finale, nella triade divina che rispecchia il senso del nucleo familiare e la perpetuazione dell’esistenza ad esso correlato e in cui Iside assomma tutte le qualità del femminino sacro), fino allo sviluppo del Cristianesimo, che imporrà la sua visione teologica androcentrica di stampo semita.
[1] G. Robins, Women in Ancien Egypt, Harvard University Press 1993, passim
[2] J. Tyldesley, Daughters of Isis: Women of Ancient Egypt, Penguin 1995, pp. 18 ss.
[3] D.B. Redford, The Ancient Gods Speak: A Guide to Egyptian Religion, Oxford University Press 2002, pp. 36 ss.
[4] R.H. Wilkinson, The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, Thames & Hudson 2003, pp.103-114
[5] Ivi, p.166
[6] G. Pintch, Egyptian Myth: a Very Short Introduction, Oxford University Press 2004, pp. 43 ss
[7] Ivi, p.46
[9] V. Essene, T. Kenyon, The Hathor Material: Messages from an Ascended Civilization, S.E.E. Pub. Co., passim
[10] H. Barker, Egyptian Gods and Goddesses, Grosset & Dunlap 1999, passim
[11] G. Pintch, Citato, pp. 23 ss.
[12] Ivi
[13] G. Hart, Egyptian Myths, University of Texas Press, pp. 81-82
[14] S.H. D’Auria, Servant of Mut: Studies in Honor of Richard A. Fazzini, Brill Academic Pub 2007, passim
[align=right]Fornte: http://www.centrostudilaruna.it/lo-svil ... gitto.html[/align]