Inserisci Immagine:
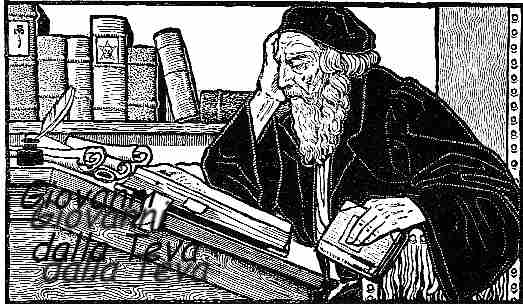 Il nuovo messia di Paolo di Tarso "Gesù Cristo figlio di Dio" (constatato che non ritornava) non deve più ritornare su questa terra, come credevano i suoi primi seguaci, ma sono i suoi seguaci che attraverso la morte vanno da lui con la risurrezione. Il cristianesimo fu l'incontro della cultura Ebrea/Essena e parte della filosofia Greca elaborata in Egitto con un contributo speciale di Filone Alessandrino, applicata ad un'epopea Asmonea tardiva e distolta. Il nuovo messia di Paolo di Tarso "Gesù Cristo figlio di Dio" (constatato che non ritornava) non deve più ritornare su questa terra, come credevano i suoi primi seguaci, ma sono i suoi seguaci che attraverso la morte vanno da lui con la risurrezione. Il cristianesimo fu l'incontro della cultura Ebrea/Essena e parte della filosofia Greca elaborata in Egitto con un contributo speciale di Filone Alessandrino, applicata ad un'epopea Asmonea tardiva e distolta.
Il cristianesimo venne quando Ebrei, Greci e Romani avevano persa la libertà e la felicità, e la speranza di riacquistarle nel mondo presente: esso venne quando la gioia del vivere, propria dell'antichità primitiva, che ebbe il suo apogeo in Grecia, fu distrutta dalla riflessione e dalla pratica dolorosa della vita, facendo luogo alla noia del vivere, alle disillusioni recate dalle continue sciagure, a quel dolore universale delle cose che rendeva l'esistenza inesplicabile e intollerabile, e forse soprattutto, perché con la coltura era cresciuto anche il sentimento della intollerabilità dei mali che affliggevano gli uomini ed i popoli.
"Se non che — per servirci delle parole di Gaetano Negri,(Gaetano Negri, La Crisi Religiosa, p. 37-38. Milano, Dumolard, 1878.) l'impareggiabile filosofo artista — non potendo l'uomo rinunziare alla felicità, egli non ha che un modo di uscire dalla sua miseranda condizione, ed è quello di trasportarla, la sua felicità, dalla vita terrena a una vita trascendentale; ammettere la sciagura nel mondo presente; ma distruggerla, direi quasi, con la speranza della felicità nel mondo futuro. Fu questa precisamente la dottrina del cristianesimo"
La scienza sperimentale non era ancor nata, e l'umanità sofferente non aveva allora altro rimedio contro i mali di questa vita, fuori che le speranze d'oltre tomba.
Fu dunque, il cristianesimo, una dottrina nata dalla decadenza, e fu, conseguentemente, la religione della decadenza.
La sorte del popolo ebreo, continuamente sbattuto fra una dominazione e l'altra, e deluso alfine nelle sue speranze di un ritorno dei tempi felici e della gloria, aveva di lunga mano preparato quella letteratura del dolore, che doveva consolare gli umili e gli afflitti, la famosa fonte "Quelle" dei vangeli, e servire di leva potente per la formazione e la diffusione di quello che fu poi chiamato il cristianesimo.
Parimente in Grecia e a Roma alla nascita di questa filosofia del dolore, della rassegnazione e del distacco dalla vita presente avevano presieduto le più gravi sciagure pubbliche. Platone — il primo Padre precristiano della Chiesa — scriveva appunto quando i destini di Atene andavano visibilmente declinando. Le rovine morali della patria non fecero che dare maggior incremento alla filosofia di Platone, a quel misticismo che, distaccandosi dalla vita reale perché troppo brutta, senza libertà e senza giustizia, si racchiude in se stesso come in un ultimo luogo di rifugio.
Incamminata per questa via, la filosofia greca arrivava da una parte ad Egesia, che consigliava la morte volontaria come il mezzo più spedito per raggiungere il riposo dell'anima, la pace senza inquietudini, l'atarassia; e dall'altra al libro sul Lutto, dell'accademico Crantore, modello delle Consolazioni.
Né diversamente volgevano le cose in Roma nel secolo anteriore all'avvento del cristianesimo. Questo secolo che, dopo di aver ridotto tanti popoli sotto l'impero di Roma, ridusse Roma stessa sotto l'impero di uno solo, si aprì sotto gli auspici di una lunga guerra dei Cimbri e dei Teutoni; vide tutti i popoli d'Italia sollevarsi contro Roma; assisté alle guerre tra Mario e Silla; ammirò Spartaco che alla testa degli schiavi fece tremare i padroni; fu spaventato da una organizzazione generale e terribile dei pirati; in Africa, in Spagna, in Germania, nella Gallia, in Bretagna vide scene di ferocia e guerre; la guerra di Mitridate e dei Parti in Oriente; le fazioni di Pompeo, di Cesare, di Bruto, di Antonio e di Augusto che divisero e tennero in armi tutto il mondo dominato da Roma. Si è allora che nasce un vero disgusto della vita, non sperandosi più niente dalla libertà né dalla legge: il suicidio diventa uno scampo; e la morte viene oramai considerata non più come la fine, ma come il fine della vita; è la filosofia della desolazione che inspira le Tusculane di Cicerone. E come l'arte segna il termometro morale del tempo, così in Orazio noi vediamo allora anche l'arte diventare pessimista fin quasi all'ascetismo. Se questa era già la disposizione degli spiriti prima di Augusto, quale doveva diventare poi sotto gli imperatori successivi, sotto Tiberio e Nerone? Da quell'ambiente non potevano venir fuori che anime cristiane come Seneca: ecco perché è in quell'epoca che a Roma comincia ad apparire, misterioso, il nome cristiano, e col nome la cosa.
La filosofia si tramuta in religione e diventa la religione del soffrire e del morire in questa vita per guadagnare il paradiso nell'altra.
Giudicate se in quel ambiente non dovessero attecchire e prendere forma concreta le speranze messianiche degli primi cristiani, annuncianti la prossima fine del mondo e la risurrezione e la rinascita dopo la morte!
La povera gente, abbandonata a sé, o nell'impossibilità di istruirsi, era completamente in balìa dei culti, vecchi del paese, o di nuova importazione.
Celso Intorno al 180 questo filosofo già più volte citato, il primo grande avversario del Cristianesimo, pose acutamente in dubbio l'attendibilità storica delle scritture cristiane.
Celso non era certo uno sprovveduto: dotato di una formazione culturale criticamente fondata e polivalente, come afferma il suo miglior conoscitore moderno, condusse la propria battaglia contro il Cristianesimo a un livello non attinto da altri critici del Cristianesimo quali Epitteto, Marc'Aurefio, Luciano e lo stesso Porfirio
"Celso non mancava di sottolineare come i Cristiani provenissero dai ceti sociali più ignoranti e, perciò più facilmente attratti dai miracoli, come la loro dottrina, "elementare e destituita di qualsiasi fondamento scientifico", avesse conquistato soprattutto la "gente più semplice". In tal modo avevano adescato le persone più credulone, raccontando loro "cose grandiose" e spiegandogli che "non occorreva rispettare il padre o i maestri, bastava, piuttosto, credere in coloro che predicavano la religione cristiana. Mentre i primi, infatti, facevano unicamente discorsi stupidi e insensati... solo i Cristiani sapevano come fosse giusto vivere, e se i giovani li avessero seguiti, avrebbero conquistato la beatitudine... Così, dunque, parlavano. Se si accorgevano, tuttavia, che un maestro, o un padre o, semplicemente un uomo dotato di buon senso, era nelle vicinanze, i più accorti si allontanavano rapidamente; i più sfacciati, invece, facevano capire ai giovani che, in presenza del padre o del maestro, non avrebbero potuto parlare liberamente; li istigavano, dunque, alla disobbedienza, dicendo loro che, continuando a vivere con gente inetta e traviata, sarebbero finiti per cadere nella rovina più profonda. Pertanto, se non volevano incorrere nel castigo, dovevano abbandonare il padre e i maestri...".
Nella disaggregazione politica e nello sconforto della perduta libertà per alcuni Esseni, quando né leggi, né potere né costumi più bastavano a rinfrancare la fede smarrita, questi ultimi l'umanità più sfortunata, si gettava a capo fitto nei sogni del soprannaturale, come per aggrapparsi ad un'ultima ancora di salvezza.
L'universale impotenza sentiva il bisogno di un giogo nell'ordine spirituale come nell'ordine temporale, la ragione non era abbastanza matura per reggersi da sé nella libertà del pensiero.
La religione cristiana /essena veniva quindi a dare una destinazione a questa credenza, eppertanto essa doveva tornare la più accetta a quell'ambiente esaltato, come quell'ambiente era il più disposto perché essa potesse attecchire e spandersi rapidamente, come una macchia d'olio su d'una superficie piana.
Ma ciò che più doveva contribuire alla fortuna del cristianesimo era la tendenza eminentemente popolare del giudaismo, tendenza che tanto nella letteratura quanto nelle figure ideali dei suoi personaggi era siffattamente suggestiva per gli umili, gli oppressi ed i piccoli da convertirli in massa alla nuova fede.
È questo elemento, venuto al cristianesimo dal giudaismo, che spiega come e perché quella medesima morale e quella medesima dottrina che la filosofia greco-romana già professava da secoli in modo tanto sublime e per forma letteraria e per virtù di esempi, non divennero popolari, non si generalizzarono che per il canale della nuova religione.
Solo che, con la religione cristiana quella filosofia, in luogo di una redenzione, fu una illusione peggiore del male, fu una decadenza che ritardò la redenzione che prometteva di tanto ancora quanto sarebbe durato il cristianesimo,[size=175] perché la collocò nell'al di là, nella vita futura, predicando, in questa vita, la rassegnazione e la miseria come di diritto divino, e come un mezzo meritorio agli uni per esercitare la carità, agli altri per dar modo ai primi di esercitarla e rendersi degni del regno dei cieli.Sotto questo aspetto, morboso fu anzi il trionfo del cristianesimo, poiché prometteva la felicità con la sola speranza, usando la fede. Non c'e gioia migliore, che aspettare un evento piacevole, lo abbiamo sperimentato tutti.[/size] Bossi Emilio Nato il 31.12.1870 Bruzella,27.11.1920 Lugano, libero pensatore e affiliato alla massoneria, di Bruzella. Figlio di Francesco, architetto. #8734; Emilia Contestabile. Studiò al liceo di Lugano e conseguì la laurea in diritto a Ginevra. Avvocato e giornalista, ottenne grande notorietà come polemista con lo pseudonimo di Milesbo.
|
|
|
|





